Speciale
Il primo maggio del Covid / Gli aggettivi del lavoro
Alla vigilia del primo maggio il servizio pubblico ha portato in tv il giovane Marx che legge e recita Ricardo: “Il valore reale di una cosa per colui che l’ha acquistata e per chi vuole venderla o scambiarla con qualcos’altro è la fatica e la sofferenza che può risparmiare a se stesso e che può imporre ad altre persone. Il lavoro è stato quindi il primo prezzo, l’originale moneta d’acquisto pagata per ogni cosa”. (Il film di Raoul Peck, andato in onda su Rai Tre, era uscito nel 2017 in occasione de bicentenario della nascita di Karl Marx: qui la recensione di Pietro Bianchi. La citazione è dai Principles of political economy and taxation di David Ricardo, uno dei fondamenti dell’economia classica).
Nello stesso giorno, l’Istat aveva diffuso i primi dati ufficiali sul lavoro nella pandemia. Meno 94mila occupati, più 301mila inattivi se si confronta il primo trimestre di quest’anno con lo stesso periodo dell’anno prima. Se i numeri italiani a prima vista non paiono catastrofici come quelli americani, è perché abbiamo un diverso sistema di protezione sociale e del lavoro; perché i cassintegrati non sono contati tra i disoccupati; perché lo choc di marzo è “annacquato” nel dato trimestrale; e per vari altri motivi. Ma si può dire, alla prima impressione, che la festa del lavoro del 2020 è all’insegna dell’inattività: che statisticamente fotografa la moltitudine che il lavoro non ce l’ha e non lo cerca.
“Inattivo” è un aggettivo che contiene una negazione, come i lunghi elenchi dei dpcm che scandiscono la nostra vita dai primi di marzo del 2020 e che ci dicono cosa non dobbiamo fare per preservare la salute pubblica. Da allora il lavoro – misura del valore di ogni cosa, secondo Ricardo-Marx – è stato chiuso, negato, allontanato dalla sua sede, cambiato, esaltato, digitalizzato, contingentato, evocato. Proprio mentre si è smaterializzato, per molti, ed è sparito, per troppi, è tornato al centro; sempre accompagnato da aggettivi che lo qualificano. E forse gli aggettivi qualificativi del lavoro nella pandemia sono più utili, per capire dove si andrà, delle previsioni quantitative sul lavoro che ci mancherà nella prima recessione della storia indotta da misure di salute pubblica.
Il primo a tornare al centro è stato il lavoro manuale. Che, il più delle volte, non si può svolgere a distanza. Fino a due mesi fa ci stavamo interrogando sulla quantità di lavori umani che saranno cancellati dall’intelligenza artificiale; improvvisamente ci siamo trovati a fare il conto di quanti lavori si possono fare senza metterci le mani, il contatto fisico con l’oggetto che si produce e/o con le altre persone. E il mondo si è diviso in due: chi può lavorare a distanza, e chi no. Come per il catalogo delle attività produttive, la statistica soccorre fino a un certo punto. Una ricognizione della “classifica delle professioni” dell’Istat, che abbiamo fatto con l’aiuto della Fondazione Di Vittorio, dà qualche indizio. Tra i dipendenti, gli “operai specializzati ed agricoltori” sono 2 milioni e 139mila, poi ci sono 1 milione 722 mila fra conduttori di impianti, operari di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli. A queste cifre si aggiungono 2 milioni 293 mila dipendenti nelle professioni non qualificate. Ma si potrebbe dire: non tutti gli operai, qualificati o meno, devono per forza “metterci le mani”.
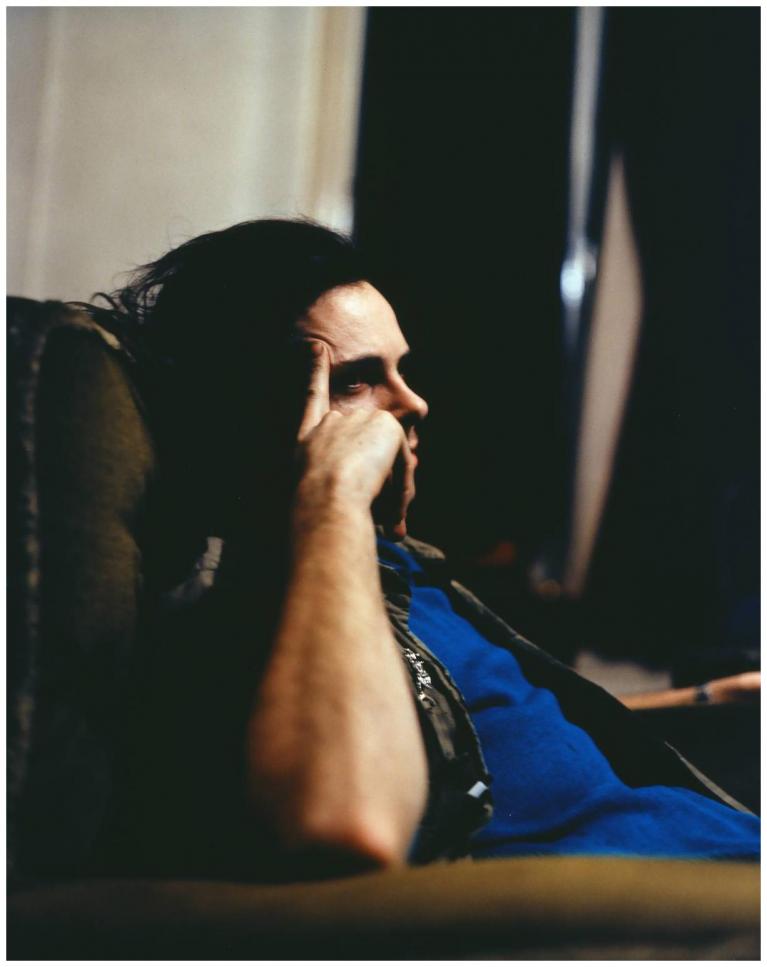
Paul Graham, Television Portrait.
Scorrendo le sotto-voci, i cui dettagli evocano mestieri nuovi e altri rimasti lì per inerzia (ci sono anche i “conduttori di veicoli a motore a trazione animale”, per dire), si intuisce però che la grande maggioranza di quei lavori operai, specializzati o meno, richiedono di “metterci le mani”; e si può arrivare a stimare il numero totale dei lavoratori dipendenti che, in termini generali, si possono considerare impegnati in attività manuali è tra 5,5 e 6 milioni. A questi vanno aggiunti gli eroi di questi giorni, dall’Istat qualificati come “professioni intellettuali” ma che devono stare a portata di mano (e di contagio): i medici (168 mila lavoratori dipendenti e 140 mila autonomi), i tecnici della salute (632 mila lavoratori dipendenti e 122 mila autonomi). E ancora: i tecnici della sicurezza e protezione ambientale (58 mila dipendenti più 16 mila autonomi), i profili qualificati nei servizi sociali e sanitari (256 mila, quasi tutti dipendenti), solo per citare le categorie più numerose.
In totale, si superano i 7 milioni di persone: lavoratori e lavoratrici che non si possono tenere a distanza, nonostante il grande balzo della digitalizzazione (secondo il capo di Microsoft Satya Nadella abbiamo avuto in due mesi la trasformazione che in tempi normali avremmo avuto in due anni). Tra questi, la decisione sul farli lavorare o meno è affidata a un altro aggettivo: essenziale. La lista delle produzioni essenziali è stata fatta, contestata, interpretata, aggirata con autocertificazione e comunicazione prefettizia. Ma al di là della portata burocratica, legale, statistica, quell’aggettivo – essenziale – è andato ben oltre il destino delle persone addette alle produzioni vitali, per interrogare tutti gli altri, anche gli addetti ai lavori intellettuali che si possono convertire alla modalità “smart”. E molti di noi si sono chiesti: quanto è “essenziale” il mio lavoro?
Passando dai numeri all’aneddotica, voglio qui raccontare una esperienza vissuta il 25 aprile. Tra i tanti effetti del lockdown, ci è stata l’improvvisa conoscenza di vicini di casa che per anni si erano ignorati nella fretta dei contatti quotidiani, del saluto in ascensore con la testa già proiettata sui luoghi di lavoro dove si stava, all’epoca, andando. Non sapevo, per esempio, che nel mio condominio viveva una coppia di cantanti, tenore e soprano. Il 25 aprile, dopo Bella ciao, ci hanno regalato un mini-concerto dalla finestra. Nel giardino condominiale, il pubblico abbastanza ben distanziato e commosso li ha ringraziati. Lei è scesa, ha detto: siamo noi che ringraziamo voi, ci avete fatto cantare. Siamo fermi da un mese e mezzo e per noi è un problema non allenare la voce. Alla domanda: ma perché non potete andare a provare uno per volta nelle sale dell'accademia?, la soprano ha risposto di getto: non possiamo, non è considerato un lavoro… Poi ha aggiunto: non è un lavoro essenziale.
Era evidente, in quel momento, che per la dozzina delle persone presenti quei pochi minuti di bellezza erano stati essenziali, un vero sollievo in tempi drammatici. E che quei due lavoratori-artisti lo hanno percepito, pur accettando con disciplina la limitazione da lockdown che ha circoscritto l’essenziale nella definizione dei lavori che salvano vite, che ci permettono di non morire, di mangiare, di avere i beni di prima necessità. Abbiamo scoperto, in questa circostanza, che di molti dei lavori super-pagati possiamo fare a meno, mentre spesso i lavori essenziali sono quelli che paghiamo di meno: il cui valore ci risparmia non solo la fatica, ma anche il rischio. È il caso dei fattorini e dei magazzinieri di Amazon e di tutta la gig-economy, mani e gambe di quelle infrastrutture sociali che sono diventata le grandi piattaforme digitali. Molto è destinato a cambiare, nella soggettività (sono partiti gli scioperi, forse saliranno un po’ i salari) e nella percezione del valore di quei lavori. E anche di tutti gli altri, che essenziali – nel senso di salva-vita – non sono, ma che ci consentono di vivere e non solo sopravvivere.
Molti di questi possono, in teoria, svolgersi a distanza e sempre più e sempre meglio lo faranno. Forse interrogandoci su cosa è davvero essenziale continueremo a fare almeno una parte delle riunioni e degli eventi pubblici sul web, risparmiando tempo e soldi. Ma c’è un ultimo aggettivo del lavoro in questo primo maggio 2020: individuale. Quasi tutti i lavori che si possono svolgere da remoto sono fatti da una persona, sola. A volte in connessione con altri, a volte no. Con il lavoro a distanza, è rimasta la parte “produttiva”, funzionale di quella connessione – le procedure, gli accordi, le regole, i file condivisi, i rendiconti, la consegna –, mentre è sparita, o si è molto ridotta, quella informale, sociale, relazionale. È come se l’atomizzazione della condizione del lavoro con la quale si è chiuso il Novecento fosse diventata improvvisamente plastica, visibile, concreta. Ciascuno davanti al suo schermo, a produrre la sua parte di utile. Il segretario della Cgil Landini ha detto in un’intervista a Repubblica che occorrerà fare un contratto anche per il lavoro da casa, cogliendo un problema enorme che si apre. Ma allo stesso tempo occorrerà riflettere, e non solo da un punto di vista sindacale, sui pericoli di un futuro di lavoratori-monadi smart, puliti, non inquinanti, anche meno stressati da pendolarismo e tempi morti, ma che toglie al lavoro la sua dimensione fisica di socialità.









