
Speciale
Cucina a vista e passioni tristi
Della nascita dei ristoranti sappiamo tutto? Sì e no. Il ristorante è un’istituzione moderna che nasce a Parigi nella seconda metà del Settecento e si diffonde un po’ dovunque, in modo esponenziale, dopo la Rivoluzione dell’‘89. Ma il suo luogo fisico e la sua stessa forma architettonica derivano da un discorso sociale più ampio: quello della gastronomia, un insieme di scritti e di pratiche che Parigi, dopo averlo ben assestato e attestato, distribuisce per il mondo. Gastronomia è insieme affinamento del gusto, diffusione dell’expertise circa cibo e bevande, valorizzazione del piacere edonistico nei riguardi dell’alimentazione, espansione dell’abitudine del mangiar fuori senza necessità, propagarsi del desiderio di convivialità, nascita della critica del gusto come genere testuale specifico, costituizione di una specie di frame molto preciso circa quel che accade nell’ambiente dove viene offerto del buon cibo (accoglienza da parte del maître, sistemazione al tavolo, distribuzione dei menu, arrivo del cameriere, ordinazione… fino al pagamento del conto, all’elargizione del pourboire e così via).
Più a monte, il ristorante nasce soprattutto grazie all’affermarsi politico di una nuova classe sociale, la borghesia mercantile e industriale, che prende il potere nel corso della Rivoluzione, e che ha abitudini, valori ed esigenze molto diversi da quelli dell’Ancien régime. Così, mentre i borghesi rivoluzionari stanno nelle strade e nelle piazze a parlar di politica, diffondendo la famigerata Opinione pubblica, i cuochi più o meno raffinati delle grandi famiglie aristocratiche restano senza lavoro. Ai loro padroni è stata tagliata la testa, o i più fortunati dei nobili sono riusciti a emigrare. Che fare? L’unica è usare la propria competenza culinaria altrove, in città, dando da mangiare – e bene – ai Robespierre, ai Marat e soci che, dal canto loro, tra una discussione accesa e una votazione per acclamazione, hanno bisogno e voglia di un luogo dove ristorarsi. Il ristorante (nome di un brodo, sembra, prima ancora che di un luogo) è la sintesi spaziale di tutto ciò: un sito nuovo che nasce perché se ne sente la necessità o che – ma è lo stesso – genera un bisogno che da tempo sembra essere nell’aria. Il ristorante è una forma testuale nuova che rinvigorisce il discorso sociale gastronomico.
Quel che sancisce tutto ciò, materializzandolo, è un atto edilizio: l’edificazione di un muro che separa, fortemente e a lungo, la cucina e la sala, creando due diversi spazi adibiti a usi opposti (cucinare vs mangiare) e con valori simbolici nuovi (spazio privato dei fuochi vs spazio pubblico dei tavoli), e con alcuni precisi attori che fanno la spola fra di essi: il maître (che è il portavoce ufficiale del locale, incaricato di diffonderne spirito e valori) e i camerieri, privi di parola, e per questo adusi a ben tenere occultato ai commensali affamati – nonché desiderosi di nuovi sapori e nuove idee da percepire nel piatto – quel che accade in cucina. Chi resta perennemente dietro il muro delle cucine è il cuoco, lo chef di brigata, affatto invisibile ai commensali, generando così una sorta di segreto (come sempre foriero di curiosità e rumors) nei suoi confronti. L’artefice principale di questa complessa operazione politica non ha volto, fisionomia, figura. Di lui non si sa nulla.

Nei luoghi di ristorazione sino a poco prima diffusi nel mondo – taverne, locande, osterie, stazioni di posta, tables d’hôte etc. – questa separazione non c’era: si cucinava nello stesso ambiente dove si mangiava, spesso tutti insieme, accomodati in lunghe tavolate. Chi preparava il cibo, buone o cattive che fossero le sue pietanze, era ben visibile a chi stava lì seduto a mangiare, e viceversa. Viene da chiedersi: perché l’edificazione di quel muro? e per quale ragione i cuochi, questi personaggi così valenti, alcuni dei quali anche illustri, stanno rintanati nelle loro cucine e non osano mai venir fuori, delegando appunto al maître la parola e la relativa accoglienza degli ospiti, dunque la propagazione dei propri valori gastronomici? Forse, ma è una vaga ipotesi, il muro serviva a tenere in ombra delle persone che, sino a poco tempo prima, avevano avuto a che fare con le famiglie nobili, anzi sostanzialmente ne facevano parte. Persone che avevano a dir poco timore di fare la stessa fine dei loro padroni, dunque si guardavano bene dal mostrarsi in pubblico, di rivelarsi ai loro commensali più abituali, ossia proprio a quelli che avevano tagliato la testa a principi e marchesi, conti e baroni: ossia ai loro commensali precedenti, capaci di apprezzare al meglio i loro deliziosi manicaretti. Il muro ha dunque in origine un valore politico, che poi genererà, perdendo tale valore, il format dei ristoranti di tutto il mondo quanto meno per un paio di secoli, creando altresì tutte le mitologie intorno agli chef che hanno, è il caso di dire, nutrito il discorso gastronomico più diffuso.
Prova ne sia che quando, come negli ultimi decenni, si è voluto innovare il format del ristorante con soluzioni architettoniche alternative, la prima e più ovvia operazione portata avanti è stata proprio quella dell’abbattere, fisicamente o simbolicamente, il muro separatore. Il cuoco ha iniziato a mostrarsi in sala, a chiacchierare con i commensali (i quali hanno cominciato a adorarlo), mandando in pensione il maître, donando la parola ai camerieri (che raccontano i piatti prima di servirli) e, soprattutto, offrendo il suo stesso corpo come emblema, come logo del suo locale. Al punto che è adesso impossibile andare a cena in un ristorante – stellato o meno – e non scambiare due parole con lo chef: parlare con lui è un’aspettativa essenziale del cliente, che paga salato il conto anche per questo. Oggi, si sa, il cuoco è un brand. Parallelamente, si è iniziato a aprire una serie di varchi nel muro: ora inserendo fisicamente apposite finestre fra sala e cucina, ora predisponendo telecamere fra i fornelli e schermi in sala per assistere dal vivo alle preparazioni, ora spostando in cucina il tavolo dell’ospite di riguardo, ora direttamente ricreando un solo ambiente con fuochi da un lato e tavoli dall’altro. Il ritorno all’osteria, la moda della trattoria alla buona, fa parte di questo generale movimento di abbattimento sistematico del muro e dei suoi vari significati.
Da qui l’attuale moda della cucina a vista, imperativo categorico nell’architettura dei luoghi di ristorazione d’ogni tipo, dai tristellati alle mense aziendali, dalle trattorie di quartiere ai refettori per bisognosi e senzatetto. Adesso tutti possono, anzi debbono, stare a osservare il lavoro della brigata, la divisione dei compiti, le sottili arti della cucina e dell’allestimento dei piatti, la manualità consapevole. Si è pure istituita una gerarchia fra i tavoli in sala a seconda della vicinanza o distanza dalle cucine. È il principio – assai ambiguo, lo si sa – della trasparenza, secondo cui tutto deve esser visto e, ribaltando il punto di osservazione, mostrato: garanzia di igiene, serietà, professionalità, buone pratiche. In poche parole: pornografia mal dissimulata.
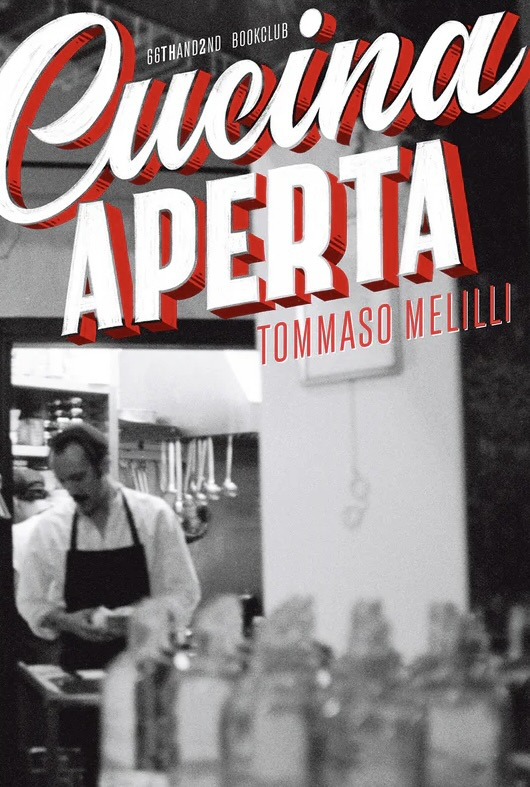
C’è allora da chiedersi che cosa pensino i cuochi di tutto questo processo etico ed estetico, sociale e architettonico. Certo, i più fortunati e capaci di loro hanno fatto il passo successivo: quello d’andare in televisione, luogo della massima esposizione in pubblico, generando la cosiddetta gastromania. Tutti gli altri son rimasti là, in cucina, a farsi osservare, come in uno zoo o in un circo, dai commensali curiosi e sopraccigliati. Tommaso Melilli, cuoco e scrittore (si veda il bellissimo I conti con l’oste, Einaudi 2020), mette a fuoco proprio costoro, i cuochi-cuochi che sono ormai oggetto di quotidiano voyeurismo da parte degli avventori, affamati di immagini più che di cibo. E lo fa in un libro recente intitolato non a caso Cucina aperta (66thand2nd, pp. 152, € 15), dove mette bene a fuoco il punto di vista – in senso letterale – di chi lavora fra i fornelli in una cucina a vista: “lavorare in una cucina aperta è per certi versi un altro mestiere: non possiamo più fare alcune schifezze innocenti, come assaggiare le salse col dito, e neppure schifezze meno innocenti, tipo rimettere nella padella le cose che cadono; siamo ulteriormente costretti a tenere in ordine e pulire spesso il piano di lavoro; non possiamo più lanciare delle cose contro i muri quando siamo nervosi, e purtroppo non si possono più produrre le stesse nuvole di fumo di un tempo, perché i sistemi di ventilazione sono quasi sempre approssimativi o antichi, e alcune persone si preoccupano molto di avere i vestiti che odorano di roba cucinata”. È il definitivo congedo dal Bourdain di Kitchen Confidential, noto ideologo delle cucine come luogo costitutivamente di malaffare: “non possiamo urlare quando ci bruciamo, quando ci tagliamo, quando ci cade una padella sul piede. Non possiamo sbraitare e insultarci a vicenda, ma soprattutto non possiamo insultare voi che rimandate indietro i piatti, che chiedete la pasta senza capperi, e che ci infliggete il catalogo ragionato dei vostri pensieri magici riuscendo a far inceppare gli ingranaggi della fragilissima macchina di produzione della felicità che cerchiamo di mettere in moto tutte le sere”. E con il ricordo commosso di Anthony Bourdain, improvvisamente impiccatosi in un lussuoso albergo tedesco, si chiude non a caso il libro. Di “carbonara confidential” si parlava già nei Conti con l’oste.
Ecco appunto – citando forse inconsapevolmente il Rossellini della Città e l’Eco dell’Opera – l’idea di una cucina aperta, un luogo non solo visibile unilateralmente ma fruibile per intero, frequentabile, dove gli sguardi vanno in entrambe le direzioni: chi è guardato guarda a sua volta chi lo sta guardando. Una specie di antropologica reciprocità che è frutto di un regime scopico doppiamente voyeuristico. Questo libro – spiega molto chiaramente Melilli – “non parla di persone che guardano altri cucinare, questo lo fate tutti i giorni: parla di ciò che vediamo noi mentre ci guardate”. È al discorso bellico che dobbiamo allora pensare: una città aperta, come appunto Roma nel film di Rossellini, è un luogo che si dichiara sconfitto pur di rinunciare alla violenza della guerra, alla forza d’urto del nemico. Le cucine aperte sono un po’ così: i lavoratori della cucina non sono più una brigata militaresca ma una compagnia di giro che fa bella mostra di sé, che recita di fare qualche sta facendo. A patto di potere anch’essi osservare quelli che, ingozzandosi a quattro palmenti, li stanno fissando mentre lavorano.
Ma che cosa c’è da guardare, cosa si vede allo spioncino oramai allargatissimo che dalla cucina punta alla sala? Parecchio: e ne viene fuori una piccola etnografia dell’attuale pratica del mangiar fuori, dove non mancano le patenti contraddizioni. Laddove una cucina aperta – cioè un ritorno sensato e attento all’osteria alla buona –proclama il recupero intelligente delle tradizioni gastronomiche dei vari territori, i loro avventori vanno invece alla ricerca di novità fini a se stesse, di quell’effetto wow che è spesso la caratteristica essenziale del fine dining. Perché per esempio non servire al tavolo un buon minestrone, magari freddo come predica un’antica usanza lombarda? Ma se lo si mette in carta, quasi nessuno lo sceglie, perché nessuno va fuori a cena per poi mangiare come mangia in casa: ma siamo certi che si tratterebbe dello stesso minestrone, delle medesime verdure, degli stessi loro accostamenti? È come se ci fosse da parte dei commensali una specie di neofilia costitutiva, pregiudiziale, che li porta non tanto ad ammirare i gesti, e le gesta, del cuoco-divenuto-spettacolo ma a giudicarlo preventivamente secondo un sistema di valori che non è il suo.
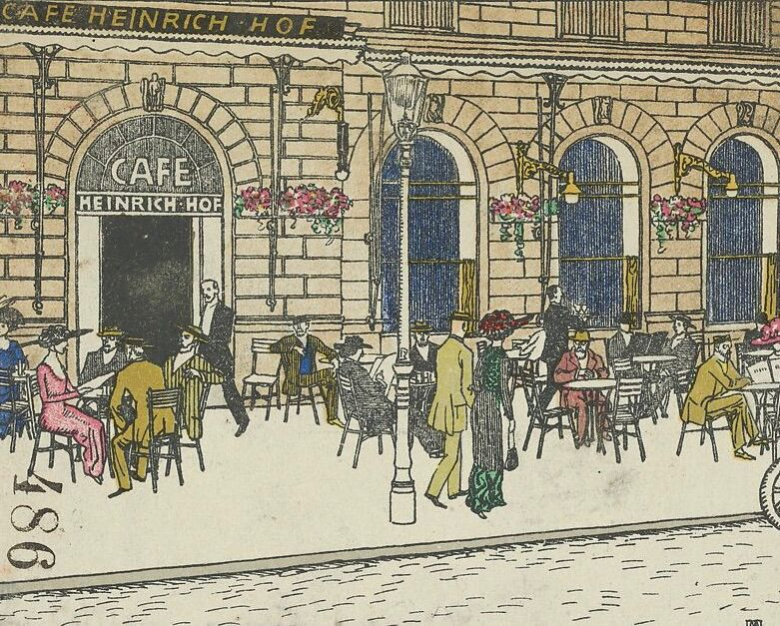
L’oste odierno, insomma, non è tale due volte: la prima perché sta perennemente in palcoscenico, la seconda perché, stando lì, non potrà mai essere quel che vorrebbe – un oste bell’e buono – ma il suo simulacro invertito di senso: lo chef. Cade, come è ovvio, il principio dell’autenticità, soprattutto se contrapposta a una qualche forma di artificiosità. Il ritorno all’autentico è artificioso perché è il suo destinatario, che pure lo cerca, a non volerlo, forse a non comprenderlo. Come dire che, tanto per cambiare, è il sistema a contare, le relazioni che si istituiscono fra i suoi vari elementi, non i singoli protagonisti. Ed è così che a mangiare le cose “cucinate quasi come a casa” non sono affatto gli avventori delle cucine aperte (sempre alla ricerca dell’innovazione fine a se stessa) ma soltanto i cuochi che le preparano, riedificando così sulla sfera simbolica quel muro che era stato abbattuto sul piano materiale. Per il resto, a essere considerato segno indiscusso della buona cucina resta il piatto complesso, misterioso, ricco alla vista perché inaccessibile al palato: un po’ come accade per l’arte contemporanea, dice Melilli, che tanto più è apprezzata dal grand public quanto meno è capita. Del resto, il cibo e l’arte hanno una cosa in comunque: il gusto, come dire la cosa più capricciosa e insieme più prevedibile che possa esistere.
È ovvio che poi i compromessi si trovano, e, come sempre, finiscono per essere dei gran pasticci: “è per questo che i francesi mettono la panna della carbonara, è per questo che nessun occidentale è in grado di mettere abbastanza prezzemolo nel tabbouleh, è per questo che spolveriamo il curry sulle cose come se fosse parmigiano, è per questo che inzuppiamo il sushi nella salsa di soia (di nuovo, perché la salsa di soia sa di parmigiano), è per questo che i kebabbari, in Italia, si sono rassegnati ad arrotolare il kebab nelle piadine. Perché abbiamo paura”. E dove c’è paura, si sa, c’è potere.
Da qui lo smuoversi di una pletora di passioni che, più ancora che il buon cibo, appare e domina nelle cucine aperte. Alla paura si risponde ovviamente col coraggio, quello di riprendere (non ‘rivisitare’, per carità) la tradizione per quel che è, o che era, senza scartare da essa la miriade di ingredienti e di piatti che risultato scomodi al gusto di oggi. Alle poche idee del cliente seduto al ristorante, occorre così associare la sua trepidazione: “andiamo ormai al ristorante come un tempo si andava a teatro; con la stessa trepidazione e fame di scoperta. In alcuni casi con più trepidazione ancora …(…) Siamo spesso più eccitati in attesa di una cena in un posto speciale che nel fruire una qualsiasi forma d’arte”. Il rischio, però, è quello di far emergere, con la tristezza, addirittura la noia. Come l’Opera di Eco, i piatti della cucina aperta finiscono così per essere soggetti alle più diverse interpretazioni. Ma anche alle più diverse emozioni.
Leggi anche:
Gianfranco Marrone | Santi bagnati, bevitori asciutti
Gianfranco Marrone | Tra gli scaffali del supermercato
Gianfranco Marrone | Tre stelle a McDonald's
Gianfranco Marrone | Il panino: attenti a quei due!
Gianfranco Marrone | Dal tagliere alla città









