Tim Ingold: il futuro alle spalle
Sembra che gli abitanti delle Isole Figi abbiano due problemi. Il primo è l’innalzamento delle acque dell’oceano, al punto da esser costretti ad abbandonare i villaggi costieri. Il secondo, strettamente collegato, è che in quei villaggi si trovano i luoghi di sepoltura degli antenati, che nessuno è disposto a lasciare lì né tantomeno a riesumare – cioè a distruggere – e trasportare altrove. Un dilemma irresolubile, una tragedia: i morti, secondo quelle comunità, costituiscono una guida spirituale fondamentale per l’esistenza sociale, di modo che le loro tombe non possono e non devono essere smosse o dimenticate. Del resto un villaggio è tale, sostenevano a Macondo, se vi sono già delle sepolture che ne possano attestare l’identità: altrimenti non è che un effimero accampamento. E difatti è solo con l’edificazione della tomba di Melquiades lo zingaro che José Arcadio Buendia – stiamo ovviamente parlando di Cent’anni di solitudine – ha potuto dichiarare fondato il suo adorato, mitico paese. Ne sanno qualcosa gli abitanti di Nanhai, territorio sul delta del Fiume delle Perle nella Cina meridionale, che per secoli è stato un reticolo di villaggi, campi, sentieri e tombe. Una collinetta, in particolare, era il luogo dove risiedevano seppellite molteplici generazioni di antenati; ma all’inizio degli anni 2000 è stata spianata per costruirvi un’autostrada: una catastrofe antropologica bella e buona che ha sradicato migliaia di persone dal loro passato. O forse, per nulla paradossalmente, dal loro futuro. Giambattista Vico, si sa, aveva a questo proposito coniato un’etimologia patafisica: sosteneva che umano provenisse dal latino humando, in riferimento ai riti della sepoltura: essere umani, in altri termini, è più che altro avere l’abitudine di seppellire i propri morti. (E io benedico ancora la mia educazione scolastica d’antan che mi ha imposto di mandare a memoria i Sepolcri di Foscolo).
La faccenda è generalizzabile, ma soprattutto assai attuale, secondo Tim Ingold, grande antropologo inglese autore di testi ormai classici come Making e Siamo linee, Corrispondenze e Ecologia della cultura, che nel recentissimo Il futuro alle spalle sposta l’asse del suo discorso su un registro più filosofico (una filosofia che, come il lettore comprenderà, mette insieme Bergson, Dewey, Benjamin, Popper e Deleuze con Geertz, Rilke, la Bibbia, Gibson e la più recente letteratura etnologica anglosassone). Questo formidabile libretto, tradotto e introdotto da un sicuro conoscitore del suo pensiero come Nicola Perullo (Meltemi, pp. 170, € 16), è – diciamolo subito – per molti versi destinato a suscitare qualche polemica. Vi si sostiene, per esempio, che per affrontare i grandi problemi del nostro tempo (guerre, crisi climatica, metamorfosi delle democrazie, migrazioni di massa, perdita delle biodiversità, convivenza fra terrestri etc.) occorra abbandonare l’idea, e la pratica, dell’innovazione a tutti i costi, del progresso per il progresso e, più in profondità, la concezione stessa di ciò che è da intendersi come futuro: da ritrovare, dice Ingold, non guardando avanti verso un orizzonte incerto e problematico, ma semmai girandosi indietro, alla ricerca delle sue tracce ossia in quel che hanno vissuto coloro che ci hanno preceduto, intrecciando le loro vite alla nostra, mantenendo stretti i legami col passato, saltando perciò quella corda – robusto ordito di una miriade di filamenti eterocliti – che tiene in continuità le esperienze vissute dalle diverse generazioni. L’immagine benjaminiana dell’Angelus novus aleggia con gran convinzione e alquanta preoccupazione.
Cosa significa, allora, che il futuro sta alle nostre spalle? Per certi versi, dice Ingold, è un’ovvietà (tutte le culture fanno così: è quel che chiamiamo tradizione); per altri invece è uno scenario che la nostra modernità tende invece a invertire, proiettandoci verso un avvenire che è, prima d’ogni altra cosa, sistematica eliminazione del passato, cancellazione delle sue tracce, oblio di quel che ci ha preceduto. I latini, come sa chi ha frequentato il liceo d’un tempo, avevano inscritto nella loro lingua questa relazione tra tempo e spazio che a noi suona strana: ante, si ricorderà, è un avverbio di tempo che significa ‘prima’ e un avverbio di luogo che vuol dire ‘davanti’; analogamente post significa ‘dopo’ ma anche ‘dietro’. Tant’è che nella nostra lingua posteriore indica qualcosa che è dietro di noi ma deve ancora accadere; e anteriore è il contrario: designa ciò che ci sta davanti ma che è già passato. C’è un bel libro di Maurizio Bettini, Antropologia e mondo antico, che ne parla a lungo. Per il latino, insomma, il futuro è un nastro trasportatore, non una via percorsa in macchina (non c’erano all’epoca? appunto: i romani lo avevano dietro di sé). Quando camminiamo sul nastro abbiamo davanti ciò che prima ci stava dietro, mentre abbiamo dietro quel che ci accadrà di vedere dopo. Abbiamo letteralmente il futuro alle spalle. Quando invece guidiamo è il contrario: abbiamo davanti ciò che deve ancora accadere, e ci lasciamo indietro la strada percorsa. In questo secondo caso è il passato a essere dietro di noi.
Generalmente, dice Ingold, ragioniamo come conducenti di un’auto: immaginiamo la freccia del tempo come un andare avanti, un inseguimento di qualcosa che deve ancora accadere. Ma è senso comune irriflesso, qualcosa su cui non ragioniamo più di tanto. Se lo facessimo, ci accorgeremmo che può accadere il contrario. Se proviamo a immaginarci l’avvenire come qualcosa che deve ancora accadere, certo, ma che sta anche alle nostre spalle, potremo altresì vivere il passato come una guida, qualcosa che è accaduto e che proprio per questo ha tanto da dirci, da insegnarci, come una guida appunto. A fronte di chi, e sono tanti, probabilmente quasi tutti, inneggiano al mutamento come pietra filosofale, allo sviluppo come valore supremo da rincorrere a tutti i costi, possiamo forse opporre, dice Ingold, un richiamo alla memoria: non per becero conservatorismo, come affrettatamente si pensa, ma per ricorso sensato alla saggezza di chi ci ha preceduto, e dunque ha tutto il diritto e il dovere di indicarci, dinanzi a noi, la strada da seguire.
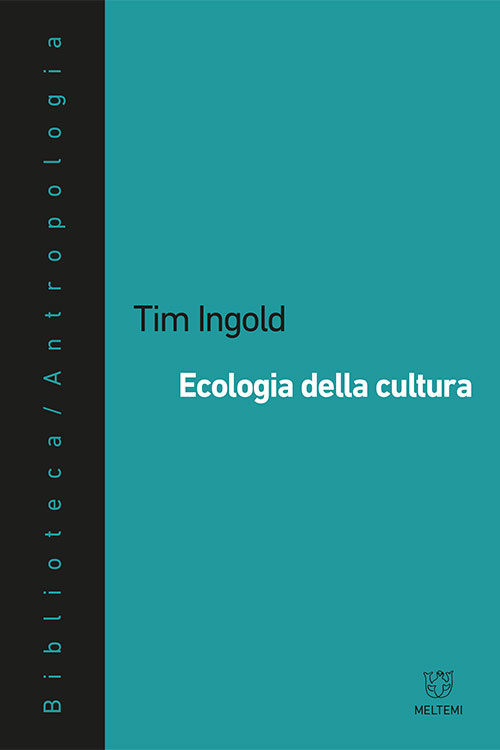
Il senso comune che è tipico della modernità pensa le generazioni come entità a sé stanti che, succedendosi l’una con l’altra, formano strati geologici che si sovrappongono fra loro (prima i Boomer, poi Gen X, poi ancora Millenials, poi Gen Z… e così di seguito), ognuno coi propri valori e gusti, a uso e consumo, molto spesso, del marketing e del branding. In tal modo, a dominare in un dato periodo storico è una sola di esse, quella che Ingold chiama Generazione Ora, pronta a cancellare quel che aveva pensato e fatto la generazione precedente, e con la consapevolezza che, a un certo punto, dovrà passare pietosamente le redini alla generazione successiva. È il principio dell’eredità, un pacchetto di beni materiali e spirituali da passare bell’e pronto di mano in mano, per generazioni, senza mai condividerlo fra di esse. È il modo di ragionare, osserva Ingold, dell’archeologia, che opera andando alla ricerca di civiltà che si stratificano nel tempo; ma anche della biologia evoluzionista, per la quale gli organismi viventi possiedono per ontogenesi pacchetti preordinati di caratteri da proporre a chi li seguirà; della linguistica, che ragiona in termini di sistemi sincronici che si succedono diacronicamente fra loro; come anche dell’antropologia della parentela, che disegna le relazioni fra esseri in termini di linee che uniscono pallini e triangolini senza dire nulla della qualità di tale relazione…
Lo studio etnologico delle varie e diverse culture umane ci rimanda un’immagine assai diversa delle generazioni: non strati impilati ma fili sottilissimi che si intrecciano a formare una corda duratura e resistente. Come dire che le generazioni si succedono, ma come in una staffetta, di modo che c’è sempre un momento, anche assai lungo, in cui non si succedono ma convivono. Generazione (sostantivo) è essere generato (verbo), dunque sussistere con chi prima mi ha concepito e con chi dopo io originerò: “l’elemento cruciale della generazione è che essa appartiene allo stesso movimento della vita che genera. È un proseguire, non uno scambiare come tale. L’atto procreativo può cominciare con un incontro sessuale, ma questo è solo l’inizio di un processo che dura nel tempo, non è istantaneo ma si protrae nel tempo […]. Si tratta della fatica di trasportare e sollevare”. Il lungo elenco genealogico che da Adamo arriva quanto meno a Noè nel Genesi, sostiene Ingold, prevede al suo interno, non foss’altro che per l’età raggiunta dai vari patriarchi, che per lunghi periodi essi abbiano vissuto insieme, condividendo esistenze ed esperienze.
Nessuna discontinuità dunque, ma una continuità sbilenca, alternata, relativa ma necessaria. In tal modo non c’è un’età dominante – la fantomatica maturità – sulle altre, ma una condivisione del tempo: i giovani non sono entità che prima o poi prenderanno il posto dei padri, così come gli anziani non sono soggetti che hanno abbandonato la ribalta; le generazioni formano un mondo comune. Si superano così le ingiustizie che la società attuale invece produce, creando gerarchie anche e soprattutto in termini di generazioni impilate piuttosto che intrecciate. “La vita – scrive Ingold – non è un tiro a segno. Si tratta invece di procedere a tentoni, nello scarto fra mezzi e fini: qui si ritrovano tutte le possibilità. In mezzo a tutto questo non vediamo un futuro che si dirige verso di noi ma che si estende fino a dove arriva lo sguardo. Si muove insieme a noi: non ci arriveremo mai; eppure finché riusciamo ad andare avanti, c’è speranza”. Esattamente come su un salvifico nastro trasportatore. Perdurare, lasciare delle scie, costruire le proprie tracce: ecco la sfida.
Un tale ragionamento, che si specifica fin nei più minimi dettagli nel corso di questo libretto fulminante, prosegue nella lunga e articolata introduzione di Nicola Perullo. Da una parte, Perullo inquadra il testo in questione nel contesto dell’opera di Ingold e, più in generale, della riflessione filosofica contemporanea. Dall’altra, allarga ancora la tematica proponendo una più profonda filosofia della Qualità, valore sempre più negletto nella contemporaneità. L’ideologia egemonica attuale, difatti, invita ad avere successo, soldi, notorietà e potere per il tramite di novità preconfezionate, innovazioni tanto prevedibili quanto effimere, legate al principio dell’immediatezza, del qui e ora, il quale presuppone a sua volta un continuo ricambio di uomini e cose, una sorta di obsolescenza programmata e diffusa per ogni dove, un’amnesia coltivata. In questa prospettiva, il nuovo è valore supremo fine a se stesso. Ma si tratta, sostiene Perullo, di una temporalità vuota perché priva d’ogni senso della durata, della permanenza, della decelerazione. Non è un caso che i francesi abbiamo tradotto sustainable con durable. Reintrodurre un pensiero della Qualità comporta allora, da un lato, superare la vecchia dicotomia fra natura e cultura (che, per esempio, opprime imperterrita, ma surrettiziamente, la maggior parte degli attuali discorsi sull’intelligenza artificiale), e, dall’altro, provare a opporre industriale ad artigianale. “Si tratta di passare dalla distinzione fra naturale e artificiale a quella fra due modelli di ‘artificialità’ nella vita singolare e comune, nella generazione e nelle generazioni: il modello artigianale e il modello industriale”. Emerge così, di contro alla smartness oggi tanto esaltata, l’idea di un’intelligenza artigianale: la quale “non è soltanto l’intelligenza dell’artigiano, che si manifesta nella qualità di un certo tipo di artefatti; è anche e innanzitutto l’artigianalità dell’intelligenza”. Ricordate Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta? Siamo da quelle parti. Urge rileggere Pirsig e il suo diario filosofico.









