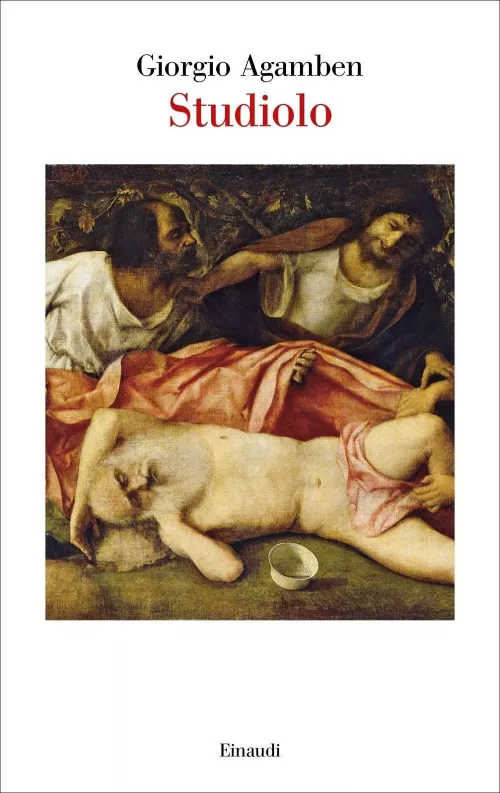Giorgio Agamben. Studiolo
Il sotteso o il sottofondo delle immagini.
È del tutto evidente che un’immagine consiste in ciò che essa stessa espone visibile e che, pertanto, la sua natura – il suo essere – coincida con il suo apparire, ovvero che è la sua fenomenologia a costituirne l’ontologia. Nella storia della conoscenza umana l’immagine ha sempre costituito il principio, il mezzo e il fine della visione. Sotto un’altra prospettiva può anche essere concepita come un’offerta di operosità all’incessante ramingare dello sguardo. Tuttavia anche l’immagine, in particolare quella dipinta, poggia su di un supporto che, per quanto minimo, presenta una profondità e oppone al lato offerto allo sguardo un altro lato oscuro, corrispondente a una sorta di sottofondo generalmente trascurato.
Ognuno di noi è legato a delle immagini particolari che, per una ragione o per un’altra, sedimentano sul fondo di quanto abbiamo ritenuto essere memorabile. Nei palazzi rinascimentali alcune immagini venivano custodite con cura in una piccola stanza, lo studiolo, nella quale il principe si ritirava quando, isolandosi dalla vita mondana, desiderava entrare in una sorta di personale paradiso dei sensi e della mente. Anche il filosofo Giorgio Agamben ha idealmente raccolto nel suo ultimo libro che ha per titolo, appunto, Studiolo (Einaudi, 2019) una ventina di dipinti, dai quali vorrebbe essere sempre accompagnato, in quanto essi mettono in questione “qualcosa che altrimenti non sarebbe dato di comprendere.” L’analisi che il filosofo conduce di queste immagini è dichiaratamente non afferente alla tradizione della storia dell’arte, né a quella della critica d’arte, ma vuole essere ascritta alla categoria del commento, sebbene talvolta, per far sì che lo sguardo possa pervenire alla pienezza della loro visione, ricorra anche ad essenziali, quanto perspicui, strumenti critici.

Achille rinuncia a Briseide.
L’arte del commentum consente possibilità interpretative più libere e di largo respiro, rispetto alle limitazioni che, non di rado, impone l’ortodossia delle metodologie della critica e della storia dell’arte. Dalla lettura dei testi che accompagnano le immagini si evince chiaramente il perché della necessità di questa scelta. Avvalendosi, quindi, di queste possibilità il filosofo punta a far emergere “quel qualcosa delle immagini” che non si dà immediatamente alla loro comprensione, forse anche perché non può apparire con una forma immediatamente visibile. Questo qualcosa, in quanto fondativo della natura stessa dell’immagine, non può che situarsi al di sotto della superficie, nel suo sottofondo non visibile e oscuro dove affondano le sue radici in cerca di alimento: là dove sorge il pensiero, nell’immaginario mitologico, poetico, simbolico e spirituale della nostra civiltà. Ogni immagine affiora su un mondo sotteso le cui vastità e profondità non si lasciano illuminare dallo sguardo solare, ma impongono a quest’ultimo di munirsi di una differente modalità più adatta a intravedere in tralice ciò che sta sotto le parvenze ottiche. Ogni capitolo del libro costituisce una magistrale esemplificazione di come accedere al sotteso dell’immagine mediante l’esercizio di questo sguardo. Ne riferiamo alcuni stralci.
Che cos’è l’ispirazione? È questa la domanda che Agamben si pone nel quinto capitolo. Con il gomito appoggiato sul ginocchio e la mano impegnata a sostenere il mento, assumendo la canonica postura del pensatore malinconico, Tiziano si ritrae tra i personaggi raffigurati in una delle sue ultime opere: Lo scorticamento di Marsia, un noto episodio della mitologia greca dipinto su tela e conservato nella pinacoteca del castello di Kroměříž. Il grande pittore veneto non sembra essere particolarmente scosso o turbato dalla cruenta scena che osserva con sguardo pensoso. Sembra meditare non tanto sulla efferatezza dello scempio sanguinoso in sé, ancorché inflitto al corpo del sileno ancora vivo, quanto su qualcosa di molto intimo e personale che lo riguarda in prima persona: il suo pensiero, infatti, è attratto da un senso che trascende l’aneddotica dell’evento. Tiziano, infatti, ritraendosi sotto le vesti del personaggio di Mida, trasfigura la scena in una meditazione, assegnandole il compito di figurare, seppure a un secondo livello, la metafora o l’allegoria dell’ispirazione. Nelle interpretazioni canoniche Marsia subisce il disumano supplizio a causa della sua hybris, che l’ha spinto a sfidare Apollo in una contesa musicale, nella quale non avrebbe mai potuto primeggiare. Per Agamben, Tiziano che ha letto la Divina Commedia di Dante si avvale di un esplicito riferimento all’inizio del Paradiso, nel quale il poeta toscano invoca Apollo affinché gli dia l’ispirazione per completare il suo lavoro: “o buono Apollo (…) Entra nel petto mio, e spira tue sì come quando Marsia traesti de la vagina de le membra sue.”

Tiziano, Lo scorticamento di Marsia.
Lo scorticamento di Marsia richiamato nell’invocazione dantesca viene assunto dal filosofo come una metafora dell’ispirazione: “possiamo presumere con ragionevole verisimiglianza che Tiziano sia stato colpito da questo passo e ne abbia tratto l’idea di fare dello scorticamento del satiro l’allegoria dell’abissale difficoltà dell’ispirazione del pittore.” Il quale sente in qualche modo che quel corpo scorticato è il suo, perché l’ispirazione che insegue è da esso dolorosamente incarnata e situata “tra l’inumano e l’umano e tra l’animale e il divino.”
Oltre al dipinto di Tiziano Agamben cimenta il suo raffinato commentum in altre venti opere, molto differenti tra loro, per i soggetti rappresentati, per lo stile e per le rispettive epoche di appartenenza. Quel che, fin dalla prima lettura, emerge con crescente evidenza e che sembra costituire la liaison, o meglio il filo con cui è ordito il loro invisibile legame, è sintetizzabile nella necessità di rendere “eterno l’istante” della leggibilità di quanto è sotteso e taciuto in ogni immagine. Agamben invita lo sguardo del lettore a vedere che le cogitationes divinae di Santa Barbara dipinta da Jan Van Eyck non sono rappresentate nel libro aperto, dove peraltro lo sguardo obliquo della santa non sembra diretto, ma dall’intreccio delle pieghe della immensa veste, metafora del dispiegamento infinito del mondo in cui Dio è presente. Allo sguardo del filosofo la Lepre morta con sacca per polvere da sparo e carniere, dipinta da Jean-Baptiste-Siméon Chardin non è riducibile alla rappresentazione di un quadro di genere, ma appare come una pittura sacra, come la più commovente crocifissione della pittura francese del XVIII secolo. Nella divaricazione delle zampe posteriori dell’animale è inscritta una struttura a X, coincidente “secondo ogni evidenza alla croce invisibile di sant’Andrea, l’espressione visibile dell’intimo legame fra Dio e il mondo.” Agamben ci porta a pensare Chardin come uno spinozista che vede nelle ciotole, nelle brocche di maiolica, nei paioli di rame, in tutte le cose la pietà e l’amore di Dio. Ragion per cui le sue opere devono essere lette come la testimonianza del più grande pittore sacro non soltanto del XVIII secolo, ma di tutta la modernità.

Chardin, Lepre morta con sacca per polvere da sparo e carniere.
La scultura Senza titolo di Cy Twombly, che porta l’inscrizione di quattro versi della X Elegia del poeta boemo Rainer Maria Rilke, è interpretata come la forma di un fiore che cade, come la visualizzazione di una bellezza spezzata e in caduta, dove “nell’infrangersi del movimento ascensionale è l’arte stessa che appare sulla soglia tra un fare e un non-fare, nel punto della decreazione, quando l’artista nella sua maniera suprema non crea più e l’arte sta miracolosamente ferma, quasi attonita: ad ogni istante caduta e risorta.” Particolarmente avvincente è la descrizione dello sguardo raffigurato nell’affresco pompeiano Achille rinuncia a Briseide: l’uomo antico fissa con uno sguardo attonito, silenzioso e sgomento e, sebbene non esprima alcuno stato d’animo, esplicita, comunque, un gesto intenso, che rappresenta l’unico principio di movimento nella generale fissità della scena. In quest’ultima nessuno sguardo incrocia l’altro, non si vedono l’un l’altro e ciascuno di essi guarda lontano, verso non si sa dove: “la lontananza che i loro occhi invocano ed evocano è così vicina, che ne restiamo noi stessi accecati.”
Giorgio Agamben. Studiolo. Einaudi, Torino 2019.