Letargo / Elisabetta Benassi. Alla ricerca del sonno perduto
THEY LIVE WE SLEEP: così «suonava» l’opera esposta da Elisabetta Benassi alla Quadriennale del 2008. Suonava perché era questa la frase ripetuta – in quella che ai nostri orecchi risultava una cacofonia priva di significato – da tante voci sfalsate fra loro, emesse da centocinquanta megafoni. Ma suonava, anche, perché – incomprensibile all’udito – la si poteva invece leggere, una volta che ci si fosse solo allontanati un po’, disegnata sulla parete del Palazzo delle Esposizioni dalla disposizione delle fonti sonore. In quel caso, come in diversi altri lavori dell’artista romana, la latenza del significato – condizione comune a tutta l’arte di matrice concettuale – ingenerava e insieme era contrassegnata da uno stato stuporoso, una sorta di sonnambulismo. Capiamo e insieme non capiamo; forse siamo destinati a capire solo a posteriori. Forse il vero oggetto del lavoro – il suo significato più pregnante – non è altro che questa latenza, questa sospensione. Che corrisponde alla forma della vita che conduciamo.
Il torpore che avvolge le nostre menti non è che il residuo incerto, brumoso e lattescente, di un’esistenza alla quale proprio il sonno, in effetti, è stato sottratto. Sino alla tarda modernità, nulla era più naturale del ritmo che ci induceva ad attenuare il nostro metabolismo, e a sospendere la nostra attenzione, per una parte consistente del giorno. Tanto che la privazione coatta del sonno, dai GULag staliniani a Guantanamo, è stata riconosciuta come una delle forme di tortura più sottili ed efficaci. Ma da alcuni decenni a questa parte, come ci ha mostrato Jonathan Crary in uno dei saggi più importanti del nostro tempo (24/7. Il capitalismo all’assalto del sonno, Einaudi 2015), l’erosione progressiva del sonno è una delle stimmate meno avvertite, ma più segretamente simboliche, della «vita in continua e illimitata espansione del capitalismo del XXI secolo» (dicono le statistiche che il riposo medio agli inizi del Novecento fosse di dieci ore, qualche decennio fa era sceso a otto, ora si aggirerebbe sulle sei ore e mezza). Lo stato d’allerta indifferenziato indotto dalla compulsività social (quello che Maurizio Ferraris ha definito, mutuando una minacciosa parola d’ordine jüngeriana, Mobilitazione totale: Laterza 2015) è la realizzazione compiuta, oggi, di quella che nei primi anni Novanta Gilles Deleuze, sviluppando temi foucaultiani, aveva definito società di controllo: nella quale è la nostra disponibilità a controllare tutto, a partire da noi stessi, che viene messa a frutto. Siamo divenuti noi, ormai, il Grande Fratello – il Panottico di noi stessi.
 Al Pacino in Insomnia di Christopher Nolan (2010)
Al Pacino in Insomnia di Christopher Nolan (2010)
Sicché – continua Crary – l’antica metafora del risveglio (da San Paolo a Matrix passando per la Scuola di Francoforte), come segno del «recupero dell’autenticità» e della condizione eretta dell’essere umani contro ogni forma di sopraffazione, «è ormai inadeguato per un sistema globale che non dorme mai». La nostra condizione è più simile a quella dei personaggi di Kafka, o di Stalker di Tarkovskij (a me viene in mente soprattutto l’investigatore Al Pacino, istupidito dalla luce perenna dell’estate artica, in Insomnia di Christopher Nolan): perennemente deprivati del sonno viviamo in una condizione limbica, allucinatoria. E allora oggi, secondo Crary, rivendicare il diritto al sonno può essere considerata una forma di resistenza – ancorché, purtroppo, solo passiva –: perché proprio il sonno «interrompe risolutamente il furto di tempo che il sistema capitalistico compie ai nostri danni». La fortuna filosofica recente del personaggio di Bartleby di Melville, o quella letteraria dell’opera-vita di Albert Cossery, a proposito della quale vale davvero la formula di Giuseppe A. Samonà (curatore di recente del suo primo libro tradotto da noi, da Einaudi: I fannulloni della valle fertile), «la rivoluzione del non fare», sono esempi di quella potenza destituente dell’inoperosità che è divenuta cavallo di battaglia di tanto pensiero contemporaneo, da Blanchot ad Agamben passando per Nancy.
Ma se è vero che proprio questo dell’uso del tempo – dove in gioco, appunto, è il vettore del genitivo: siamo “usati” dal tempo che ci è dato in sorte, o di esso possiamo ancora disporre? – appare uno dei campi cruciali in cui si declina attualmente il politico, non ci può sfuggire come stia diventando precisamente quella del sonno, oggi, una delle merci più pregiate. Il capitalismo, al solito, riesce a mettere a frutto anche quanto potrebbe rappresentare le sue eccedenze, i suoi resti. È la «mercanzia onirica» di cui parla Lidia Riviello nella sua ultima raccolta poetica, Sonnologie (pubblicata la scorsa primavera dalle Edizioni Zona), dove tutti siamo rappresentati quali «clienti» e «utenti» di un mondo dove «una volta si sognava senza produrre», ma dove ormai «l’infusione sottovuoto è carissima // solo sulle barche se lo permettono un sonno per intero».
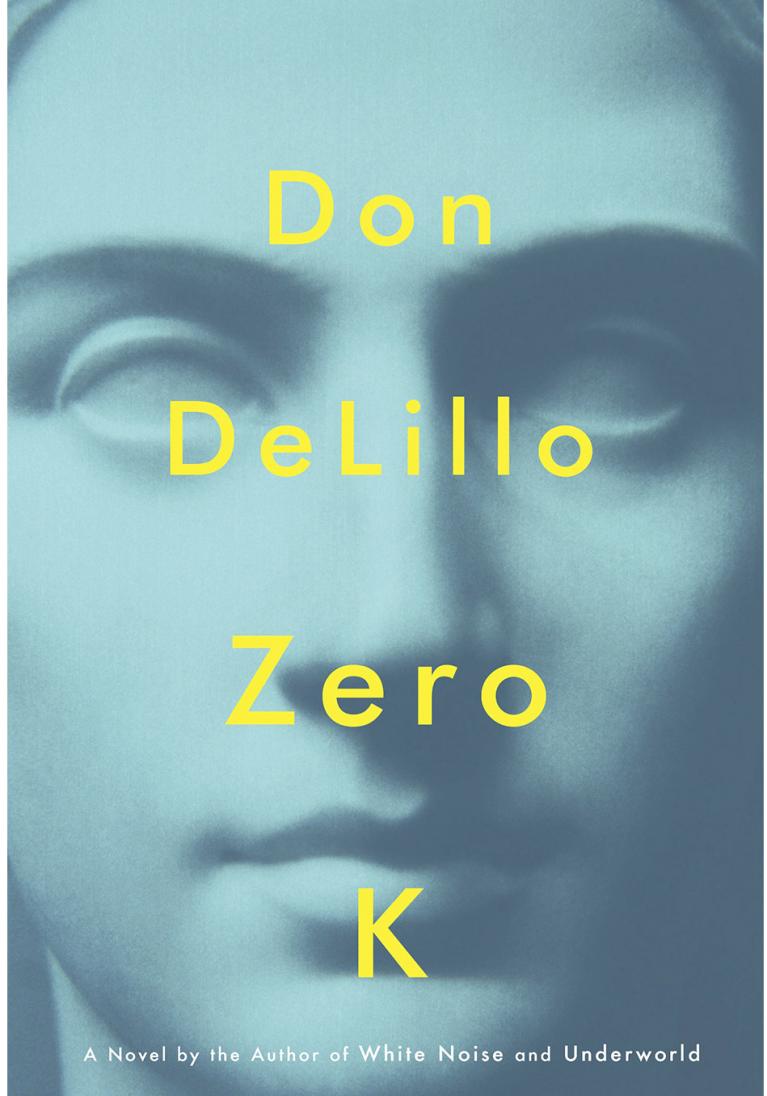
Don DeLillo, Zero K, 2016
Ed è poi questa, si capisce, la cornice di quell’algido e disperato poema narrativo che è l’ultimo romanzo di Don DeLillo, Zero K (traduzione di Federica Aceto, Einaudi 2016): in cui la merce suprema è appunto l’immortalità di un sonno senza tempo, uno stato di sospensione criogenica («Zero K» indica appunto la più bassa temperatura raggiungibile, lo zero assoluto dunque: corrispondente a meno 273,15 gradi Celsius) che promette la vita eterna agli adepti, tutti ovviamente facoltosissimi, di questa nuova religione che è anche l’arte per eccellenza del nostro tempo. Quest’«altra vita» a pagamento – «la trascendenza, la promessa di una intensità lirica al di fuori dei parametri dell’esperienza normale» – è infatti equiparata all’«unica cosa che non è effimera», ossia «le opere d’arte» (nel suo ipostatizzare in ogni suo romanzo appunto l’arte, a forma surrogata della religione, DeLillo è l’ultimo erede consapevole di una tradizione iniziata, nella modernità, dall’apostata Joyce). È sommamente ambiguo, DeLillo, nel far raccontare la storia di Convergence – la tecnologia biomedica d’avanguardia sovvenzionata dal miliardario Ross Lockhart, cui a un certo punto decide di sottoporsi lui stesso, seguendo nel suo destino la giovane moglie malata terminale di sclerosi – a uno che al suo fascino resta ostinatamente refrattario, a uno scettico insomma, come suo figlio Jeff. Ma non per questo penso sia corretto identificare Convergence, come è stato fatto, con l’inferno (la «ghiaccia» vitrea di Cocito, nell’interpretazione dantesca). Semmai essa viene presentata come un paradiso, o almeno l’inizio di un paradiso possibile («è questo l’aldilà lunare del pianeta»; il Cielo della Luna è la prima sfera attraversata dalla Terza Cantica dantesca dove, come si ricorderà, «trasumanar significar per verba / non si poria»: proprio l’inadeguatezza delle parole umane viene denunciata dalla giovane consorte di Ross Lockhart, Artis Martineau, quando si prova a rendere lo stato di sospensione in cui si trova, nel lancinante intermezzo di Zero K).
 Alcor Life Extension Foundation, Scottsdale (Arizona)
Alcor Life Extension Foundation, Scottsdale (Arizona)
La Convergence di DeLillo è il rifugio «fuori dalla storia» che ci si può procacciare al più alto dei prezzi: la vita, cioè, almeno per come la conosciamo (per questo i candidati alla criogenesi subiscono il condizionamento di una serie di terribili video che, sulle pareti di Convergence, trasmettono in continuazione scene di catastrofi naturali e barbarie bellica). Proprio come diceva Stephen Dedalus nell’Ulisse joyciano: «la storia è un incubo da cui cerco di destarmi». Qui però, per il paradosso indicato da Crary, all’incubo della storia, anziché attraverso il risveglio, si crede di sottrarsi calandosi volontariamente nel letargo della pre-morte/non-morte tecnologica. Per un ulteriore paradosso, quello a cui con questi mezzi estremi tentano di sottrarsi i megacapitalisti di Convergence è precisamente il mondo sovrailluminato, senza pietà perché senza riposo, di cui proprio loro sono i principali artefici. Come suona l’incipit di Zero K, «tutti vogliono possedere la fine del mondo» – del mondo infernale che ci siamo costruiti (la «fine del mondo esterno» era pure il sogno dell’altro megacapitalista Eric Packer in Cosmopolis, autorinchiuso in quella Convergence semovente che è la limousine blindata e foderata di marmo e sughero entro la quale conduce la sua esistenza). Ma solo pochi privilegiati possono accedervi: a spese di tutti gli altri che vi sono condannati.
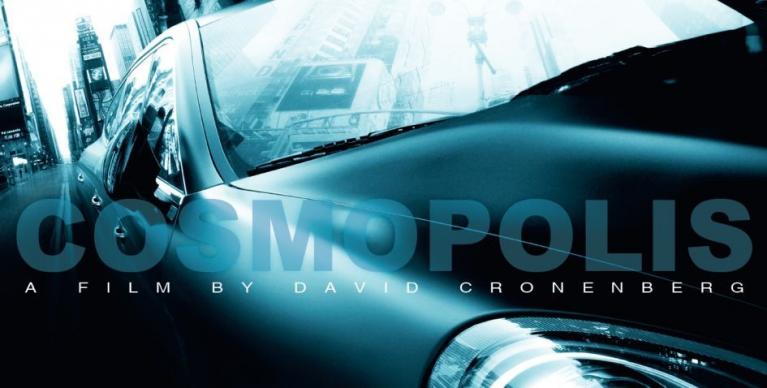 David Cronenberg, Cosmopolis (2012)
David Cronenberg, Cosmopolis (2012)
La medesima ambiguità ha il titolo della nuova mostra di Elisabetta Benassi, Letargo, terza personale ospitata dalla sua galleria storica (il Magazzino d’Arte Moderna in Via dei prefetti, a Roma; sino al 28 febbraio 2017), a sei anni di distanza da quell’All I Remember che le ha dato una giusta fama (consentendole di partecipare, unico artista italiano, alle tre ultime Biennali veneziane). Già in quell’occasione eravamo di fronte a un’allusiva riflessione sulla storia e sul suo calco rovesciato: le immagini erano in realtà retro-immagini della storia del Novecento, come l’hanno raccontata i mezzi di comunicazione di massa, evocate in absentia dalla riproduzione del verso di quelle fotografie, marcato nel corso del tempo dai segni e contrassegni che di quelle immagini ha tracciato, appunto, il loro uso e ri-uso mediatico. Insieme agli acquerelli di questi retro (riprodotti in parte in un bellissimo libro delle edizioni NERO), dell’opera fa parte integrante un’antiquata macchina per la riproduzione di microfilm che, nella semi-oscurità, randomicamente li visualizza su una parete della galleria (come nelle installazioni “cinematografiche” di Fabio Mauri), e che ha un titolo desunto da Jacques Derrida (come già un precedente lavoro di Benassi, Mal d’archivio), Memorie di cieco. Come diceva il filosofo in quel libro del ’90, dedicato – come recita il sottotitolo – all’Autoritratto e altre rovine, «il linguaggio […] ci parla sempre dell’accecamento che lo costituisce». Come la macchina che proietta le immagini, e che resta l’unica a non vederle, così l’artista non può dar conto dei circuiti di senso che le sue immagini producono. La sua cecità visionaria è la forma che assume il suo lavoro onirico: il prodotto del suo sonno, appunto.
E come sempre, in Elisabetta, sono appunto delle macchine a simboleggiare la natura latente – sospesa fra un sonno disturbato e una veglia febbricitante –, “automatica” come una scrittura surrealista, di questo lavoro che è il suo. Autoritratto al lavoro s’intitola appunto ironicamente, fra le otto opere esposte in Letargo, una motozappa delle Officine Meccaniche Benassi (un’affermata azienda che produce macchine agricole nei pressi di Ferrara, il cui motto suona «Con noi per coltivare il futuro»… ci si ricorda di una non-opera dell’artista omonima, 459 metri di campo arato, una performance – poi non autorizzata dal Comune di Roma – nella quale nel 2005 avrebbe dovuto appunto arare, al seguito di due buoi giganteschi, un campo di calcio a Colle Oppio).
 Elisabetta Benassi, Autoritratto al lavoro, 2016, motozappa (Meccanica Benassi), 105 x 70 x 140 cm, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
Elisabetta Benassi, Autoritratto al lavoro, 2016, motozappa (Meccanica Benassi), 105 x 70 x 140 cm, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
Salamandra ZAF è invece un grande pannello realizzato in una lega d’alluminio – il cui nome commerciale dà il titolo all’opera – sul quale sono infissi emblemi e marchi di automobili i cui nomi evochino quelli di animali (molto frequenti sul mercato statunitense; ma non mancano il Biscione dell’Alfa Romeo, la Panda della FIAT o il Leone Rampante della Peugeot): FALCON, FOX, TAURUS, BRONCO, MUSTANG, JAGUAR eccetera.
 Elisabetta Benassi, Salamandra ZAF, 2016, acciaio ed emblemi, 171 x 350 cm, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
Elisabetta Benassi, Salamandra ZAF, 2016, acciaio ed emblemi, 171 x 350 cm, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
La più spettacolare fra le opere presentate da Letargo è poi Mimetica: una grande palma artificiale realizzata in acciaio e resina, lunga quasi sette metri. Lunga, anziché alta, perché è stata collocata in posizione obliquamente orizzontale a cavallo di due delle sale espositive del Magazzino: al posto delle radici spunta dalla parete la sua base cava, che mostra la sua anima metallica, somigliante alla bocca d’un cannone (come quello vero del Gianicolo, in omaggio a Pino Pascali ripreso in un video del 2002, Noon, e sul quale la stessa Elisabetta, in tenuta da artigliere, vegliava in un’altra opera dell’anno successivo, Il mostro).
 Elisabetta Benassi, Mimetica, 2016, palma artificiale, acciaio, resina, fibra naturale e polipropilene, 310 x 300 x 690 cm, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
Elisabetta Benassi, Mimetica, 2016, palma artificiale, acciaio, resina, fibra naturale e polipropilene, 310 x 300 x 690 cm, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
Shit! s’intitola un minuscolo e vezzoso gioiello in una teca da esposizione, come in un’oreficeria; e che si rivela essere, invece, un coprolite: l’escremento fossile di un dinosauro, cioè, raccolto in Madagascar. Ma il vero punto saliente della mostra è il lavoro che le dà il titolo, Letargo appunto.
 Elisabetta Benassi, Letargo, 2016, particolare, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
Elisabetta Benassi, Letargo, 2016, particolare, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
Si tratta di due piccole sculture di bronzo rivestite di gesso, raffiguranti gusci di tartaruga infossati – fissati, in verità, con robusti chiodi – in uno strato di terriccio depositato nel portabagagli di una vecchia auto, una Ford Escort primi anni Settanta appoggiata con noncuranza su un muro all’esterno del Magazzino (tanto che diversi visitatori non la degnano d’uno sguardo, pensando si tratti d’uno dei tanti catorci abbandonati in città) e che, ci dice un hand-out distribuito in mostra, è stata donata a Elisabetta da Francesco Clemente, l’artista che l’ha impiegata per anni (ci si ricorda di Mareo Merz, installazione monumentale esposta da Benassi alla Fondazione Merz, a Torino, nel 2013: un vero peschereccio, lungo dieci metri, che nella sua rete ha “pescato” l’ultima automobile appartenuta a Mario Merz, una FIAT Marea appunto).
 Elisabetta Benassi, Letargo, 2016, automobile Ford Escort, bronzo, terra, due elementi bronzo ognuno 20 x 40 x 60 cm, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
Elisabetta Benassi, Letargo, 2016, automobile Ford Escort, bronzo, terra, due elementi bronzo ognuno 20 x 40 x 60 cm, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
L’ambiguità di fondo di Letargo non deriva però solo dalla commistione simulacrale di naturale e artificiale – che si può dire sia, fin dall’inizio, l’ossessione dell’artista (come nel bellissimo video del 2004, Tutti morimmo a stento: dove in uno stato di veglia immobile e inquietante, davvero “letargica”, erano rappresentati i «Motomen»: malinconici cyborg uomo-motocicletta rottamati fra mucchi di lamiera in uno sfasciacarrozze). L’emblema della Palma è ribadito da un altro lavoro, Palmense (vino al posto dell’acqua), anch’esso dissimulato dalla posizione, appoggiato com’è in un angolo: si tratta di una bottiglia colla sua etichetta PALMENSE, una vera marca d’acqua minerale d’antan, al cui interno è però contenuto del vino. La parodia delle Nozze di Cana, il primo miracolo di Gesù fra quelli raccontati dai Vangeli (Giovanni 2, 1-11), trasporta tutta l’ispirazione di Letargo in una significazione religiosa; e non si può non pensare, allora, che il simbolo della Palma nell’iconografia cristiana rinvia all’idea della Resurrezione dei Martiri e al loro trionfo nella vita dopo la morte (così trasvalutando il senso di decorazione conferita per una vittoria, militare o sportiva, che la Palma aveva invece nel mondo pagano): nei Vangeli così viene salutata l’entrata trionfale di Cristo in Gerusalemme (Giovanni 12, 13), prefigurando appunto la sua Resurrezione.
Questa dunque la sorte riservata a chi, come gli animali nella loro cieca saggezza, saprà superare la condizione presente accettando di sprofondare nel Letargo. Nella Legenda Aurea di Jacopo da Varazze si racconta una bellissima storia, cara a Borges, a Danilo Kiš e a Ermanno Cavazzoni qualche anno fa ripresa da Jacqueline Risset (nel suo Le potenze del sonno, nottetempo 2009): «sette giovani cristiani di Efeso, per sfuggire al regno degli idoli sotto l’imperatore Decio, si rifugiarono in una caverna. Si ritrovarono murati vivi con il loro cane, e lì si addormentarono. Dormirono trecentonove anni, mentre il cane, con le zampe distese, vegliava. Alla fine dei trecentonove anni si svegliarono per qualche ora e furono testimoni della Resurrezione. Avevano potuto contemplare il trionfo della giustizia; morirono subito dopo» (ce n’è una versione anche in una sura del Corano). Ecco, oltre all’ironia della natura posticcia, artificiale che di questo miracolo ci mostra il Letargo di Benassi, è proprio questa conclusione, della storia dei Sette Dormienti di Efeso, che lascia interdetti – coloro, almeno, che non possano condividere la fede nell’altra vita alla quale fa cenno DeLillo nel suo opus mysticum, artificiale e postremo quanto serissimo.
 Elisabetta Benassi, Casse-Pipe, 2016, accendini Zippo, incisione laser su accendini, due elementi, ognuno 6,5 x 3,5 x 1 cm, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
Elisabetta Benassi, Casse-Pipe, 2016, accendini Zippo, incisione laser su accendini, due elementi, ognuno 6,5 x 3,5 x 1 cm, Courtesy l’artista e Magazzino Roma
Fra le altre opere di Elisabetta esposte in Letargo, ce n’è una che pare riassumere in sintesi estrema tutte queste ambiguità. Sono due comunissimi, elegantissimi accendini Zippo, dalla superficie levigata e luccicante, sulla quale sono incise due scritte a tutte maiuscole, OUR AIM IS AWAKEFULNESS e OUR ENEMY IS DREAMLESS SLEEP: le parole d’ordine dell’odierna Mobilitazione Totale. E infatti il titolo del lavoro è Casse-Pipe, come quello del libro del 1949 in cui Louis-Ferdinand Céline raccontava il suo servizio militare, fra i corazzieri, alla vigilia della Grande Guerra. In argot, l’espressione casse-pipe designa il tirassegno e dunque allude appunto alla guerra (raccontata nel precedente Viaggio al termine della notte) in cui i soldati, come pipe di gesso, sono esposti alla casualità del fuoco. Dunque il risveglio dal Letargo, bruciante e luminoso, coincide con la morte; e la nostra stessa vita letargica non è, allora, che una morte a credito. Se così stanno le cose, davvero, meglio restare ciechi.
Una versione più breve di questo articolo è uscita su «il manifesto» il 31 dicembre.









