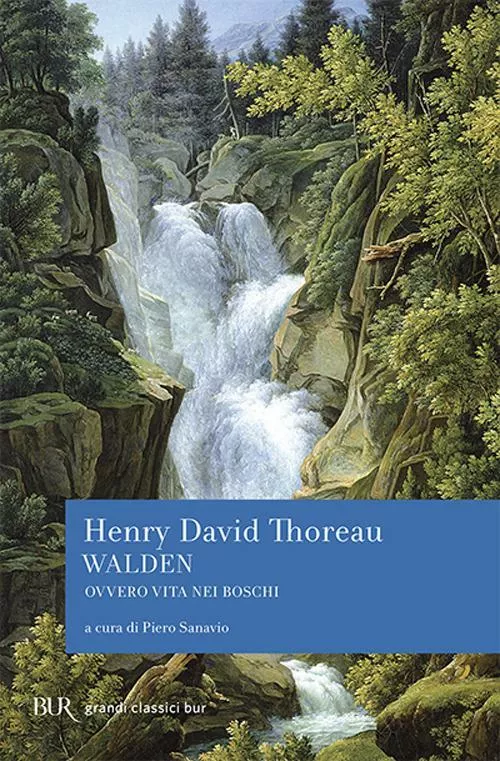Una vita / Fuggire il mondo
Risale a maggio di quest’anno l’ultima nuova uscita, per la BUR, del libro Walden, o Vita nei boschi scritto nel 1854 da Henry David Thoreau, cantore di una vita libera dai condizionamenti sociali e dal conformismo, che qui narra la sua esperienza di oltre due anni in seno alla natura in una foresta del New England, alla ricerca dell’essenziale della vita e alla scoperta di sé, lontano dall’inautenticità e dall’arroganza dei saperi e della cosiddetta civiltà. Ci sarà un motivo se Thoreau rimane un sempreverde, ripubblicato da diversi editori, se amiamo il giovane sognatore che coglie l’incanto delle cose semplici e la loro significazione originaria, se ci identifichiamo coi suoi ideali, se sentiamo anche noi il brivido di una vita non logorata dall’abitudine e il desiderio di rompere gli schemi, di ritrovare una sapienzialità direttamente “ispirata dal cielo” che va dalla cura del corpo e dell’anima all’agricoltura tradizionale, che aveva accompagnato l’umanità con un repertorio raffinatissimo di conoscenza sedimentato nei millenni rendendoci liberi e autonomi, mettendo a nostra disposizione pane e rimedi al male.
Oggi, invece, la conoscenza è stata delegata ai diversi specialismi del sapere e delle tecnologie, che fanno violenza al pianeta e alimentano le nostre illusioni di onnipotenza fino a quella d’immortalità. Tornare alla natura, risemantizzare il mondo immettendo in esso la forza di un’interpretazione poetica (alla lettera) capace di rigenerare anche noi stessi, riprendere la ricerca del sé autentico, sono diventati un lusso o una bizzarria, e il possibile riscatto, ciò che sarebbe giusto e normale, è diventato eccezionalità. Sono in molti oggi a utilmente indicare, per salvarsi, la via della liberazione dal mondo e anche da un sé desolato, attraverso pratiche classiche di rilancio della cura di sé che passano, ad esempio, attraverso la meditazione nel silenzio, nel camminare (tema peraltro caro allo stesso Thoreau che in un altro libro invita l’uomo a ritrovarsi camminando nella casa verde dei boschi), riaffermando il proprio potere di autodeterminazione, di esperienza e movimento nel mondo.
Liberarsi appare comunque sempre più un miraggio, se si pensa all’enfasi con cui il nostro mondo, riassorbendole in chiave feticistica come merce e con ciò neutralizzandone il potenziale critico, accoglie queste indicazioni. Resta tuttavia vero – ci resti almeno il piacere dell’enunciazione – che muoversi, andare, è libertà, scelta, flusso, distribuzione; è sollievo al dolore. Non c’è nulla che accentui il dolore quanto la condanna all’immobilità, alla completa passività e inermità. Jacques Lacan ha tanto ben presente questo fatto da estendere anche alla materia il concetto, quando, confermandone con ciò metonimicamente la validità rispetto all’uomo, giubila di fronte all’esplosione di forme che lo stile barocco consente alla pietra.
Nelle nostre democrazie capitaliste occidentali l’appartenenza alla polis e alle sue regole sfuma in un relativismo etico, nella solitudine autocratica di individui-monadi, col dovere di essere felici e di corrispondere alle aspettative degli altri. Le coscienze sono incupite dall’isolamento, da responsabilità crescenti, dalla stereotipia delle attività individuali a ciclo chiuso di produttori-consumatori. Come si sa, l’inconscio e con lui il desiderio si è esteriorizzato nelle vetrine dei supermercati. Il pensiero si è esternalizzato nelle memorie dei computer, il rapporto individuo-società si ritrova deprivato di mutualità e di senso.
Nella civiltà esiste un disagio, avverte Freud, che è il prezzo da pagare per la condizione di vita nelle sicurezze della polis e non nella ferinità della ingens silva. E gli altri possono sedurci ma anche essere il nostro inferno, come osserva Sartre.
Kafka ci suggerisce di assecondare il mondo per non cadere in un solipsismo im-mondo. Tuttavia la battaglia è dura, il rapporto fra individuo e società è difficile.
Ma quando è cominciato tutto? Quali sono le origini del nostro mondo contemporaneo, cosa l’ha plasmato secondo certe linee di senso, secondo valori e disvalori, cosa ispira il modo in cui siamo chiamati a stare?
Una prima radice del nostro smarrimento potremmo trovarla in quella svolta epocale nella storia umana che Foucault ha descritto, in Le parole e le cose, corrispondente al passaggio dall’età antica a quella che egli chiama età classica, circa a metà del Seicento. Da un universo in cui tramite la divinazione si rintracciava attraverso le cose il disegno di Dio, e un senso superiore della vita, si passa, con la triste emblematica figura del Chisciotte – la geniale creazione di Cervantes –, a una modernità in cui le cose non rinviavano a null’altro che a loro stesse, rendendo necessaria al cavaliere errante la fatica di reinserire il meraviglioso e la lingua della fantasia nella realtà inaridita ed estraniata. Il Chisciotte vive, nella forma della parodia, la tragedia di un uomo rimasto senza mondo. Il cavaliere errante, per averne uno e dare un senso alla sua vita, deve trasfigurare un’osteria in un castello, allucinare mostri nei mulini a vento, proclamare fieramente i suoi ideali cavallereschi a stallieri e vinattieri, consacrare la sua dedizione a fantesche prese per dame regali che lo irridono fingendo di capire e di corrispondere al suo nobile sentire. Il Chisciotte ci rappresenta tutti: scappa dal mondo reale per percorrerne uno più vero e abitabile.

Un altro possibile nodo del nostro diario contemporaneo si può riconoscere nel modo in cui si è costituita ed è stata codificata la rete dei riferimenti della vita associata nella modernità occidentale. C’è un modello originario della vita pubblica e privata che Walter Benjamin nei suoi Passages ha individuato nella città di Parigi e nel suo sviluppo entro i primi decenni dell’Ottocento. Nei meandri di questa metropoli, simbolo dell’Occidente, nei suoi oggetti, nei suoi personaggi, nelle scene in cui il quotidiano, il meraviglioso e l’orrido si rimescolano, c’è l’origine della moda e della fascinazione degli oggetti, del gusto dell’esotico e della novità, delle regole che moduleranno il desiderio delle cose e la loro acquisizione, e reggeranno poi stabilmente fino a oggi i commerci, anche quelli immateriali fra le persone feticizzate come le merci ed esposte nei sontuosi ed esotizzanti negozi dei Passages. Non sono da questo esclusi il lavoro, gli affetti e i modi di legarli ai luoghi e alla storia, al territorio umano e urbano, agli oggetti e al clima, alle bizzarrie del gusto e ai tesori dell’intimità.
Si fugge allora dal mondo alienato, anche quando si rinnega un sé troppo “allineato”. Sembra di dover invertire i termini del titolo dell’interessante e ben noto libro di David Le Breton Fuggire da sé, una tentazione contemporanea (Cortina, Milano 2016).
Vi sono “fughe” che sono débâcles, ritirate, abbandoni all’automatismo mentale, e fughe più interessanti in cui si rivela un’ affermazione liberatoria e un ampliamento di sé, e in cui si mostrano originalità, rarità d’ingegno, il coraggio di una ricerca anche impervia, l’iniziativa e la spinta a esplorare possibilità nuove. E così il discorso si fa via via più ricco e misterioso.
Vi sono casi di radicale trasformazione, in cui l’antico sé, sottrattosi alle passioni di un mondo insensato, è ormai del tutto estraneo al nuovo soggetto. Ne è l’emblema in un racconto di Borges Tzinacàn, il mago della piramide di Qaholom. Questi, prigioniero di una cupa torre insieme a un giaguaro, dopo aver dedicato i lunghi anni di prigionia a scoprire la parola del dio, una formula di quattordici parole che, pronunciata, lo avrebbe liberato e reso padrone del mondo, sceglie invece di morire dimenticato in quelle tenebre, nella nuova dignità di chi ha ricevuto in dono una conoscenza dell'universo tale da fargli dimenticare chi era lui stesso, quell'altro che lui era stato, che cercava il segreto, “perché egli ora è nessuno”.
Si può desiderare di scomparire per divenire altro, si può voler perdere l’identità come sé anagrafico che obbliga a occupare convenientemente una casella e certi ruoli (il nome è morte e la vita è continuo cambiamento, dice il Vitangelo Moscarda di Uno, nessuno, centomila). Fuggire da sé è fuggire dal tempo, e anche in un certo senso dal proprio volto.
A cosa si sottrae infatti chi compie una fuga? Sicuramente anche al volto coi significati che imprime al sé in quanto immagine sociale, in ostaggio al potere. Il volto, quello che compare sulla carta d’identità, è la mappa delle convenzioni del riconoscimento, emana segnali che delimitano lo spazio personale e sociale e in esso le interazioni possibili. Pensiamo di solito al viso come massima espressione, nel linguaggio comune, dell’individualità, ma dobbiamo poi riscoprirne l’aspetto impersonale e inumano. Al punto che «se l’uomo ha un destino», come pensano Deleuze e Guattari, «sarà di sfuggire al viso, disfare il viso [...], divenire impercettibile, divenire clandestino, [...], non lasciarsi più sussumere dal viso».
La dissoluzione delle costrizioni e degli obblighi, lo sfumare dei lineamenti del volto come metafora della fuga dal codice identitario nucleare, apre il soggetto verso gli altri e verso un mondo radicalmente nuovo, nel modo in cui a ciascuno di noi esso può rivelarsi. Ciascuno di noi nel momento prodigioso e semplice in cui, col suo nome senza necessità del cognome, si definisce nel fare con qualcuno in un dato luogo qualcosa. Quando cioè ciascuno di noi, senza bisogno di una definizione sociale, è semplicemente una vita.