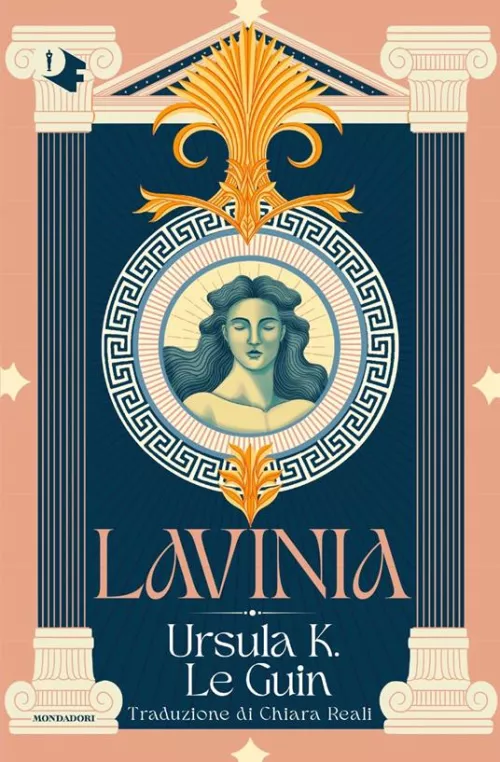Ursula K. Le Guin: caos e altri utensili
Perché Kurt Vonnegut sì e Ursula K. Le Guin no? Me lo domando da tempo, mordendomi letteralmente le mani per quella mia imperdonabile disattenzione. O dovrei dire duplice riflesso condizionato? Negli anni ottanta del secolo scorso abitavo negli Stati Uniti e, un po’ per istinto un po’ seguendo un mio filo, mi capitò di intervistare a lungo e in totale libertà artiste e artisti grandissimi, tra i quali molte scrittrici e molti scrittori. Perché Vonnegut sì e Ursula K. Le Guin no?

Nel 1989, l’anno della caduta del muro di Berlino, conversai a più riprese con lui, che era nato nel 1922, era stato prigioniero di guerra a Dresda – da cui lo straordinario romanzo Mattatoio n. 5 o la crociata dei bambini (1969) – ed era ormai considerato un’icona vagamente d’altri tempi: guerra del Vietnam, diritti civili, liberazione sessuale, fragole e sangue o giù di lì.
Lei, che era nata nel 1929, l’anno del Crollo di Wall Street, non era – è meglio che lo ammetta subito – ancora entrata nel mio radar. Mia colpa, mia massima colpa, ma evidentemente c’è un tempo per tutte le cose e io non dovevo essere ancora pronta per le sue trame spiazzanti che, al riparo di un genere letterario considerato (salvo rare smentite) di serie B – fantascienza e fantasy per ragazzi/e e per adulti –, erano di fatto più acute e illuminanti di molti saggi di sociologia e di filosofia politica.
Ci sono arrivata tardi e per vie misteriosamente indirette, guidata ogni volta da numi tutelari di sesso femminile di fede rigorosamente femminista, da Grace Paley a Robin Morgan, che la consideravano non solo una formidabile scrittrice che se la rideva delle strettoie dei generi letterari, ma una maestra di pensiero, visionaria quanto basta per far saltare le barriere tra scienze ‘dure’ e ‘molli’ e navigare a vista, da esploratrice, nel caos indefinibile e instabile della vita “per come è vissuta, per come potrebbe essere vissuta e per come dovrebbe essere vissuta” (cito dalla magnifica prefazione di Veronica Raimo a I sogni si spiegano da soli. Immaginazione, utopia, femminismo, una selezione di scritti non finzionali di Le Guin, Edizioni SUR 2022).

Prendiamo il ‘tempo’, per esempio: Le Guin ne fa, sia all’interno delle sue trame sia sul piano narrativo, una variabile spaziale. Per lei una buona storia non può andare da qui a lì come una freccia, una lancia, un proiettile o un missile balistico che qualcuno (il narratore? Dio?) lancia in modo che arrivi senza il minimo inciampo a destinazione. Le buone storie sono per lei ondivaghe, frammentarie, perfino confuse, girano in tondo, tornano su se stesse, hanno un movimento spiraliforme, non mirano necessariamente a una conclusione o a un punto di approdo. Eppure in queste storie – che, ammettiamolo, riproducono il tempo reale delle nostre vite – non ci si perde mai, perché lo scopo dell’autrice non è raggiungere un qualche punto fermo portandoci con sé, bensì esplorare e scoprire “un pezzetto alla volta” il terreno su cui si e ci muove. Disorientarsi, lasciarsi depistare, tornare apparentemente al punto di partenza sono tattiche da ricognitrice, non da conquistatrice. La strategia narrativa di Ursula Le Guin è tutto fuorché coloniale.
Quest’anno, a Natale, forse per evitare loro di arrivare in ritardo come me, ho regalato ai miei nipoti adolescenti la sua saga Terramare, un volumone composto di tre romanzi, Il Mago, Le Tombe di Atuan e Il signore dei draghi. Leonardo, quindici anni, lo ha cominciato quella sera stessa e il mattino dopo mi ha spiegato che i libri fantasy sono di due tipi: nel primo tipo c’è un/a protagonista assoluto, che ti fa da guida e in cui tu che leggi puoi identificarti; nel secondo c’è un intero mondo che brulica di presenze, non solo umane e animali, e lì è facile smarrirsi. Credo che Le Guin avrebbe riso soddisfatta. Sì, smarrirsi senza arrendersi come strumento-guida dell’atto narrativo. Far tesoro degli scogli, degli stalli e dei limiti naturali. Perlustrare, non progettare. Porsi domande, un sacco di domande.
Per esempio: come si fa a diventare adulti senza imparare a mangiare la plastica? Oppure, è proprio detto che il sesso coincida con i presunti due generi – femminile e maschile – e con tutte le conseguenze ‘sociali’ che da quel binarismo marmoreo (e tuttavia storicamente malleabile) si fanno derivare? E se la vita fosse uno straordinario apprendistato alla morte e i bambini ne fossero infinitamente più consapevoli dei grandi? Come si fa a raccontare l’impresa del venire al mondo e rimanerci per un certo numero di anni quando “sono in arrivo tempi duri”?

Per la narratrice Le Guin “il realismo è il mezzo meno adeguato per comprendere o rappresentare le incredibili realtà della nostra esistenza. Chi si occupa di fantastico – che utilizzi gli antichi archetipi del mito e della leggenda o quelli più moderni della scienza o della tecnologia – potrebbe discettare, con la stessa serietà o in maniera molto più diretta di chi si occupa di sociologia. Perché in fondo, come hanno affermato le grandi menti scientifiche, e come tutti i bambini e le bambine sanno, è soprattutto grazie all’immaginazione che acquisiamo percezione, compassione e speranza”.
Percezione, compassione, speranza. Atti di immaginazione. Sfondamenti progressivi dei perimetri spaziali e temporali, perché – come direbbe Grace Paley – la vita è fatta di enormi cambiamenti all’ultimo minuto e di continui piccoli contrattempi e richiede l’impareggiabile, modesto talento di non voler capire tutto. Le macrospiegazioni senza incrinature, i grandi sistemi d’ordine senza zone d’ombra, mentono e ingannano. La troppa luce acceca. Ecco perché Le Guin – che, al pari di Virginia Woolf, è anche una sottile teorica femminista – usa il gender (il genere sessuale) per scardinare il genre (il genere letterario) da lei prescelto. Là dove l’ordine si cristallizza, imbrigliando il caos e il caso, deve pur esserci qualcuno che si chiede chi l’ha stabilito, a chi giova e chi esclude, e come si fa a metterlo in discussione senza crearne un altro di segno uguale e contrario.

E lì entrano in campo le linee rette: frecce, lance, proiettili, missili balistici – tutta roba da remoto: ti vedo, ti colpisco, ma non ti tocco – e relativi addetti ai lavori, cacciatori, soldati, guerriglieri, eroi in genere, perlopiù maschi ed evidentemente senza molto altro da fare. Nell’universo letterario, esperienziale e politico della scrittrice di (si fa per dire) fantascienza Ursula K. Le Guin quegli oggettini per lo più appuntiti e perforanti hanno bucato anche la sfera del racconto, colonizzandola attraverso trame uggiosamente lineari perlopiù a protagonista unico, maschio, destinato a nascere-combattere-dare la morte/morire. O, in alternativa, nascere-combattere-dare la morte-tornare a casa-morire. A causa loro Mito e Storia sono macronarrazioni ‘assolute’, che tuttavia inducono a domandarsi: dove mai è andato a finire tutto quello che non c’è o non appare?

A forza di omettere, si finisce per esporsi al dubbio e all’indagine: dove si è nascosto tutto il resto? Cosa c’è fuori scena?
Di nuovo i bambini evocati spesso da Le Guin, con i “loro occhietti limpidi, gelidi e sfavillanti”: chi gliele ha costruite le piramidi ai faraoni? Quanti uomini ci sono voluti per costruire il cavallo di Troia e quanti alberi sono stati abbattuti per far arrivare fino a noi quella formidabile macchina da guerra? C’erano donne da quelle parti o sempre e solo donne-pretesto come Elena o donne-servizio come Penelope?
Ed eccoci a Lavinia, di cui nessuno sa niente perché nell’Eneide, il grande poema epico latino che dovrebbe mettere in ombra l’Iliade di Omero, il nostro Virgilio si è scordato di darle un corpo e una storia, limitandosi ad attribuirle una funzione. Che cosa fa, nel 2008, Ursula K. Le Guin con questo personaggio impalpabile come un venticello primaverile o una lieve foschia? Lo mette al centro di un romanzo altrettanto epico, Lavinia (trad. it. di Chiara Reali, Mondadori 2023), affidandole la responsabilità del racconto. I critici l’hanno definita un po’ sbrigativamente una riscrittura degli ultimi sei libri dell’incompiuto poema virgiliano, con capovolgimento del punto di vista in chiave femminil/femminista. Sì, anche, senza dubbio. Ma c’è molto di più: insieme a Lavinia, Le Guin si tuffa nelle tenebre fitte di un passato perfino più oscuro del futuro anteriore in cui ‘accadono’ i suoi romanzi fantasy e fantascientifici. Il passato, come scriveva Roland Barthes a proposito di una fotografia della madre da piccola, è infinitamente più misterioso del futuro. Comporta un atto di immaginazione che deve fare i conti non solo con le macerie e i frammenti di realtà sopravvissuti, ma con l’emozione con cui li rinveniamo. Esporsi al passato è precipitare in un presente più denso.
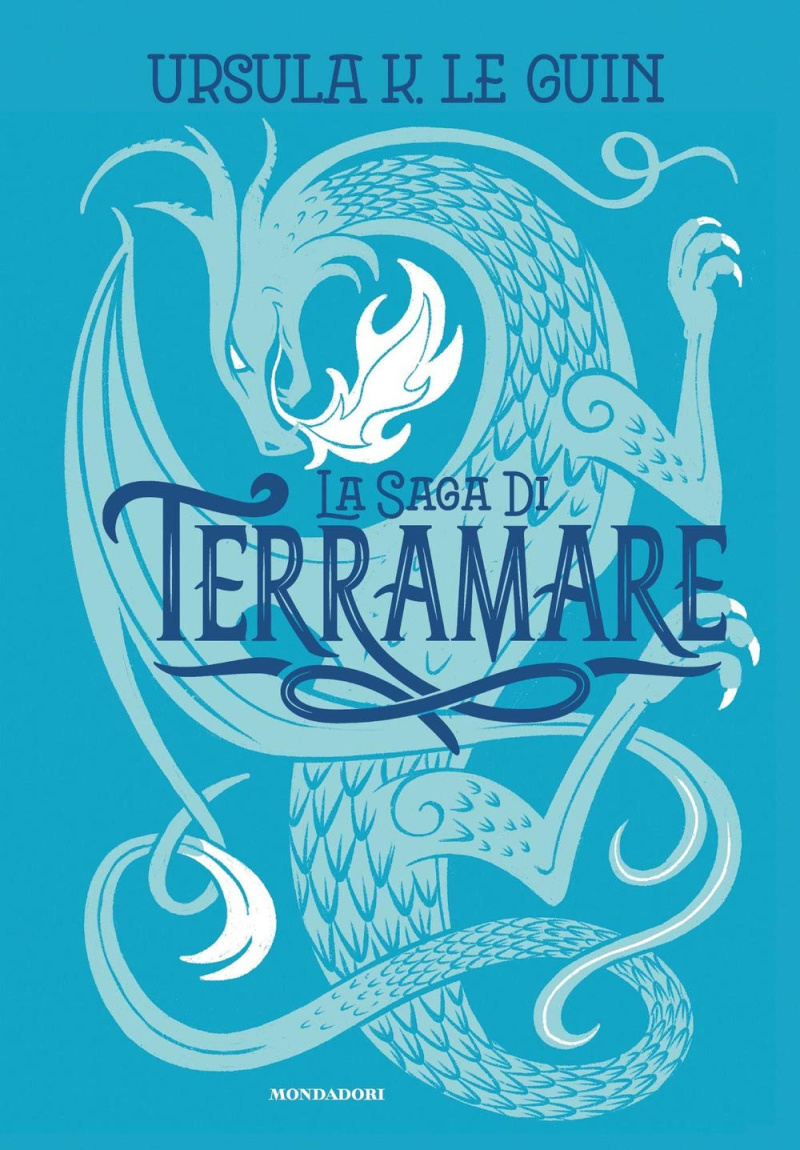
Si tratta dunque di “ascoltare il silenzio”, mettendosi “in ascolto di una voce”. Con la consapevolezza che, se le parole non hanno un corpo, la storia non c’è. Trovare quella voce ‘incarnata’ è un’arte da trickster, da scompaginatrice dell’ordine, insofferente alle dualità che spaccano il mondo secondo linee spaziali, sociali, temporali fittizie. Nell’universo di Le Guin il sesso non coincide con il genere e il dopo può essere il prima, il qui l’altrove e il da nessuna parte in ogni luogo. Immergersi nei suoi romanzi è un buon antidoto alle schematizzazioni narrative e mediatiche che ci vorrebbero tutti allineati, laboriosi e storditi come i sette nani piccone-in-spalla di Biancaneve. Per lei il cardine dell’atto di narrazione è il ‘se’, particella dubitativa che schiude mondi, invitando a fare ipotesi, a smentirle, ad avanzarne altre ancora.
In Quelli che si allontanano da Omelas, un folgorante racconto breve scritto nel 1973, l’ipotesi (o l’interrogazione?) propostaci da Le Guin è la seguente: “Se la felicità di un’intera comunità dipendesse da un solo essere condannato a una vita infelice, che cosa accadrebbe?”
A noi rispondere, se possibile con qualche onestà e senza retorica.