Speciale
Il regno infernale di Colonia Dignidad
La storia di Colonia Dignidad non è finita con l’arresto del pedofilo che l’ha fondata nel 1961. Nemmeno con i processi ai responsabili o con la conversione del lager nella holding Villa Baviera: azienda avicola e forestale, laboratorio di strudel e pane che rifornisce i centri commerciali più esclusivi di Santiago e albergo con tetti spioventi in mezzo a un gigantesco parco, sentieri per ciclisti e ristorante. Le ombre del passato sono troppo lunghe per essere spazzate in pochi anni, e permeano di sé la vita degli abitanti e i luoghi, per quanta volontà vi abbiano messo nel cambiarli.
Soltanto dopo l’uscita del film Colonia la storia di quel centro è stata divulgata al mondo. Benché opera di fiction con lacune e imprecisioni, il film ha raccontato per la prima volta una storia che sembra inverosimile: per quasi quarant’anni Colonia è stato il regno pedofilo del tedesco Paul Schäfer, ex militante della Gioventù Hitleriana e fondatore di una setta parareligiosa in Germania, i cui fedeli più accaniti e un gruppetto di gerarchi lo seguirono nel Sud del Cile, attirati dalla promessa di dar vita a un mondo nuovo, un’enclave di quindicimila ettari che acquistarono in una zona isolata con campi e fiume fino alla cordillera. Erano in gran parte contadini ignari, che sotto la direzione di quel guru dall’occhio di vetro si misero a lavorare la terra, costruirono due grandi case e un ospedale pediatrico e non si accorsero, o la accettarono, della deriva che aveva preso quella enclave e delle regole perverse che imponeva il capo: gli uomini dovevano vivere con gli uomini, le donne con le donne.
 Paul Schäfer.
Paul Schäfer.
Niente televisione, né telefono. Si lavorava quindici ore al giorno, e da mangiare c’era poco. Le famiglie furono separate, i bambini divisi dai genitori. Vietati i rapporti sessuali, e anche innamorarsi. Soltanto Schäfer aveva diritto al suo inconfessato, ma noto a molti, paradiso sessuale: quei bambini che convocava nelle sue stanze, a turno, per violentarli dopo averli sedati e di cui controllava con paranoia il comportamento. Per chi non era abbastanza compiacente c’erano torture e botte, ma chi non lo era, alla fine? “Siamo stati abusati quasi tutti. Ci facevano credere che fosse l’unica vita possibile, ma soprattutto che Schäfer fosse Dio, e che quegli abusi fossero previsti dalla Bibbia”, mi racconta Efrain Veuhoff, che oggi ha 49 e vive e lavora a Santiago, non si è mai fatto una famiglia perché non è riuscito, dice, a reagire al trauma. Efrain è una delle vittime che hanno denunciato Schäfer ma non è stato risarcito per gli abusi, così come i coetanei Franz e Dieter: quest’ultimo così provato dalle punizioni e dagli elettrochok che non è più in grado di lavorare, a quanto ci racconta l’avvocato Hernán Fernández che lo rappresenta in giudizio ma è scoraggiato dalla mancanza di collaborazione dello Stato, dal menefreghismo, e dalla zona d’ombra in cui sono finite quelle storie, coperte da colpe e collusioni. Grazie alla solida amicizia con Pinochet e a protezioni non del tutto chiare Colonia era diventata, sotto il regime, un campo di concentramento della Dina, specializzato in sofisticate torture e sparizioni, e in metodi tecnologici di sorveglianza e intercettazione. Eppure, fu proprio dopo la fine della dittatura che Schäfer visse il suo periodo d’oro, dal ’91 al ’96. Il primo presidente democratico Patricio Aylwin aveva cercato di far chiudere Colonia, ma il suo governo non fu abbastanza forte e il vecchio criminale aveva protezioni altissime tra giudici e politici.
Processi farsa liquidavano con un nulla di fatto le prime denunce, e chi assolveva Schäfer veniva promosso. Incoraggiato dall’impunità, il guru decise di estendere il suo inferno pedofilo ai ragazzini locali di famiglie povere, che attirava a Colonia con la scusa di farli studiare. Onoratissime per l’attenzione di quel signore distinto e dagli occhi chiari, amico di una parte dell’establishment, i genitori dei bambini difesero Schäfer quasi fino alla fine contro carabinieri e polizia, e picchettavano la strada che portava al lager quando arrivavano le forze dell’ordine mandate dal Governo, marciando con cartelli con su scritto: “Giù le mani dal nostro ospedale”. Per inciso, il direttore dell’ospedale era quell’Harmut Hopp che, condannato in contumacia e oggi serenamente libero in una cittadina della Germania senza aver fatto un solo giorno di carcere, curava in effetti i bambini del posto, ma ne mandava una parte a dilettare Schäfer , usandone altri come cavie.
Presente e passato si accavallano per gli abitanti di Villa Baviera: 139 ex coloni e i loro figli che vivono nelle casette intorno o nel locale per gli anziani dove non mi è permesso entrare. “Ci vuole un’autorizzazione speciale e inoltre sono molto vecchi, potrebbe turbarli”. Alcuni li vedi in giro, le donne indossano cuffiette bianche e scarponi da uomo, gli occhi celesti si abbassano spauriti quando le saluti. L’esodo dei coloni è avvenuto per scaglioni, con il tempo: pochissimi sono riusciti a scappare ai tempi di Schäfer, ma quello che raccontarono ai media sembrava troppo inverosimile per essere creduto. La fuga vera, e ufficiale, cominciò nel 1997, quando le denunce cominciarono a diventare troppe e Schäfer decise di scappare in Argentina dove lo arrestarono nel marzo del 2005, in una casa in cui viveva con la figlia adottiva e qualche fedelissimo. Soltanto dopo la sua fuga i coloni più giovani, nati nel lager o che vi avevano abitato fin da bambini, scoprirono che la realtà, la vita era diversa da quella che avevano conosciuto. Per esempio impararono cos’era il sesso, come nascevano i bambini, che innamorarsi non era peccato mentre lo era la tortura.
Qualcuno non riuscì a integrarsi e tornò a Colonia, che a quel punto cercava di diventare un posto normale. Si mise a lavorare nella holding o nell’albergo, come guida o cameriere. Nei miei tre giorni a Villa Baviera ho incrociato persone che si schernivano terrorizzate quando cercavo di fare domande e qualcuno che ha parlato, ma anche di questi ultimi non capivo in che misura fossero vittime innocenti o imboccati. Bugie e soprusi si incrociano, ingarbugliandosi. “Non sapevamo niente della vita fuori, per noi l’unica realtà possibile era questa”, mi dice Erika Tymm, 56 anni, capelli biondi e il forte accento tedesco di chi ha imparato lo spagnolo da adulto. “La nostra vita di bambini era lavoro nei campi, poco cibo e l’allegria dell’infanzia. Poi, molti venivano abusati. Mio marito, per esempio. Un giorno, eravamo già sposati, è scoppiato a piangere e mi ha detto: “Mi sono ricordato all’improvviso, Schäfer mi ha violentato”"". Il marito di Erika si chiama Gunter Schaffrik e pare si sia trasformato da vittima in carnefice, visto che sta scontando una condanna a undici anni per aver reclutato bambini cileni su incarico di Schäfer. La moglie va a trovarlo una volta alla settimana, e giura sulla sua innocenza. Si sono sposati a 44 anni. Fino ad allora, e per molti mesi dopo, la donna non aveva idea di come nascessero i bambini. L’avvocato Fernández assicura non solo che Gunter è colpevole, ma che Erika era perfettamente al corrente di quelle attività.

Anche a non sapere niente del passato, Villa Baviera ha un che di inquietante nonostante l’aspetto casereccio da Oktoberfest, le file di botti intorno alla casa principale, i tetti spioventi e le grandi farfalle in ferro su cui campeggiano scritte di benvenuto in tedesco. Decine di piantine decorano l’esterno, le molte stanze e localini sono addobbati con pianoforti e cesti, centrini ingialliti, tendine casalinghe. A buttare una luce ostile sono sia quei quaranta chilometri che, nell’ultima metà della strada, sono sterrati e faticosi e corrono tra paesaggi spogli e abbandonati, l’ex guardiola e i campi un tempo minati, sia le decine di fotografie dei ragazzini in gruppo alle pareti del ristorante, e gli indumenti per bambini, piccoli loden e cappellini, gilet minuscoli appesi al muro in un' esibizione che sembrerebbe sadica non fosse che quel posto, il ristorante, è il cuore dell’albergo, il fiore all’occhiello, il segno visibile della trasformazione da lager in un luogo decente, molto ben recensito su trip advisor. Soltanto la camera di Schäfer non è fotografabile, il resto è aperto a tutti: le stanze affacciate sui corridoi coperti di moquette rossa e il seminterrato attraversato da cunicoli e la torretta da cui si controllava chi entrava e usciva. I bunker non si vedono, sono molto più in là, chissà dove. “Mia moglie mi ammazza”, mi dice scuotendo la testa Hans Schreiber, 44 anni, uno dei responsabili della Holding Villa Bavier quando, dopo che l’ho tacchinato per due giorni per intervistarlo, decide di accettare. “Sei mesi fa non avrei mai accettato di parlare con un giornalista straniero”. È simpatico e il suo spagnolo è perfetto, dice cose sensate e sembra sinceramente interessato ad aiutare la giustizia e a fare il bene dei coloni. Suo padre era uno del cerchio magico di Schäfer, ma su questo glissa.
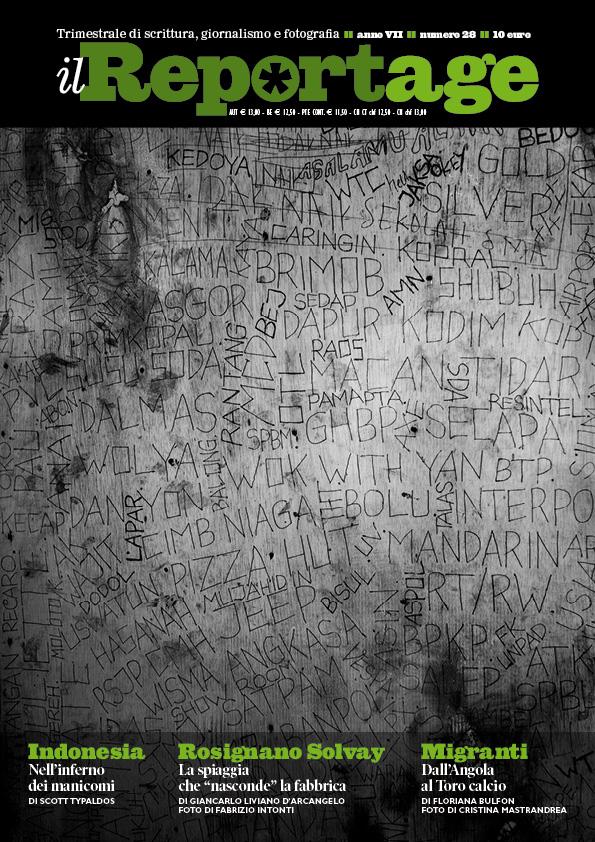
Reportage n. 28 (ottobre-dicembre 2016)
Glissa parecchio anche sugli abusi, dice come tutti gli altri: “Questo era l’unico mondo che conoscevamo, per noi era bello e buono perché non avevamo termini di paragone”. Quando però incontro Margarita Romero, a Santiago del Cile, presidente della Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, fa un salto sulla sedia appena le nomino Hans. “Sa che ha cercato di comprare il silenzio dei coloni con i giornalisti in cambio di terre?”, mi rivela. L’Associazione è nata per far conoscere la verità e per ottenere che la ex Colonia diventi monumento nazionale, una richiesta che ha ottenuto di recente il placet del Consejo de Monumentos. Motivo del riconoscimento non sarebbero tanto gli abusi quanto il ruolo criminale che ha svolto il lager durante il regime. La sorella di Margarita, mirista, è passata per Colonia, così come lo psichiatra Luis Peebles, anche lui membro dell’associazione. Torturato con estrema crudeltà, il medico si salvò per miracolo e quando venne liberato scappò in Belgio dove conobbe Margarita e insieme decisero di fondare quell’organizzazione che sta dando filo da torcere ai figli dei gerarchi. Tornato dal Belgio, a dittatura finita, capitò a Peeble di reincontrare Schäfer, 83enne e in sedia a rotelle, prima del processo in cui avrebbe dovuto testimoniare contro di lui (aveva riconosciuto la voce del pedofilo mentre veniva torturato, bendato). Sapeva che era ipocondriaco e gli chiese: “La vedo pallido, le è salita la pressione?”, per poi aggiungere: “Lei mi conosce, no? Visto che mi ha torturato”. E quello, omuncolo fino alla fine, si mise a strillare: “Non so niente di torture, niente, io non c’entro”.










