Gershwin: una Rapsodia lunga cento anni
Il 12 febbraio 1924 a New York minacciava neve. Questo non impedì che nel pomeriggio i 1.100 posti della Aeolian Hall – rinomata sala da concerto ubicata in un grattacielo di 18 piani nel cuore di Manhattan, sede della omonima fabbrica di pianoforti e strumenti musicali – fossero tutti occupati. Fra il pubblico, divi della musica classica in America come il direttore d’orchestra Leopold Stokowski, i violinisti Jascha Heifetz e Fritz Kreisler, il pianista e compositore emigré Sergej Rachmaninov, fuggito dalla Russia rivoluzionaria solo pochi anni prima. In programma c’era un concerto intitolato “An Experiment in Modern Music”. L’evento si inseriva nello straordinario e innovativo fervore musicale che percorreva il mondo artistico e culturale della metropoli americana, in un periodo che i contemporanei già chiamavano “Età del Jazz”. Una definizione consacrata fin dal 1922, quando erano stati pubblicati gli omonimi racconti di Francis Scott Fitzgerald.
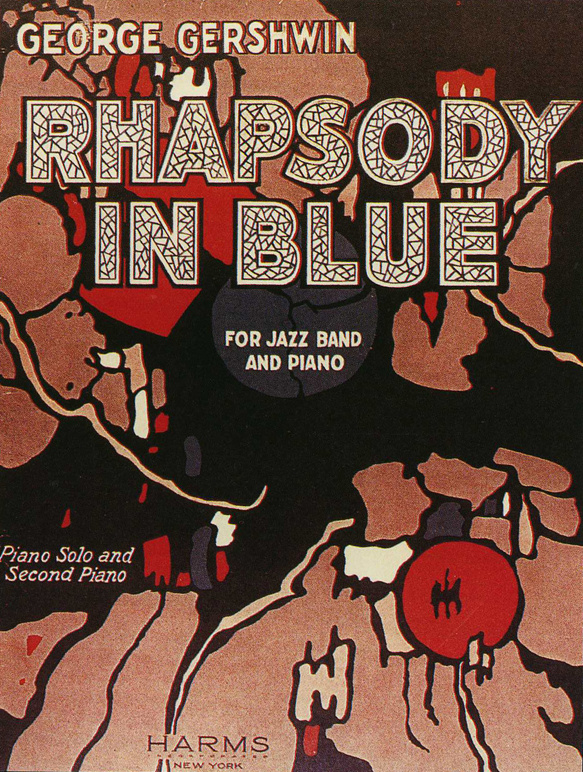
Di fatto, la locandina era un guazzabuglio di pezzi per lo più ballabili e comunque di carattere “popolare”, opere di autori oggi semi-sconosciuti nelle quali il jazz finiva in un certo modo “normalizzato” e utile alle esigenze commerciali di chi aveva organizzato il tutto, il leader della “Palais Royal Orchestra”, Paul Whiteman (1890–1967). Originario del Colorado, questo musicista assai abile negli affari aveva capito ancora giovane che suonare la viola in qualche orchestra (lo aveva fatto anche nella San Francisco Symphony) non lo avrebbe portato da nessuna parte, mentre diventare direttore e manager di big band sulla East Coast lo avrebbe fatto diventare ben presto milionario. A quell’epoca lo era già.
L’unico brano del programma di quel concerto che poteva effettivamente essere considerato un “esperimento” era quello per pianoforte e big band che Whiteman aveva appositamente commissionato a George Gershwin. Ed era per quello che la curiosità era così alta: il venticinquenne compositore nato a Brooklyn da immigrati ebrei russi, che avevano lasciato la madrepatria a fine Ottocento per sfuggire alle persecuzioni razziali, era già sulla cresta dell’onda per una serie di straordinarie canzoni, fra le quali la popolarissima Swanee, brano seducente e brillante che lo aveva lanciato a Broadway. E si era anche segnalato, un paio di anni prima, per un’opera da camera sperimentale in un atto, Blue Monday, nella quale peraltro le sue prime ambizioni colte avevano dovuto fare i conti con una chiara bocciatura del pubblico.
Per il brillante pianista e “songster” newyorkese quel debutto era quindi per vari motivi cruciale, una sorta di prova del fuoco. La sua Rhapsody in Blue, come s’intitolava il pezzo, fu presentata quasi alla fine, seguita soltanto, per strano che possa sembrare, dalla sussiegosa Marcia Pump e Circumstance n. 1 dell’inglese Edward Elgar, risalente a quasi un quarto di secolo prima.
Il successo fu immediato, reso trionfale anche dalla brillantissima prova dell’autore al pianoforte. Nasceva quel pomeriggio uno dei miti della musica americana del Novecento, all’incrocio fra colto e popolare. A un secolo di distanza, l’apprezzamento del pubblico non accenna a diminuire.

La Rapsodia fu composta nel giro di qualche settimana e completata il 7 gennaio 1924, data apposta dallo stesso Gershwin sul manoscritto. Il musicista non realizzò la strumentazione ma scrisse – oltre alla parte del solista – l’accompagnamento “condensato” su due pentagrammi. La trascrizione per big band era pronta il 4 febbraio, firmata dall’arrangiatore di fiducia di Whiteman, Ferde Grofé (1892–1972), al secolo Ferdinand Rudolph von Grofé, figlio di un baritono tedesco che aveva cercato fortuna a New York. Il suo nome segue la storia di questo caposaldo della musica del Novecento: a Grofé si devono infatti gli altri due arrangiamenti principali della Rapsodia, uno per “orchestra da teatro” nel 1926 (pensando evidentemente agli organici di Broadway) e uno per orchestra sinfonica tradizionale, messo a punto nel 1942. Per molti decenni, quest’ultima è stata la versione di riferimento nelle esecuzioni in tutto il mondo, e rimane largamente praticata. La versione originale fu recuperata alla fine degli Anni Settanta dal direttore d’orchestra Michael Tilson Thomas ed è a sua volta diventata di uso corrente.
L’attacco, si sa, è folgorante. Quelle celeberrime note sono diventate un’icona sonora che resiste al tempo e all’inflazione degli utilizzi multimediali (un simbolo dell’Età del Jazz, di Manhattan, dell’America in generale), tanto da indurre qualche studioso a delineare un parallelo – per universalità, o quanto meno per riconoscibilità – con l’inizio della Quinta Sinfonia di Beethoven. Eppure, il caratteristico “glissando” del clarinetto subito dopo il trillo d’apertura non fu un’idea di Gershwin, ma del musicista a cui erano affidate le battute iniziali. Si chiamava Ross Gorman (1890–1953) ed era un polistrumentista di valore, che nella band di Whiteman oltre a vari tipi di clarinetto suonava anche l’oboe e sassofoni assortiti. Lo spunto gli venne durante le prove e il compositore – che aveva scritto una scala ascendente lunga più di due ottave, in tutto diciassette note staccate – ne fu subito entusiasta.
A volerla banalizzare, la trovata può sembrare l’escamotage di un esecutore che si avventura per quelle scale ma fatti pochi gradini preferisce un’altra soluzione. È tuttavia improbabile che Gorman avesse in mente di semplificare. Anche perché tecnicamente non è questo il caso. Semmai, è plausibile che si sia immedesimato nel concetto “sperimentale” del concerto, e per questo abbia proposto questa modalità esecutiva in quel passaggio. Per certi aspetti, la sua intuizione testimonia lo spirito jazz con il quale la Rapsodia venne accolta dai suoi stessi primi interpreti. E l’inamovibilità di questa soluzione un secolo dopo è diretta conseguenza della brillantezza dell’invenzione esecutiva del primo giorno.
Nella prospettiva storica, l’elemento di maggiore interesse è dato dalla “procedura” creativa. Nello scrivere questa Rapsodia – una forma, sia pure libera, tipica della musica colta nell’Ottocento – Gershwin partiva infatti dal congeniale stile popolare per affrontare il genere cosiddetto della “concert music”, protagonisti un’orchestra e uno strumento solista di alto lignaggio come il pianoforte. Lo scopo era realizzare qualcosa che doveva uscire sia dai teatri di Broadway che dalle sale da ballo o dai fumosi locali dove il jazz muoveva i primi passi, per approdare ai luoghi deputati della musica “alta”, senza però nascondere o tradire le proprie origini. Si trattava di un orientamento opposto a quello adottato in quello stesso periodo da vari compositori colti, in Europa (Ravel, Stravinskij e Milhaud su tutti, ma non solo loro) e in America (Aaron Copland). Affascinati dalle nuove tendenze della musica americana, costoro avevano preso a prestito – per alcuni loro brani – moduli ritmici e armonici più o meno di carattere jazzistico, inserendoli all’interno delle forme tradizionali abitualmente praticate e attentamente conservate. Un’operazione sofisticata ma parziale e condotta “a freddo”, destinata a essere ben presto accantonata.
Con la Rhapsody in Blue, Gershwin faceva se non il primo, il principale passo in direzione della “grande musica” da quando, diciottenne, aveva cominciato la sua attività compositiva. Affrontava il viaggio con il bagaglio del suo tipico linguaggio musicale, fatto di invenzione melodica strepitosa, di senso vivissimo del ritmo e delle sue articolazioni comunicative, soprattutto di un gusto armonico molto personale, pieno di sfumature e inquietudini espressive, ovvero di “blue notes”, note dissonanti. Il titolo, peraltro, non fa riferimento a questo significato: fu suggerito al compositore dal fratello Ira Gershwin, l’autore dei testi della maggior parte delle sue canzoni, dopo aver visitato una mostra del pittore americano James McNeill Whistler.

La rotta così brillantemente iniziata, in realtà non sarebbe mai veramente giunta in porto e dopo quel formidabile esordio ci sarebbero state prove creative più problematiche, per quanto di enorme interesse, come il Concerto per pianoforte e orchestra in Fa (1925), il poema sinfonico Un americano a Parigi (1928), la Rapsodia n. 2 per pianoforte e orchestra (1931). Nello stesso periodo, si sarebbero infittiti gli incontri con i grandi della musica europea (Berg, Stravinskij, Ravel, Prokof’ev, la grande didatta Nadia Boulanger), il più delle volte contraddistinti dal tentativo sempre frustrato di ottenere da loro gli insegnamenti necessari per considerarsi davvero ed essere accolto nell’empireo della musica classica. Significativamente, questi incontri si concludevano quasi sempre con l’invito a Gershwin a non rinunciare alla propria personalità e alle proprie caratteristiche creative. Attestazioni di stima più o meno sincere, sottese peraltro a un dato di fatto incontrovertibile: il musicista americano che non aveva compiuto studi regolari godeva di un successo autenticamente popolare, che fra l’altro lo aveva reso ricchissimo. Emblematico il caso proprio della Rapsodia. È stato calcolato che nel decennio fra il debutto e il 1934 solamente questo pezzo gli fruttò fra diritti d’autore, proventi per la vendita delle edizioni musicali e di registrazioni di vario tipo una somma superiore ai 250 mila dollari, equivalenti oggi a oltre quattro milioni.

Pur essendo un blocco unitario, la Rhapsody in Blue si configura idealmente secondo la forma tripartita del Concerto per pianoforte classico, con un movimento lento centrale a separare i due Allegri che aprono e chiudono la composizione, il primo suggellato da una tradizionalissima cadenza dello strumento solista. Melodia, ritmo, armonie “sporche” la fanno da padrone, e non mancano nemmeno rimandi tematici che configurano una sorta di “circolarità” dell’invenzione, con i seducenti motivi dell’inizio che ritornano alla fine. Quanto al jazz, è abbastanza evidente che le allusioni rag e le “blue notes” ne offrono più che altro la “sensazione” (cioè quel che cercava Whiteman): la musica nera che da New Orleans stava cominciando a conquistare New York era qualcosa di molto diverso. In larga misura mancano, invece, gli sviluppi, cioè l’elaborazione dei pur bellissimi temi, dal Settecento principio cardine dello scrivere musica colta in Occidente. Qualche decennio più tardi sarebbe stato questo il principale addebito di Leonard Bernstein al collega nato vent’anni prima di lui.
La parte per lo strumento solista, il pianoforte (del quale Gershwin era un riconosciuto virtuoso professionale e mondano, sempre disponibile a sedersi ovunque alla tastiera), è brillante e coinvolgente, ritmicamente trascinante. Vi domina la vera vocazione creativa di questo compositore, la trasformazione dei temi. Si ascoltano Variazioni piene di fantasia, improvvisazioni si direbbe in gergo jazzistico, in realtà accuratamente definite nella Rapsodia e nella maggior parte delle opere strumentali, fino alle spettacolari Variazioni su “I Got Rhythm” per pianoforte e orchestra, che risalgono al 1934. Un modo di condurre il discorso musicale per farlo sembrare estemporaneo anche se non lo è, tenendolo sempre saldamente ancorato ai punti di partenza melodici.
Più tardi, sarebbero arrivate le sofisticate rivisitazioni della musica africana-americana in chiave colta, indubitabilmente “bianca” e secondo tradizione operistica europea, contenute in Porgy and Bess (1935). Un lavoro capitale nel teatro per musica della prima metà del Novecento, ma un successo neanche alla lontana comparabile con quello delle opere strumentali e delle canzoni. Fermo restando che alcune melodie dell’opera, a partire da Summertime, fanno parte fin dal loro primo apparire del mondo sonoro dell’Occidente contemporaneo. Come del mondo jazz fanno parte, nel ruolo di “standard” continuamente rivisitati, decine di sue canzoni. Un giacimento senza pari per bellezza, eleganza, profondità.
Nato il 26 settembre 1898, Gershwin morì a 38 anni, l’11 luglio 1937, dopo un disperato tentativo dei medici di intervenire chirurgicamente su un tumore al cervello che si era manifestato solo pochi mesi prima. Si trovava a Hollywood: aveva firmato un contratto per la RKO Pictures e stava entrando decisamente nel mondo della musica da film. Prima di partire aveva detto alla sorella Frances: «Ho la sensazione di avere appena raschiato la superficie di quello che voglio veramente fare». In quel periodo era vicino di casa di Arnold Schoenberg, illustre immigrato in fuga dal nazismo. Ne era diventato amico e lo invitava spesso a giocare a tennis, comune passione, sul campo della lussuosa villa con piscina che aveva preso in affitto. Dopo la sua scomparsa, l’inventore della dodecafonia gli tributò un epicedio forse sorprendente ma profondo: «Mi sembra che Gershwin sia stato indubbiamente un innovatore. Ciò che ha creato con il ritmo, con l’armonia e la melodia non è esclusivamente un fatto stilistico […] Melodia, armonia e ritmo non sono saldati insieme, ma colati in un unico stampo».
La musica del XX secolo ha perso quello stampo troppo presto.









