
Speciale
Hans Sahl, esule dimenticato
«Già, quella era New York, che ardeva nella calura mattutina di un’umida giornata di agosto, traspirante, gocciolante, nuda. Bisognava sentirla sulla pelle, New York, percorrendo quelle strade dense di vapori, sentire quel vibrare di milioni di corpi umani, quel miscuglio di caldo, affanno e lavoro, bisognava sentirlo in ogni arto e scoprire all’improvviso quanto fosse bella: alla sua maniera cruda, anzi crudele, e però bella».
Nell’originale – l’originale tedesco – queste poche righe sono ancora più intense. Mi toccarono il cuore appena lette. Ero arrivato a pagina 343 del romanzo, all’inizio del capitolo 5 del Libro quinto, e fui come trafitto: di questo testo mi ero innamorato. Non perché io fossi, a prescindere, un partigiano o un laudatore di New York e delle sue atmosfere. No, il mio cuore ne fu touché perché in queste due frasi mi apparve concentrata l’inquieta bellezza dei pensieri di Georg Kobbe, esule tedesco scacciato dall’Europa, tra l’attrazione per la nuova patria impostagli dalla Storia e la consapevolezza che la sua Heimat, la terra natìa, era rimasta al di là dell’oceano. Questa sintesi drammatica di avventura e nostalgia mi ha turbato, a tratti commosso, fin da quando mi sono imbattuto – con colpevole ritardo – nell’autore: Hans Sahl.
La scena con cui ho aperto questo articolo si svolge nella parte bassa di Manhattan, di fronte al fiume Hudson, nella cruciale estate del 1944, «quando la città viaggiava a luci spente e tende tirate nella notte, nella guerra, nell’incertezza». Kobbe, lo scrittore antifascista costretto a emigrare dopo la presa di potere nazista a Berlino, è in trepidante attesa. È in attesa di capire se potrà, a guerra finita, tornare in Europa. O se, come accadrà all’autore del romanzo, fortemente autobiografico, New York resterà ancora a lungo la sua patria di riserva, o di consolazione.
Sto parlando di I pochi e i molti. Romanzo di un’epoca del giornalista e poeta ebreo tedesco Hans Sahl (Dresda 1902 – Tubinga 1993), prima edizione italiana da me curata per Sellerio, Palermo 2023. È il quindicesimo libro di letteratura tedesca da me tradotto, ed è quello che più mi ha soddisfatto, sia per l’altezza della sfida, davvero impegnativa, sia per l’esito complessivo della versione nella nostra lingua. Ne scrivo anzitutto per omaggiare uno scrittore che in Italia è stato a lungo trascurato: non fosse per Sellerio, appunto, che pubblicò quasi trent’anni fa la sua autobiografia, L’esilio nell’esilio, traduzione di Ingrid Harbeck (Palermo 1995), e per la germanista Nadia Centorbi, che ne tradusse le poesie in Mi rifiuto di scrivere un necrologio per l’uomo (Del Vecchio, Roma 2014). E in secondo luogo perché mi è rimasta una sensazione di amarezza: i media e i lettori italiani – se posso permettermi – non mi sembra abbiano colto appieno il valore di questa riscoperta.

Tradurre per innamoramento è un privilegio – non voglio dire raro, ma infrequente. Quante volte, nella vita, un traduttore letterario si trova a dover eseguire un mandato: c’è un testo non scelto da lui, e una richiesta dell’editore. Quanto è stato diverso e felice il caso mio, il mio incontro con Hans Sahl, nato Hans Salomon a Dresda agli albori del secolo breve, da famiglia ebrea borghese fortemente assimilata, con genitori amanti della musica, della letteratura e della lingua tedesca: prima patrioti nella Grande guerra, poi emarginati e perseguitati con l’avvento di Hitler, della Seconda guerra mondiale, della Shoah.
Prevengo la domanda: è stato impegnativo tradurre l’unico romanzo di Sahl (che uscì in Germania solo nel 1959, parecchi anni dopo la fine della guerra)? Sì, lo è stato. Ma è stato soprattutto un piacere profondo.
E prima ancora ho provato un enorme rispetto: verso la biografia dell’autore. Non era la prima volta che affrontavo un testo della Exilliteratur, la letteratura mitteleuropea dell’esilio, di quegli autori tedeschi, austriaci, cechi, cristiani o ebrei, appartati umanisti o coraggiosi antinazisti, che furono costretti alla fuga dalle minacce politiche o dalle persecuzioni razziali. Ho tradotto per diversi editori – Einaudi, Neri Pozza, Keller – altri autori di lingua tedesca dell’esilio: Lion Feuchtwanger, Erich Maria Remarque, Bruno Frank. Ebbene, la vicenda dell’esule Hans Sahl ha toccato in me corde ancor più profonde.
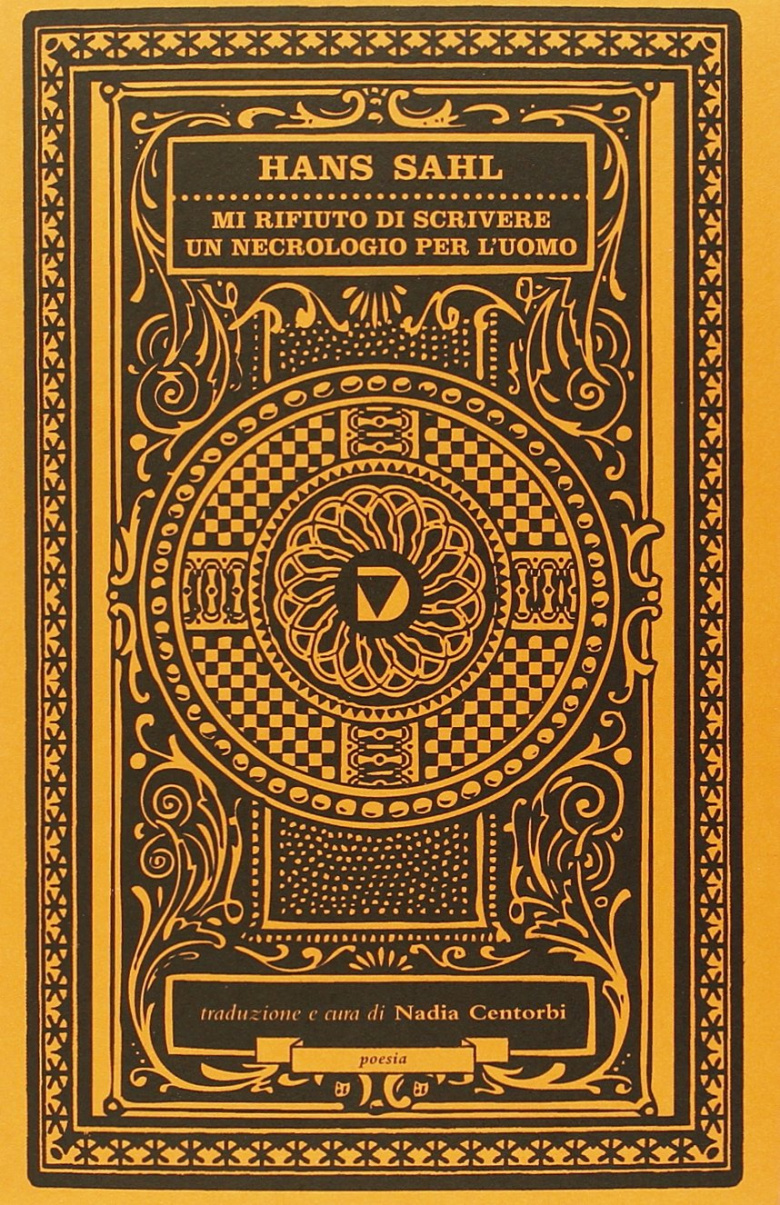
È importante ricordare che, come il suo eroe-antieroe Georg Kobbe, nel mese di marzo del 1933, anche Sahl, finito sulle liste della Gestapo, dovette fuggire da Berlino precipitosamente; e il caso volle che si trovasse lo stesso giorno sullo stesso treno di Max Reinhardt, il celebre regista teatrale. Si rifugiò prima in Cecoslovacchia, poi ad Amsterdam, poi a Parigi, dove rimase fino al 1940, quando la Francia subì l’invasione-lampo della Wehrmacht, con il tracollo delle proprie truppe e l’immediata occupazione tedesca. Rinchiuso in un campo d’internamento, tra centinaia di profughi, scappò a piedi verso il Sud della Francia; da Marsiglia nel 1941 attraversò i Pirenei, la Spagna e il Portogallo fino al porto di Lisbona, da dove infine si imbarcò per gli Stati Uniti. Senza dimenticare – e la storiografia finora non lo ha messo in risalto quanto merita – che Sahl, tra il 1940 e il ’41, proprio a Marsiglia collaborò a lungo con l’intrepido giornalista americano Varian Fry, l’agente dell’Emergency Rescue Committee supportato da Eleanor Roosevelt, organizzazione clandestina che correndo gravi rischi riuscì a portare in salvo quasi duemila tra scrittori, artisti, scienziati della Mitteleuropa minacciati dalla barbarie nazista. Né si dimentichi che, da Walter Benjamin a Stefan Zweig, molti furono i suicidi per disperazione, molti altri i profughi catturati dalle forze collaborazioniste francesi o dagli agenti nazisti in Francia, e inviati nei lager. Come ho detto, il rispetto per la biografia dell’autore è stato un elemento determinante.
Una volta confrontatomi con il testo letterario, le difficoltà si sono presentate quasi tutte insieme. Un primo punto è stato l’asse geografico-temporale della narrazione. Un asse piuttosto complesso. La primissima parte del romanzo è ambientata nella New York del 1943, e narra della sopravvivenza quotidiana, in una misera camera d’affitto, dell’esule Kobbe, ancora in contatto, e in crescente contrasto, con gli altri émigrés fuoriusciti dall’Europa messa a ferro e fuoco dalle truppe tedesche.
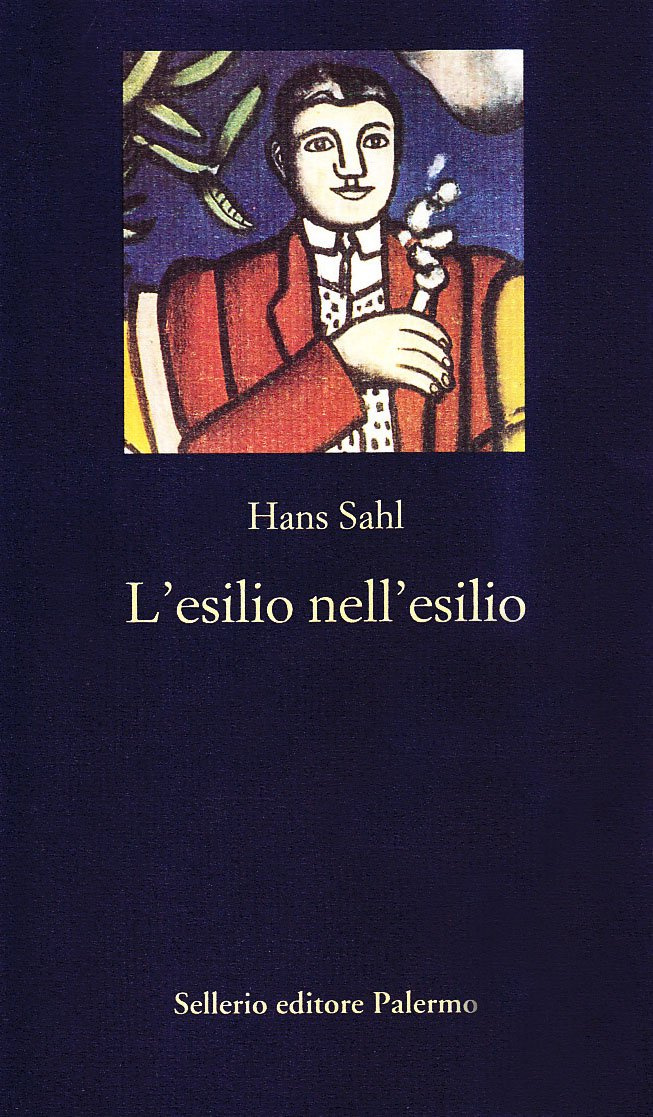
Il Libro secondo è un lungo flashback autobiografico sulle origini familiari del protagonista. Introdotto da una frase di tacitiana concisione sulla catastrofe che colpì la Germania uscita in crisi profonda dalla Repubblica di Weimar e dallo shock del 1929: «Nel primo terzo di questo secolo un grande popolo ricco di talenti cadde vittima di un fatale equivoco». Qui si torna indietro: agli anni degli studi universitari di Georg Kobbe, ai primi amori, al rapporto difficile col padre che non voleva un figlio bohémien, e con la madre preoccupata della propria agiatezza borghese. Si narra, in pagine estremamente toccanti, del declino mentale e della morte del padre; della vita culturale berlinese, tra soirées teatrali e cene d’artista, che entra in crisi sotto la minaccia crescente delle squadracce naziste.
Il Libro terzo riparte dal presente narrativo a New York, per poi ripercorrere retrospettivamente l’esilio in Francia del protagonista, tra il 1934 e il 1939. Qui l’émigré Kobbe, obliati gli agi borghesi e le mondanità di Berlino, conosce per la prima volta la povertà e la fame. Il tutto in quella che fu la Ville Lumière, faro di civiltà, porto sicuro per i fuorusciti di mezza Europa, luogo di passate prelibatezze. E che ora vede Kobbe entrare in aspro conflitto con i filosovietici tra gli emigrati politici tedeschi, fino a trovarsi ancor più isolato.
La quarta parte del romanzo, più breve ma di estrema intensità, ripercorre la fuga da Parigi di Kobbe e di una marea crescente di persone: non solo di profughi come lui, ma di tanti civili innocenti sotto il fuoco dei caccia tedeschi verso quella che si sarebbe rivelata, con il trattato di Vichy, la Francia collaborazionista. Qui il tono del romanzo – mi si passi la semplificazione – fa uno scarto: verso il genere “avventuroso”, con quelle marce forzate anche notturne verso il Midi e Marsiglia.
Nel Libro quinto, e ultimo, ritroviamo sano e salvo a New York il Kobbe che abbiamo conosciuto nelle prime pagine. È entrato in contatto, seppur in assoluta precarietà economica, aiutato da comitati di soccorso, con qualche scampolo di società newyorkese benpensante e democratica. La guerra europea è lontana, ma al tempo stesso, mentre volge alla fine, sempre più vicina. Senza rivelare qui la conclusione del romanzo, mi limito a dire che l’arco narrativo si tende fino all’estate 1945, con le bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki (vissute come notizie un po’ astratte, sulla Est Coast pronta a festeggiare) e il ritorno alla pace. Una pace che già s’incrina, nel presagio dell’incombente Guerra fredda.

Una sfida ulteriore, nel tradurre quest’unico, e ambizioso, romanzo di Hans Sahl, è stato il variare delle tecniche narrative. Le vicende di Kobbe sono narrate a volte in terza, a volte in prima persona; così pure diversi episodi con la sorella Katharina, le amiche Luise e Barbara, gli altri esuli tedeschi, ora a Parigi ora a New York. L’uso ricorrente del flash-back ha richiesto la massima attenzione. Fasi descrittive (il tran-tran quotidiano a Parigi, la fuga verso il Sud) si alternano a passaggi introspettivi, direi quasi di monologo interiore. Questi ultimi svariano dalle riflessioni sull’amicizia e sull’amore alle considerazioni politiche circa il regime hitleriano da un lato, i crimini di Stalin dall’altro, e la debolezza dell’opposizione antinazista, prima in patria e poi in America.
Dello scrittore in fuga Kobbe, a volte, l’autore Sahl riporta pagine di diario, o brevi racconti, e qui è trasparente la sovrapposizione biografica tra le due figure. Questo uso creativo di diverse tecniche, che ha richiesto al traduttore cautele supplementari, non è certo casuale. Sahl, formatosi intellettualmente negli anni della Repubblica, aveva frequentato l’avanguardia berlinese anche come critico, tra arte, cinema e teatro. Amico di scrittori, giornalisti, attrici e ballerine, aveva conosciuto Bertolt Brecht e Lotte Goslar, Ignazio Silone e Joseph Roth, che compaiono, trasfigurati, anche nel romanzo. E il romanzo lo scrisse negli anni Cinquanta, epoca a sua volta aperta all’innovazione in letteratura e nelle arti. Per decenni, nel dopoguerra, lavorò come corrispondente culturale da New York per importanti testate tedesche e svizzere. Di questa sua attenzione alle novità la forma romanzo di I pochi e i molti porta tracce evidenti.

Nella versione italiana ho dovuto dunque tener conto di varie aritmie del flusso narrativo. Così come ho dovuto differenziare nel tono – e anche nel gusto – i dialoghi da salotto a Berlino dalle chiacchiere del popolino francese; le conversazioni nostalgiche degli esuli ebrei a New York dai dibattiti in “politichese” (già allora) degli antifascisti tedeschi spaccati tra terra promessa americana e osservanza sovietica.
Ricorderei qui come il titolo originale, Die Wenigen und die Vielen, proponga anche in italiano la dialettica irrisolta tra I pochi (che si opposero alla barbarie hitleriana) e i molti (che rimasero, collaborarono, commisero crimini). Il titolo italiano non sarà troppo musicale, ma esprime in sintesi un’evidenza della storia novecentesca, la scelta necessaria tra tirannia e democrazia, o anche solo tra coraggio e opportunismo.
Ebbene, nell’affrontare l’arco storico della vicenda da Weimar a Hiroshima, il fatto di essere stato per trent’anni un giornalista del settimanale L’Espresso mi ha senz’altro avvantaggiato. Grazie a competenze acquisite nel tempo mi sono trovato a mio agio nel decodificare i ricorrenti passaggi politici del romanzo. Fossi stato un “traduttore puro” sarebbe stato più faticoso, più rischioso. L’avere esercitato a lungo il giornalismo in senso classico – ovvero prima dell’era X – mi ha dato qualche sicurezza in più nel mio “secondo mestiere” di germanista e traduttore letterario. Per provare ad assecondare al meglio, nel ricreare in italiano la splendida prosa di Hans Sahl, la sua ambizione che mi è sempre parsa indubitabile: quella di scrivere il Romanzo di un’epoca.









