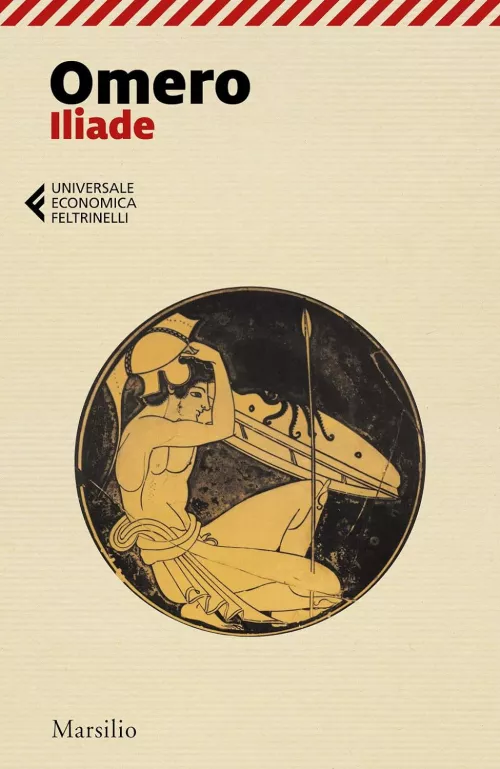Speciale
Il raid omerico: la preparazione
Il guerriero dell’età arcaica per come ci viene presentato dal poema omerico è innanzitutto proprietario del proprio nome. Esso, collegato alla stirpe, lo individua prima della battaglia e lo ricorda quando cade anche se in precedenza non era conosciuto al lettore; si copre di gloria nel momento dell’uccisione di altri nomi. Fare il vuoto attorno al proprio sé nella mischia fitta, abbattere nel duello un altro grande nome come fosse un albero antico, frondoso di rami parentali ed onusto d’imprese, rappresenta il modo per far risplendere la fama personale. La guerra omerica, giocata nella piana tra mare e mura, appare uno scontro tra grandi numeri individualizzati che si realizza in combattimenti uno a uno dove trionfa il valore; così si diffonde di bocca in bocca il nome di Achille massacratore, la nomea lo precede e lo protegge nella lotta.
L’enfasi cade poi sui duelli singoli che sottolineano in quintessenza ritualizzata l’insieme gigantesco, cruento e caotico della battaglia. In questo tipo di guerra che leva alto il nome dei suoi eroi, specie se la durata si protrae molto a lungo come nell’assedio di Troia, potrà avere uno spazio significativo anche il raid. Un esempio completo lo si trova nel decimo libro dell’Iliade allorché Agamennone, “soletto per la notte oscura” (scrive Vincenzo Monti – v. 103 – alla cui traduzione ci si rifà in cerca d’un surplus di sapore), oppresso dal pensiero dell’infinita guerra e della strage dei suoi, infine preoccupato per la vicinanza del campo nemico e per la possibilità che “pur di notte” tenti “qualche conflitto” (v.126) mentre le sentinelle si sono addormentate, vinte dal sonno e dalla fatica, si reca alla tenda del vecchio Nestore. Insieme svegliano Ulisse e Diomede, mentre Menelao si è occupato di convocare gli altri comandanti achei per un improvvisato consiglio di guerra. Ecco allora comparire i nomi evocanti l’assemblea di Aiace d’Oileo e del forte figlio di Fileo, di Merione e di Trasimede a capo del corpo delle guardie. E’ proprio Nestore, il più anziano dei condottieri greci, a proporre il raid nel campo troiano evidenziandone caratteristiche e scopi: eccezionalità dei protagonisti (“anima ardita/ e in sé sicura” vv.260-1), obiettivo della sottrazione, tanto uomini (“qualcuno/ de’ nemici vaganti alle trincere/ far prigioniero” vv.263-5) che notizie (“tanto andar vicino,/ che alcun discorso de’ Troiani ascolti,/ e ne scopra il pensier […] rimanersi ad assediar le navi, o alla città tornarsi” vv.265-9), rientro veloce alla missione (“e ritornarne/ salvo ed illeso” vv.271-2), infine premio materiale ed immateriale (“alta fama al mondo” v.272 tanto che “ne’ conviti e ne’ banchetti ei fia/ sempre onorato, desiato e caro” vv.278-9 e “bel dono” v.273, consistente in una giovane pecora nera con l’agnello). Il discorso di Nestore, di straordinaria puntualità e completezza nell’esporre le linee essenziali del raid, risulta inoltre grazie alla concisione di leggera costruzione retorica. Il mandante lo esprime in forma interrogativa nei confronti dei propri pari; si tratta di una proposta, e non di una coercizione, che fa leva sull’onore più che sul simbolico premio materiale e però sottintende il rischio dell’impresa, tanto da far restare tutti i convenuti “pensierosi e muti” (v.280).
A rompere il silenzio offrendosi volontario è Diomede, non a caso definito dal narratore “bellicoso” (v.281), e capace di far aderire il proprio nome con il profilo di protagonista e di azione tracciato da Nestore, che Vincenzo Monti sintetizza con un’efficace formula di autoriconoscimento: “quell’audace son io” (v.283). Segue l’esplicazione attraverso un’iterazione retorica del pronome personale: “me la fidanza,/ me l’ardir persuade al gran periglio/ d’insinuarmi nel dardanio campo” (vv.283-5). E tuttavia Diomede, fortissimo nella battaglia, non è mai soltanto animato dal furore cieco di Achille, ma viene piuttosto accompagnato da Atena, dea dell’intelligenza, tanto da sconfiggere addirittura Ares in un conflitto virtuale (Iliade V, vv.833-63) e si accompagna, in molteplici spedizioni che fanno corona al poema omerico, con l’astuto Ulisse (per esempio la spedizione all’isola di Lemno per recuperare il ferito Filottete in Igino, Favole, 102.3, o nel celebre furto del Palladio, immagine della sua protettrice Atena e conservata sotto forma di piccola statua a Troia, in Apollodoro III,12.3). Egli è dunque il protagonista più adatto al raid e conferma la propria avvedutezza nella scelta del partner. I comandanti infatti sanno che questa forma di combattimento non si addice all’uomo solo ma necessita dell’aiuto reciproco tra i pochi e Agamennone stesso proclama “Diletto Diomede, a tuo talento/ un compagno ti scegli a sì grand’uopo,/ qual ti sembra il miglior. Molti ne vedi/ presti a seguirti; né verun rispetto/ la tua scelta governi, onde non sia/ che lasciato il miglior, pigli il peggiore;/ né ti freni pudor, né riverenza/ di lignaggio, né s’altri è re più grande” (vv.301-8). I comandanti continuano a sottolineare il pericolo dovuto al luogo ostile e sconosciuto, alla situazione resa incerta dalla notte, ma non possono dire esplicitamente che si tratta del movimento lungo il lato oscuro ed infido della guerra, dove vale ogni tattica e stratagemma, che in certo modo sconfessa il duello uno a uno condotto alla luce del sole, secondo i crismi del rituale, sotto gli occhi e il giudizio degli uomini e degli dei. E però l’accenno a scegliere indipendentemente dal valore assoluto o dalla riverenza del lignaggio, senza vergognarsi della sotterranea furfanteria verso l’azione, viene subito colto da Diomede che senza esitazione indica il partner indispensabile a tale frangente, con cui non a caso, nella visioni dantesca, dividerà la fiamma tormentatrice dei fraudolenti (“[…] se d’un compagno/ mi comandate a senno mio l’eletta,/ come scordarmi del divino Ulisse/ di cui provato è il cor, l’alma costante/ nelle fatiche, e che di Palla è amore?/ S’ei meco ne verrà, di mezzo ancora/ alle fiamme uscirem; cotanto è saggio” vv.242-8).
La saggezza, secondo la traduzione di Vincenzo Monti, o il “pensar bene” (Rosa Calzecchi Onesti, Einaudi 1990), potrebbe essere anche altrove resa meno onorevolmente con astuzia fraudolenta ed infatti Ulisse s’affretta a passare oltre (“non mi lodar né mi biasimar, Tidìde,/ soverchiamente…/ ché tu parli nel mezzo ai consci Argivi” vv.318-20). Gli Argivi appunto lo conoscono bene e non sempre l’indubbia utilità pratica dell’itacense va di pari passo con una limpida e piana stima, così egli esorta il compagno proprio all’azione quando ancora regna la copertura delle tenebre, ovvero la sua ora che fugge e va viceversa sfruttata con prontezza (“Partiam: la notte se ne va veloce,/ delle stelle il languir l’alba n’avvisa,/ né dell’ombre riman che il terzo appena” vv.321-3). Il termine usato nel passo specifico risale al verbo noein dall’ampio spettro semantico che tocca la percezione (vedere, scorgere, accorgersi) sfumando nella conoscenza (pensare, riflettere, progettare) sempre di accezione positiva, ma sappiamo che Ulisse deve la sua fama soprattutto alla più ambigua metis. Si tratta di “una forma di intelligenza e di pensiero, un modo di conoscere; essa implica un insieme complesso, ma molto coerente, di atteggiamenti mentali, di comportamenti intellettuali che combinano l’intuito, la sagacia, la previsione, la spigliatezza mentale, la finzione, la capacità di trarsi d’impaccio, la vigile attenzione, il senso dell’opportunità, l’abilità in vari campi, un’esperienza acquisita dopo lunghi anni; essa si applica a realtà fugaci, mobili, sconcertanti e ambigue, che non si prestano alla misura precisa, né al calcolo esatto, né al ragionamento rigoroso.” La definizione proviene dal classico di Vernant Le astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia che insegue questa particolare, talvolta sottaciuta e negata, piega dell’intelligenza greca obliquamente attraverso un’intera cultura, in primo luogo tra le divinità elleniche – Atena ne è la rappresentante principale –, nei culti, ma anche nel mondo pratico dell’artigianato e delle professioni o in quello tutto verbale e cerebrale dei sofisti, per coglierlo infine nei comportamenti di Ulisse.
Nonostante la flessibile intelligenza degli eroi la narrazione bellica non rinuncia a descrivere l’avveduta preparazione delle armi, che sono però adattate alla particolarità della missione. Diomede aveva dimenticato sulla nave la propria spada e ne riceve in cambio un’altra “di doppio taglio” (v.327) che, questa volta un po’ forzando l’espressione del Monti, ci suggerisce un uso letale e scaltro. Insieme allo scudo e al posto dell’elmo diurno, rilucente, vistoso per bellezza e per incutere paura al nemico, “una celata di cuoio/ taurin compatta” (vv.329-30) senza orpelli quali la cresta che possono scoprire e impacciare i movimenti. Anche Ulisse indossa il cappuccio mimetico – “un morion aspro di pelle” (v.335) – che è fissato al corpo con cinghie di cuoio e rivestito all’esterno con zanne di cinghiale. L’estetica di tale indumento si sposa con la natura animalesca e silvestre da assumere nel raid; ne viene tracciata inoltre una breve storia che rimanda proprio a una sottrazione iniziale (“l’avea furato in Eleona un giorno/ Antolico ad Amintore d’Ormeno,/ della casa rompendo i saldi muri” vv.342-4). Sempre legati alla caccia, forse anche a quella rituale o ex-lege che affronteremo più avanti (visto che la celata di solito “copre il capo/ de’ giovinetti” vv.331-2), l’arco e la faretra che Merione dona ad Ulisse.