Speciale
Diario russo due. Razryv
Storie
La parola razryv in russo vuol dire rottura, ma anche lacerazione, strappo, separazione. E in questi giorni forse nessun vocabolo è in grado di spiegare così bene cosa sta accadendo nella società russa, nelle relazioni intime, negli affetti, nelle amicizie. Mi scrivono le mie ragazze e i miei ragazzi, mi chiedono come sto, alcune volte aggiungono di essere orgogliosi delle scelte che ho fatto. Alcuni di loro vivono in Italia, dove studiano nei corsi magistrali di alcuni atenei. Appena posso, in questi giorni dove l’orrore non conosce tregua, li incontro, ci parlo. E le storie che mi raccontano aggiungono ancor più dolore, perché sono giovani lacerati, tra la scelta etica di non accettare la guerra e la sua pornografica propaganda, e le loro famiglie. Alcuni genitori sostengono la cosiddetta “operazione speciale”, altri pagano sul posto di lavoro i permessi di soggiorno dei propri figli, e quest’ultimi si trovano dilaniati, tra coscienza e amore. Altre famiglie sono divise dai bombardamenti di queste quattro settimane di guerra, lacrime e silenzi si alternano nell’affrontare la tragedia, incredulità, rancori e disperazione popolano le notti.
Discorsi
La lacerazione si approfondisce nel corso dei giorni, e ci divide, ci trasforma. L’azione combinata della propaganda e della (re)pressione inizia ad avere effetto, amicizie che si rompono a causa delle posizioni diverse sulla guerra. Forse è normale, e rileggendo la storia d’inizio Novecento non è sorprendente, ma è diverso vederlo nelle proprie vite. Rapporti coltivati da anni si infrangono, e i pezzi che lasciano sembrano incompatibili, inconciliabili.
Ma non sono solo le relazioni che si spezzano. Il 24 febbraio, data di inizio dell’attacco all’Ucraina, ha lacerato anche la società, la cultura, l’economia, la scuola e l’università. Non c’è più un sentire comune, faticosamente costruito, in quei piccoli spazi che possono essere i posti di lavoro o di studio. Un’atmosfera di disagio frammista a sospetto pervade i discorsi, i gesti son diventati affettati, anche nelle voci si sente una nota stonata, qualcosa che prima non c’era. La scuola e l’università si trovano a essere al centro delle attenzioni dei patrioti di professione, pronti a proporre misure simil-americane, come il saluto alla bandiera e il canto dell’inno nazionale in classe al mattino, o a denunciare il carattere poco “nazionale” dei programmi di studio dei corsi di laurea. Denunce che potrebbero essere polemiche di poco conto, se non provenissero dalla Procura generale. E mi chiedo, avendo insegnato in uno di questi corsi di laurea, cosa significhi aver dei programmi “nazionali” e “patriottici” e come si misurano queste virtù tanto declamate ormai da anni, e ora imposte con i processi e le delazioni.
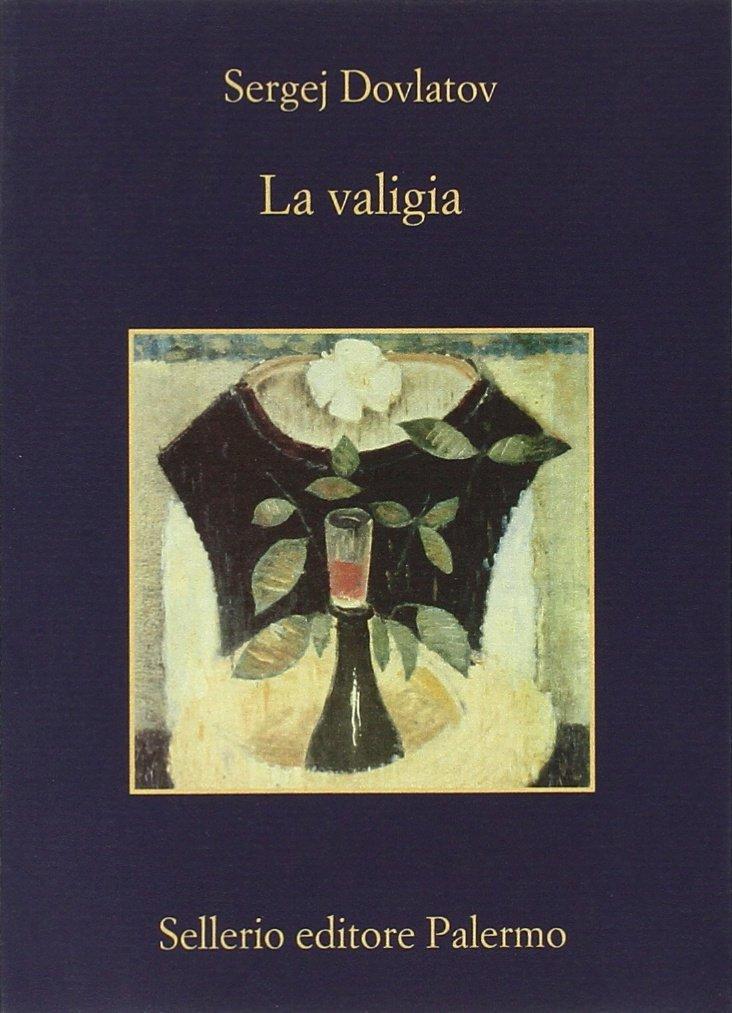
La valigia
Sergej Dovlatov, nel suo La valigia, parlava degli oggetti portati con sé nell’esilio americano da Leningrado, spesso insoliti, che gli riportavano alla mente momenti e persone della sua vita in Unione Sovietica. Le mie valigie sono le chat su Telegram e VKontakte, Instagram e Facebook, app che negli ultimi dieci anni hanno cambiato il nostro rapporto con i ricordi. Migliaia di immagini, fotografie del lago Seliger, di Vologda, di Pietroburgo, delle lezioni in aula e delle uscite con gli amici, memorie visive che si riempiono di significato in questa lacerazione. E forse è strano avvertire sentimenti simili, d’altronde, non sono russo, la mia infanzia e la mia adolescenza non sono passate a Mosca o a Pietroburgo, ma per diciassette anni la Russia è stato il posto dove sono cresciuto da giovane e poi da adulto, e come per me lo è per tante amiche e tanti amici che hanno condiviso percorsi simili.
Pagine sull’esilio
La letteratura russa è ricca di pagine sull’esilio. Alcune dei principali autori dell’Ottocento e del Novecento hanno vissuto in prima persona l’esperienza della lontananza forzata dalla patria: Gor’kij, Nabokov, Brodskij, lo stesso Dovlatov, giusto per limitarci ad alcuni nomi. Brodskij ha dedicato pagine raffinate alla condizione dello scrittore in esilio, in un certo senso confessando i sentimenti legati alla propria condizione. Il premio Nobel spiega come i meccanismi di autodifesa di un autore al di fuori della patria diventano la propria missione: “uno scrittore esule è scagliato, o si ritira, dentro la sua madrelingua. Quella che era, per così dire, la sua spada, diventa il suo scudo, la sua capsula. Quella che all’inizio era una liaison privata, intima, col linguaggio, in esilio diventa destino – prima ancora di diventare un’ossessione o un dovere. Una lingua viva ha, per definizione, una propensione – e una propulsione – centrifuga; cerca di abbracciare quanto più terreno è possibile – e quanto più vuoto è possibile.”. Ma per chi va via da un paese, dove alla fine ci è arrivato per scelta, è ben più difficile poter ritrovarne i suoni e le atmosfere, anche conoscendone a fondo la lingua e la cultura, anche se cercherà di farlo. E non tutti siamo scrittori. La capacità di elaborare e comprendere questo razryv, lacerazione, è uno dei temi di oggi su cui interrogarsi, e per ora sarà difficile ricucire un tessuto sentimentale, tra le persecuzioni politiche e i bombardamenti.
Leggi anche
Giovanni Savino, Diario russo. 19 marzo 2022









