Diego Zúñiga / Camanchaca, memoria e condensazione
Le pagine di Camanchaca, dell’autore cileno Diego Zúñiga (La Nuova Frontiera, 2018, trad. Federica Niola), sono composte di conversazioni mancate, dettagli omessi, ricordi solo parzialmente veri, racconti familiari trasmessi al buio e senza testimoni, di parole pronunciate mentre l’interlocutore s’infila gli auricolari nelle orecchie annuendo con il lettore mp3 in mano. L’interlocutore in questione è anche protagonista anonimo e voce narrante della storia, un ventenne che vorrebbe diventare giornalista sportivo, “[...] sognavo di avere grandi cuffie, uno studio, e di intervistare gli sportivi, o di condurre un notiziario” (p. 22). Ha due famiglie, perché i genitori sono separati, ha molti chili di troppo e i denti che sanguinano quando dorme. Anche la madre ha lo stesso problema, che obbliga il figlio a intraprendere un lungo viaggio col padre e la sua nuova famiglia per farsi salvare la bocca da qualche bravo dentista fuori dal Paese.
Il viaggio è in auto, verso nord, da Santiago del Cile a Tacna, costeggiando l’oceano, che gli abitanti di quei luoghi associano alla possibilità imminente della catastrofe, il maremoto che un giorno seppellirà tutto sott’acqua.
Nel romanzo i pensieri del protagonista diventano frammenti di una narrazione che è sempre mirabilmente discontinua e incompleta, parziale, come il paesaggio che i personaggi guardano attraverso il finestrino durante il tragitto verso il Perù.
Le righe scritte sulle pagine in cui si è scelto di lasciare ampi spazi bianchi sembrano giri di filo nero in cui il ragazzo potrebbe infilare ogni mattina i ricordi della propria infanzia, pezzi della sua dentatura, e della sua memoria, in disfacimento, che immaginiamo raccolga dal cuscino dopo notti passate a sanguinare nel sonno.
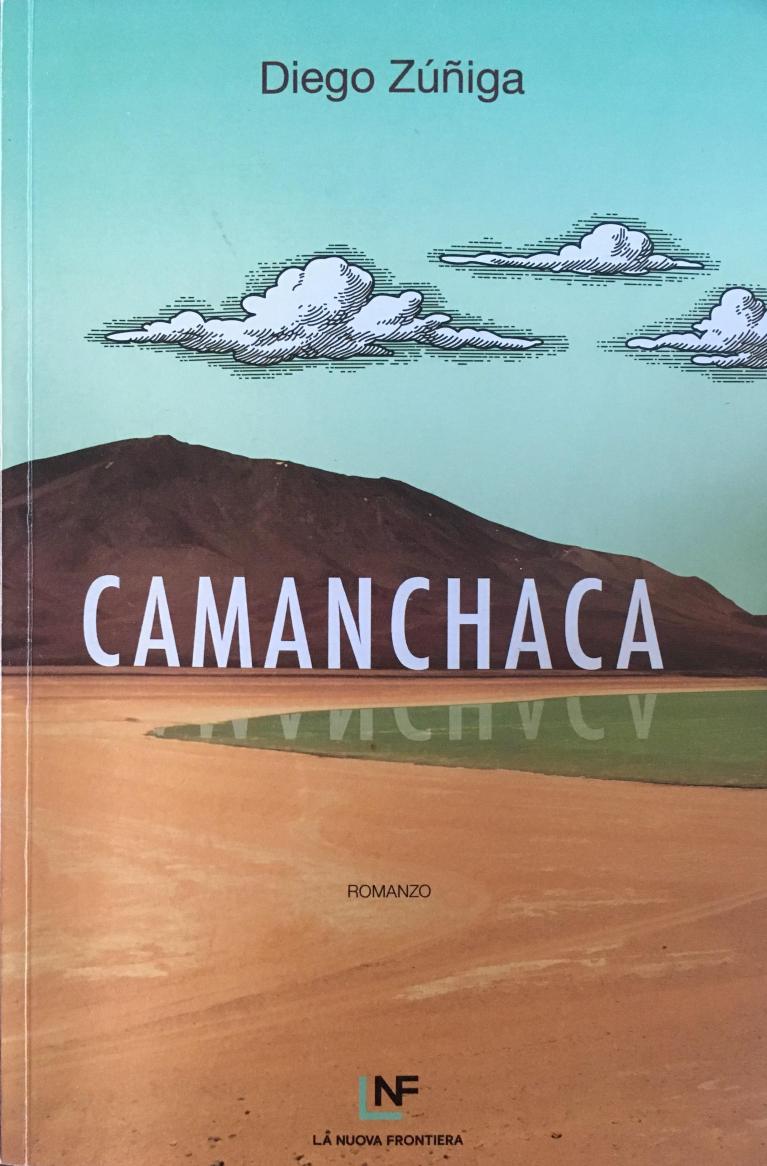
Isolato dalla musica nelle orecchie, sul sedile posteriore del pick-up Ford Ranger grigio fumo del padre, il ragazzo narra al lettore il suo racconto, che è una collana di frammenti i cui principi strutturanti sono la selettività e la condensazione linguistica ed espressiva. Da questi due principi prende forma la sintassi narrativa di Diego Zúñiga, molto sorvegliata, trattenuta, dove le vicende familiari e la storia recente del Cile stanno tra di loro in un rapporto d’interdipendenza i cui meccanismi sono sempre intenzionalmente taciuti. Una prosa di questo tipo, ellittica e frammentata, prevede, anzi, esige un lavoro di riempimento da parte del lettore dei vuoti lasciati dall’autore; il lettore può quindi stabilire un nesso tra il diffuso senso di sconfitta e di angoscia in cui sono avviluppati i personaggi e gli effetti sociali della feroce riorganizzazione neoliberista attuata dagli anni Settanta del Novecento con il regime di Pinochet e sostenuta dal governo cileno anche durante la transizione democratica. Tali effetti, divenuti poi elementi strutturali di uno stato con una forte polarizzazione della ricchezza e del reddito, furono catastrofici proprio per le sorti economiche di migliaia di famiglie molto simili a quella del protagonista, che ora, diventato adulto, preoccupa tutti, il padre e il nonno soprattutto, perché ha bisogno di dimagrire, non si deve trascurare, deve farsi vedere a tutti i costi i denti da qualcuno, altrimenti, il nonno lo avverte, “li perdi tutti e allora sì che non trovi lavoro da nessuna parte” (p. 43).
Sono assenti riferimenti espliciti alla dittatura, non servono, perché la preoccupazione, il disamore e la solitudine gravano sulla vita di chi ha visto strappare, uno a uno, i fili del tessuto sociale del proprio Paese, e pesano sulla testa del ragazzo senza nome come i banchi di nebbia che si formano sulla costa cilena, la camanchaca appunto, che segue e circonda l’auto in corsa su una strada che è la spina dorsale della nazione.
Zúñiga non spreca una parola. La caratterizzazione del protagonista è efficace perché retta, nella sua asciuttezza, dalla somma dei comportamenti (poco descritti) e della realtà interiore (resa da una forte concentrazione espressiva) del ragazzo, nonché dal contrasto tra la sua reticenza e, di segno opposto, le sue dimensioni abbondanti (“se dimagrisco qualche chilo, quando torno a Santiago riesco a entrare nei pantaloni in offerta due per uno”, p. 14) e la sua voracità (“Ho ordinato un panino di pollo croccante con avocado, dei nuggets, patatine, empanadas al formaggio e una bibita grande. [...] ho pensato se prendermi un altro menu in offerta, o magari di cambiare ristorante”, pp. 76 e 77). In effetti, il protagonista di Camanchaca, il cui padre gli appare in sogno come una balena blu gigantesca che piange volando sopra Santiago, è una bocca insaziabile che parla poco, trangugia restituendo sangue al posto delle parole. La sua bocca sanguinante, questa figura del vuoto incolmabile in cui la soppressione di informazioni amplifica la forza poetica del personaggio, è il centro cavo della narrazione, che si sviluppa su due assi, il viaggio in auto e la ricerca della verità da parte del ragazzo su alcune questioni familiari. Egli ricostruisce, attraverso i ricordi lacunosi della madre e del nonno, la storia dello zio Neno, morto in un incidente stradale dalla dinamica poco chiara, e cerca anche di scoprire se le sparizioni che hanno colpito la famiglia abbiano a che fare con gli ufo o con i militari. I parenti cui chiede spiegazioni raccontano sempre controvoglia, “come chi fa e disfa un puzzle rovinato” (p. 84), mostrando solo quei tasselli che, deformati e sgualciti dal tempo, sono diventati dei sottintesi indecifrabili.
Mentre la voce narrante alterna passato e presente, e la discontinuità organica del racconto trova il suo corrispettivo paesaggistico nella foschia che copre a tratti la costa, il padre devia, all’altezza della città portuale di Antofagasta, verso Atacama, “il deserto blu, come se fosse coperto da un manto” (p. 27). Ad Atacama non ci sono insetti, non ci sono animali, è uno dei luoghi più secchi del mondo.
Se la sintassi narrativa di questo romanzo, che in verità ha l’aria del poema in prosa, trova il suo corrispettivo naturale nella camanchaca, la lingua di cui è fatto, così diretta, asciutta, trova il suo corrispettivo nel paesaggio lunare aridissimo di Atacama. Qui, dove gli astronomi di tutto il mondo s’innamorarono del cielo cileno mentre i militari predisponevano il più grande campo di prigionia del Paese per i detenuti politici (il campo di Chacabuco), la polvere stellare accarezza i resti delle ossa dei desaparecidos e degli empampados, vale a dire coloro che, perdendo l’orientamento, si abbandonano al deserto.









