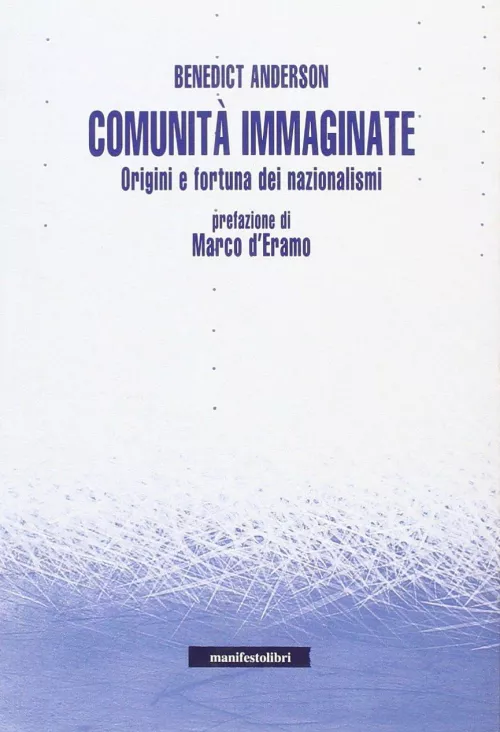Speciale
Ritorno al futuro / Benedict Anderson, Comunità immaginate
Comunità immaginate, pubblicato negli Usa nel 1983 dallo studioso sino-irlandese Benedict Anderson, affronta la questione della genesi e della struttura del nazionalismo. Mi è sembrato necessario affrontare la lettura di questo classico di fronte ai cambiamenti dello scenario politico occidentale, alla ricerca di un quadro interpretativo fondamentale che riconoscesse dignità al nodo del nazionalismo, tornato in grande auge nella nostra attualità. La lettura del libro mi avrebbe auspicabilmente aiutato a (ri)posizionare il mio punto di vista di semiologo, indicandomi cosa guardare, da dove cominciare per tentare un’interpretazione dei testi e degli artefatti che circolano nel nostro scenario sociale al passo coi tempi, al passo cioè con la nuova sensibilità che l’egemonia del nazionalismo in Occidente incarna al giorno d’oggi.
L’edizione che ho usato per questa rilettura è stata quella del 1996 di Manifesto Libri, introdotta da Marco D’Eramo. Al momento della pubblicazione dell’edizione italiana, lo scenario politico sociale era molto diverso da quello attuale. Era il tempo della globalizzazione e dell’atlantismo trionfante, del villaggio globale promesso da Internet e del boom della “new economy”, della costruzione delle istituzioni multinazionali dell’Unione Europea. In questo clima, le guerre dei Balcani venivano, per esempio, guardate dall’alto in basso, raccontate come incomprensibili guerre fratricide fra ossessionati dell’identità, cattivi nazionalisti destinati a essere schiacciati dalla storia e dalla fine della politica, ridotta a mero problema di amministrazione di un ordine mondiale, dopo la caduta del Comunismo, mai più veramente passibile di essere messo in discussione.
Se non altro, l’avvento dei nazionalismi a casa nostra, primo risultato di questa esplorazione, ci permette di archiviare il lungo periodo di quella che alcuni hanno chiamato post-politica, un orizzonte comunitario senza conflitto e antagonismo fra visioni alternative della società. L’emersione inaspettata del brutto di Donald Trump, dei rozzi slogan salviniani, l’evocazione ad opera dei gilet gialli della rivoluzione e della guerra civile nella Francia macroniana ci costringono a restituire un posto all’alterità, a ripensare l’agone politico come dialettica fra posizioni effettivamente presenti e praticate da gruppi sociali in vera competizione. Ci costringono a ridiscutere le nostre pretese di verità, di fronte alle obiezioni del prossimo, di fronte alla sua azione politica.
La pubblicazione di Comunità immaginate avviene nello stesso anno (1983) di un altro famoso libro sul tema, L’invenzione della tradizione a cura di Eric Hobsbawm e Terence Ranger, tirato giù dallo scaffale anch’esso per l’occasione. I due volumi, seppur da una prospettiva diversa, l’uno più sociologica l’altro più prettamente storica, procedono verso una medesima mossa teorica. I due libri, infatti, gettano le basi di un ribaltamento dell’approccio accademico anglosassone al nazionalismo, derubricando il fenomeno, per così dire, da dato (di cui prendere atto) a prodotto (frutto di una costruzione). Sottolineare il versante di produzione di questi concetti, come si fa nei titoli dei due libri (invenzione/immaginazione), è, infatti, un gesto di rottura, in primis verso la galassia dei nazionalismi stessi che ha sempre teso a rappresentarsi in termini di continuità metastorica: le nazioni, dal punto di vista dei nazionalisti sono sempre esistite. Servirà il lavoro certosino dello storico (la chiamata di Hobsbawn e Ranger) e delle scienze sociali (Anderson) per ridimensionare questa pretesa. Significativamente si tratta di studiosi di estrazione marxista, portatori insomma di un interesse per così dire ideologico a sconfessare il velo simbolico, la sovrastruttura sapientemente “inventata” per nascondere i veri interessi strutturali di ordine economico delle classi dominanti. Promessa mantenuta in parte, se è vero che il libro di Benedict Anderson si fa portatore di una prospettiva più complessa e consapevole del ruolo modellizzante della dimensione simbolica rispetto alla vulgata marxista tradizionale. I titoli dei due libri, per esempio, sembrano affini ma in realtà la dimensione di produzione del senso a cui essi fanno riferimento è molto diversa. Con il riferimento del titolo del libro a cura di Hobsbawn e Ranger al concetto di invenzione, la tradizione (su cui si fonda il nazionalismo) viene letta in una visione prettamente materialista, di invenzione da zero, smascherata nel suo tentativo di presentarsi come sempiterna, grazie al lavoro degli studiosi portatori di una verità materiale esistente e quindi tracciabile documentalmente.
L’aggettivo immaginate utilizzato nel titolo del libro di Anderson, invece, meno ingenuamente, si riferisce non a una immaginazione sganciata dalla realtà, quanto alla naturale vocazione simbolica degli individui a immaginarsi come membri di una comunità che li trascende. Da una parte, c’è quindi un fare investigativo (rivelare la natura fittizia della tradizione in nome della verità) dall’altra, un approccio volto a rivelare le procedure di costruzione del complesso fenomeno dell’appartenenza nazionale. Si spiega così il motivo della scelta di Comunità immaginate, anziché del pur notevole libro di Hobsbawm e Ranger per la mia lettura critica.
Nella prefazione alla prima edizione del libro, Anderson si chiede (siamo nel 1983): «chi può essere sicuro che Yugoslavia e Albania un giorno non arriveranno a esplodere?». Sarebbe stato il venir meno dell’egemonia sovietica sull’Europa orientale a rivelare il re nudo, ovvero che i regimi marxisti nati a ridosso della seconda guerra mondiale in seguito al nuovo ordine mondiale segnato da Yalta si fossero costituiti a partire dalla riconfigurazione tradizionale nazionale, mai veramente eradicata dall’avvento del comunismo, anzi, al contrario, così dirompente da trasformare, tanto inesorabilmente quanto surrettiziamente, ogni repubblica socialista in una repubblica nazionale. Sarebbe stato, quindi, secondo Anderson, il venir meno del dominio militare sovietico a dare la stura alle rivalità nazionali latenti in Europa dell’est. Profetico. È allora per uscire dal “tardo-tolemaismo” della teoria marxista incapace persino di definire il nazionalismo che il libro vuole proporre la sua rivoluzione copernicana di inquadrare il fenomeno nella sua più genuina matrice culturale, senza minimizzarla, in nome del primato della struttura.
Qual è la definizione di nazione che Anderson propone? “Comunità politica immaginata, e immaginata come intrinsecamente insieme limitata e sovrana”, intendendo con immaginata, il fatto che naturalmente i componenti di tale comunità, non potranno mai conoscersi personalmente. Pur essendo la nazione intrinsecamente limitata dai propri confini, i patrioti potranno soltanto immaginarsi come membri di una comunità trascendente di cui non potranno conoscere tutti i membri. Si può rilevare quanto una definizione di questo genere possa essere insoddisfacente. Dal punto di vista delle scienze antropologiche e semiotiche, infatti, il fatto che in una comunità ci si conosca personalmente non è affatto rilevante per l’esistenza della comunità stessa, nella misura in cui essa si costituisce intorno a un sistema di valori e di credenze oltre che a delle regole di affiliazione che fanno capo a una struttura precisa e che quindi non richiedono affatto ai singoli componenti di conoscersi materialmente. Dal punto di vista delle scienze antropologiche e semiotiche, insomma, ogni comunità è per definizione una comunità immaginata e quindi questo aggettivo, rivelandosi superfluo, mostra una visione sicuramente ingenua e naïve delle dinamiche comunitarie, ancora debitrice dell’approccio del materialismo storico, ossessionato dall’incarnare miti e rappresentazioni nella “realtà” materiale delle cose. Si può quindi affermare che sebbene Anderson riveli una visione sicuramente più consapevole di quella di Hobsbawm e Ranger, interessati a fare debunking delle “invenzioni” storiche portate dai nazionalismi, d’altro canto, la volontà di portare avanti una analisi delle forme culturali dei nazionalismi si scontra con una interpretazione del concetto di comunità ancora insufficiente. Pazienza.
L’altra caratteristica che Anderson riconosce alle nazioni è il fatto di essere limitate, di essere segnate da confini, cioè locali, mai universali e soprattutto non interessate a diventarlo. Le nazioni vogliono mantenere la loro particolarità contro ogni istanza di universalizzazione. Universalismo vs particolarismo. Infine, le nazioni, punto assai notevole, si caratterizzano per il fatto di essere orizzontali, ovvero di costituirsi intorno all’idea dell’uguaglianza. Differenze di ceto sociale, di censo, di status vengono tutte livellate in nome di un cameratismo egalitarista che costituisce i suoi componenti come corpo politico totale, il popolo “sovrano”, rappresentato da ognuno dei suoi cittadini in egual misura. Da cui il peculiare mood emotivo dei suoi componenti che tendono a pensarsi come sodali uniti da un comune destino. Le nazioni si propongono, quindi, come strumento di perpetuazione di una continuità storica sempre a repentaglio, che vuole arruolare chiedendo a ognuno di dare il proprio contributo. Immagini come quelle rappresentate in ogni dove dai monumenti al milite ignoto possono rendere l’idea di una tale disposizione: tombe senza corpi ma piene di immaginazione. Le nazioni finiscono, così, per prendere il posto delle religioni, non nel senso banale che le rimpiazzano ma in quello che svolgono una funzione ad esse analoga. Ed è, sostiene Anderson, proprio dalle religioni oltre che dal modello del regno dinastico da esse discendente che esse si stagliano per differenza.
Il modello dell’appartenenza nazionale subentra nel momento in cui si interrompe il rapporto fra le parole e le cose. Foucaultianamente, è la rivelazione dell’arbitrarietà del segno, secondo l’autore di Comunità immaginate, la prima imputata nel lento processo di tramonto del modello internazionalista rappresentato dalle grandi religioni e dalle monarchie. Le lingue sacre, come il latino in Occidente, infatti, erano la struttura, unica e indiscussa, di un’ontologia del mondo al cui vertice stava il divino. In funzione di ciò, esse svolgevano la funzione di garanti della verità del mondo e, d’altra parte, costituivano uno strumento di assimilazione dell’alterità, a prescindere da ogni connotato culturale: chiunque, nella misura in cui riconoscesse la verità di Dio per il tramite della lingua, sarebbe potuto essere integrato in questo ordine. Le lingue sacre sono aperte e si caratterizzano per la loro volontà di voler assimilare il prossimo, promuovendone la conversione. Il giocattolo, come si diceva, si rompe progressivamente. Anderson riporta un curioso passo del Milione di Marco Polo, che attribuisce al Kublai Khan un giudizio sulle religioni del vecchio continente che oggi potremmo definire relativista. Dal punto di vista lontano del sovrano mongolo, l’una valeva l’altra, esse avrebbero meritato la medesima considerazione e rispetto. Ciò che sorprende Anderson è la mancanza di reazione del viaggiatore veneziano, ovvero come, già nel duecento, Marco Polo non sentisse la necessità di insorgere di fronte a un tale relativismo, tacciandolo di ipocrisia o piuttosto di blasfemia ma si accontentasse di accogliere con soddisfazione la percezione che il gran Khan tenesse come “più vera” la fede cristiana. Sta in questo “più”, secondo Anderson, il germe, che si rivelerà incredibilmente fecondo, della territorializzazione della fede. La competizione, essere i migliori prende il posto della Verità.

Benedict Anderson.
La monarchia “assoluta” è lo strumento attraverso cui la civiltà universalista del latino lingua sacra si appresta al governo delle cose terrene. Interessante notare, al proposito, come le élite governanti afferenti a questo modello fossero fondate su basi internazionali. Fra i regnanti non contava la nazionalità, almeno finché, a partire dal 600 circa, l’autorità a suggello della loro attività di governo non fu rimpiazzata: da Dio al popolo, vero sovrano. Il passaggio di testimone da queste due autorità, ha colossali conseguenze. Perfino, sostiene Anderson appellandosi a Benjamin, nella concezione del tempo, che passa dall’essere scandito dalla simultaneità nel presente di passato e futuro (profezie, presagi, premonizioni costituiscono il tempo come compresenza di essi) all’essere vuoto scorrere, tempo da riempire, omogeneo e parallelo. Proprio in virtù della sua omogeneità, il tempo comincerà a essere misurato oggettivamente da orologi e calendari. È proprio la possibilità che esso venga misurato oggettivamente a costituire la base per la comparazione, la competizione fra le culture. Da ora in poi censimenti, mappe, musei, istituzioni scolastiche, burocrazia potranno essere considerati nella loro qualità di strumenti di immaginazione, strumenti attraverso cui dar forma alle comunità immaginate.
Non è un caso che, a partire dall’invenzione della stampa, il latino-lingua-universale perderà progressivamente terreno contro le lingue nazionali della pluralità e della territorializzazione, segnando il predominio della fissità del libro. Proprio la concezione del tempo come scorrere omogeneo, legittima, per esempio, la nascita dei quotidiani (definiti come “forma estrema di libro”, “bestseller di ogni giorno”), che si costituiscono come orchestratori della contemporaneità, essi tengono il filo di molteplici narrazioni accomunate dal solo fatto di essere contemporanee. I giornali così non fanno che ordinare, produrre gerarchie fra fatti e notizie del giorno a partire dalla scansione ordinata del tempo. Nel nome di esse, poi, costituiscono comunità di lettori che tendono a immaginarsi simili in base al fatto di condividere una medesima agenda, una medesima gerarchia di fatti concomitanti, dettata dal numerino in alto sulla pagina con la data di pubblicazione. Giornali e nazionalismo, mcluhanianamente, secondo Anderson, sono legati a doppio filo. I lettori dei giornali così come quelli delle letterature nazionali, rappresentano l’élite da cui prenderanno forma le politiche nazionaliste.
Un altro asse fondamentale di costruzione dei nazionalismi ha a che fare con il nuovo mondo. Anderson è lo studioso che prova a ribaltare l’ipotesi stereotipa che pensa l’Europa come matrice dei nazionalismi, suggerendo una pista globale, legata al colonialismo. Le nazioni, almeno nel momento della loro costituzione, non si sono fondate su una dialettica noi/loro, basata per esempio, sulla differenza etnica o linguistica. La nascita degli Stati Uniti, come atto di ribellione alla madrepatria inglese, può costituire un buon esempio di questa evenienza. Il colonialismo inglese, infatti, era stato impostato su una doppia discriminazione, da, una parte, dei colonizzatori contro i colonizzati ma più sottilmente dei rappresentanti dello stato nazionale colonizzatore contro le élite amministrative creole delle colonie con la madrepatria. La costituzione di veri e propri centri di potere legati alla burocrazia coloniale permise la proliferazione di un’élite creola di coloni che intorno a essi fondava in proprio prestigio ma che non poteva aspirare a ruoli diplomatici, essendo essi riservati ai civil servants provenienti dalla madrepatria.
Proprio questo blocco, lungo tutto il nuovo mondo, fece montare astio e risentimento che, presto, presero le forme dell’ostilità. Le élite burocratiche creole nate come strumento di dominio delle popolazioni locali, si misero così a capo di queste stesse popolazioni, facendo fronte comune contro i colonizzatori. Tea party ma anche personaggi come Simon Bolivar, in America Latina, potrebbero essere un buon esempio di questo tipo di processo.
L’idea che delle anonime unità amministrative possano essere alla base del sentimento nazionale è controintuitiva. Essa può essere spiegata facendo riferimento ai pellegrinaggi che l’istituzione di questi centri amministrativi richiedeva. Le grandi religioni avevano inteso il viaggio in funzione di un centro emanatore di senso (Gerusalemme, Roma, La Mecca etc.), il nuovo funzionario amministrativo affronta piuttosto il viaggio in vista di una vetta da scalare, in una progressione verso il successo e la realizzazione professionale. L’ultima cosa che egli desidera è tornare a casa, nella misura in cui il suo ritorno sarebbe a tutti gli effetti inteso come degradazione, sconfitta; egli vuole piuttosto piantare le tende solo temporaneamente in vista della prossima scalata. Durante questa scalata, insieme spaziale e professionale, egli non sarà, poi, solo, incontrando lungo la via altri compagni di viaggio della medesima specie. È proprio sulla base del cameratismo costituito dai viaggi che si costituiscono inedite solidarietà, fra persone che nulla avrebbero avuto in comune, nelle colonie disegnate a tavolino dagli invasori, se non il fatto di procedere lungo i medesimi binari amministrativi. A questo proposito, indicativo il caso dell’Indonesia (pag. 128). I suoi confini sono tracciati dalla conquista olandese di territori geograficamente frammentati che avevano una composizione etnica-religiosa assolutamente eterogenea, tale che un cittadino di Sumatra non sentisse di avere nulla in comune con un ambonese delle Molucche.
Solo la diffusione di un apparato scolastico nazionale poté creare un senso di appartenenza nazionale indonesiano costituito da un apparato pedagogico omogeneo ma anche e soprattutto da una struttura dei pellegrinaggi degli studenti “a piccole vette” che dalle scuole dei villaggi, progressivamente potevano scalare la gerarchia delle scuole statali fino al suo vertice rappresentato da Batavia, la nuova capitale coloniale, il cui avvento avrebbe reso obsoleta la vecchia gerarchia tribale del potere rappresentata dalle altre città come Singapore, Manila e Rangun. Il fatto di adire da uno sperduto villaggio delle Molucche alle scuole di Batavia, insieme ai tanti altri studenti ivi afferenti da luoghi distanti migliaia di chilometri e storicamente non collegati, avrebbe finito per costituire il collante di una nuova élite nazionale immaginata, figlia della burocrazia coloniale.
Porre la questione del nazionalismo in questi termini, ancora una volta, può essere utile per ripensare lo scenario dell’attualità. E qui arriva una battuta fulminante: “Chi vorrebbe volontariamente morire per il Comecon o per la Cee”? (pag. 69). Letta col senno di poi, questa battuta scritta nel 1983, può illuminare sulla grande crisi che il discorso europeo sta attraversando. Se è vero che era difficile immaginare che qualcuno nel 1983 anno di pubblicazione di Comunità immaginate, avesse potuto pensare di “dare la vita” per una patria rappresentata da Cee o Comecon, dopo trenta e più anni, le cose non sembrano essere tanto cambiate, a proposito dell’Unione Europea. Essa viene sempre più spesso rappresentata come casta burocratica indifferente e distaccata dalla vita dei suoi cittadini. Ciò che appunto sembra mancare è il senso di appartenenza verso una nazione Europa, riconosciuta a suggello della propria comunità politica. Guardando alla questione nei termini in cui Anderson la pone, emerge come questa difficoltà, oltre ad essere esito di un’evoluzione storica, fatta di conflitti e rivalità radicate che qui, una volta tanto, non si vogliono prendere in considerazione, emerge anche in sincronia come portato di scelte istituzionali poco efficaci. Si può facilmente riflettere su come i viaggi Erasmus, indicati in un famoso discorso da Umberto Eco come germe dell’Europa unita, possano essere riconosciuti nel ruolo di costruttori nazionali indicato da Anderson.
Questi viaggi, compiuti da cittadini davvero diversi per cultura di provenienza, lingua, religione, sono, infatti, riusciti nell’intento di creare un’élite nazionalista europea oltre le appartenenze nazionali ma il portato di questa esperienza è rimasto limitato a un numero drasticamente basso di cittadini. Il modello di una tale cittadinanza multinazionale, poi, non è stato perseguito fino in fondo, mettendo in continuità istituzioni europee e nazionali, costituendo itinerari organizzati per piccole vette. Queste piccole vette funzionano finché si tratta di scalare le burocrazie nazionali ma si interrompono nel salto verso la dimensione europea, che appare piuttosto come costruzione abbastanza centralizzata e in competizione con quella nazionale. Piuttosto che vertice della catena delle piccole vette, si propone come percorso a sé impermeabile e autosufficiente, rappresentativo di un’autorità il cui potere decisionale appare senza una vera legittimazione, imperiale ma senza Dio. La lettura del testo di Anderson, potrebbe in questo senso aiutare a riorientare gli sforzi politici e amministravi per il raggiungimento di una vera cittadinanza europea, in grado di legittimarsi simbolicamente.
Proprio in virtù di questo scollamento appare chiaro come ogni tentativo di rilanciare il progetto europeo che non tenga conto di queste dinamiche ma faccia leva su un comunitarismo delle élite europee sia destinato a fallire. Se è vero che esso viene spesso rappresentato dalla “generazione Erasmus” di 40enni educati nel momento in cui lo scopo di perseguire una cittadinanza europea era perseguito con più lungimiranza, è anche vero che senza mettere mano ai nodi semiotici strutturali della comunità, queste stesse istanze e questa medesima generazione rischia di apparire come i Burgsozialist della corte asburgica (pag.115), socialisti affascinati dal discorso imperiale e per questo osteggiati dai movimenti di liberazione nazionale. Essi tendevano a difendere le ragioni della coesistenza delle nazionalità tedesche e ungheresi in nome di un uno spirito di fratellanza proletario finendo per avallare una politica volta alla negazione degli interessi delle fasce meno abbienti. Il loro riformismo in fin dei conti veniva visto come una copertura volta a rafforzare le classi dominanti senza ottenere un effettivo allargamento della cittadinanza.
Le considerazioni finali del libro sono particolarmente illuminanti a proposito dell’ostracismo che nel discorso pubblico contraddistingue il discorso sul nazionalismo, rappresentato in Europa, dopo le tragedie del fascismo e del nazismo, come una patologia della storia. Contro la faciloneria di questo tipo di posizioni, Anderson indica svariati esempi in cui il riconoscimento delle aspirazioni nazionali dei popoli abbia costituito un modo per pacificare territori altrimenti condannati a essere martoriati dalla guerra. Il caso dell’Irlanda avvelenata dal terrorismo prima della sua indipendenza dal Regno Unito e, quindi, risolutivamente pacificata potrebbe essere un buon esempio della capacità del nazionalismo di sedare gli animi una volta che le sue aspirazioni vengono realizzate. A un certo punto, scrive (pag.151): «In un’epoca in cui così spesso intellettuali progressisti e cosmopoliti (soprattutto in Europa?) insistono sul carattere quasi patologico del nazionalismo, sul suo radicarsi nella paura e nell’odio per ‘Altro’ e sulle sue affinità con il razzismo, è bene ricordare che le nazioni suscitano amore, e spesso amore pronto al sacrificio. I prodotti culturali del nazionalismo (poesia, letteratura, musica e arti plastiche) illustrano quest’amore in centinaia di forme e stili diversi. Mentre è molto più difficile trovare analoghi prodotti nazionalisti che esprimano paura e odio. Persino nel caso di popoli colonizzati che avrebbero ogni diritto di provare un odio profondo per i loro dominatori imperialisti, è incredibile come questo elemento occupi un ruolo insignificante nell’espressione del sentimento nazionale.». Queste considerazioni, significativamente portate avanti da uno studioso marxista possono ancora una volta illuminare sul dibattito pubblico attuale, facendo emergere come la questione della rinascita dei nazionalismi in Europa e in Usa possa essere correttamente guardata senza catastrofismi, come variabile legittima della storia, nella perenne tensione fra federazione e secessione.