Felini / La clessidra di Aarhus e il gatto della porta accanto
Qualche giorno fa girava su internet un breve video degli abitanti della città di Aarhus, in Danimarca, a passeggio nel 1902. La notizia stava nel colore: il video originariamente in bianco e nero, si può vedere adesso a colori. E questo cambia tutto. Perché gli abitanti di Aarhus diventano molto più simili a noi. A centoventi anni di distanza siamo sicuri che tutto ciò che in quel video si muoveva, adesso non lo fa più. Insomma, siamo sicuri che sono tutti finiti al cimitero. Dagli adulti ai ragazzi, fino ai neonati nelle carrozzine. Eppure allora erano vivi e frenetici come noi: la loro colorata somiglianza con ciò che possiamo vedere nelle nostre città, a parte il décor e l’abbigliamento diversi, ci colpisce come un messaggio insieme vitale e funebre. Sono tornate eccezionalmente vive, tutte quelle persone sconosciute, nel nostro presente. Mentre il loro passato, che per un attimo torna a colorarsi, è come se ci afferrasse per i capelli dicendoci: tra poco toccherà anche a voi.
Ma quello che mi interessa, in quel video, è l’irruzione a un certo punto di un cane. L’inquadratura filma i passanti che camminano verso la cinepresa fissa, prima in lontananza, quindi sempre più vicini, con i volti curiosi o sorpresi, infine uscendo dall’immagine e sparendo dietro la cinepresa stessa. Nel contempo filma il flusso opposto, di quelli che stanno camminando in senso inverso: coloro che sbucano da dietro la cinepresa, talvolta si voltano per guardarla, poi si allontanano fino a sparire dall’altra parte. La cinepresa sembra essere una clessidra, che inghiotte in un verso o in un altro il pulviscolo agitato dei corpi umani, pronti a polverizzarsi in un breve lasso di tempo. In quell’amalgama preciso e irripetibile che si trova a camminare su quella strada di Aarhus in quel giorno e a quell’ora del 1902, ci sono molti individui che appartengono a generazioni diverse, ma non lontane. Non così lontane, per lo meno, da non avere abitato nella stessa città in quello stesso momento. Non così lontane come lo siamo noi, che non potremo mai incrociare per strada nessuno di loro: donne, uomini, ragazzi, bambini. Una giovane donna, avvicinandosi, guarda dritta dentro la cinepresa. E verrebbe da chiederle: chi sei? Che storia hai?
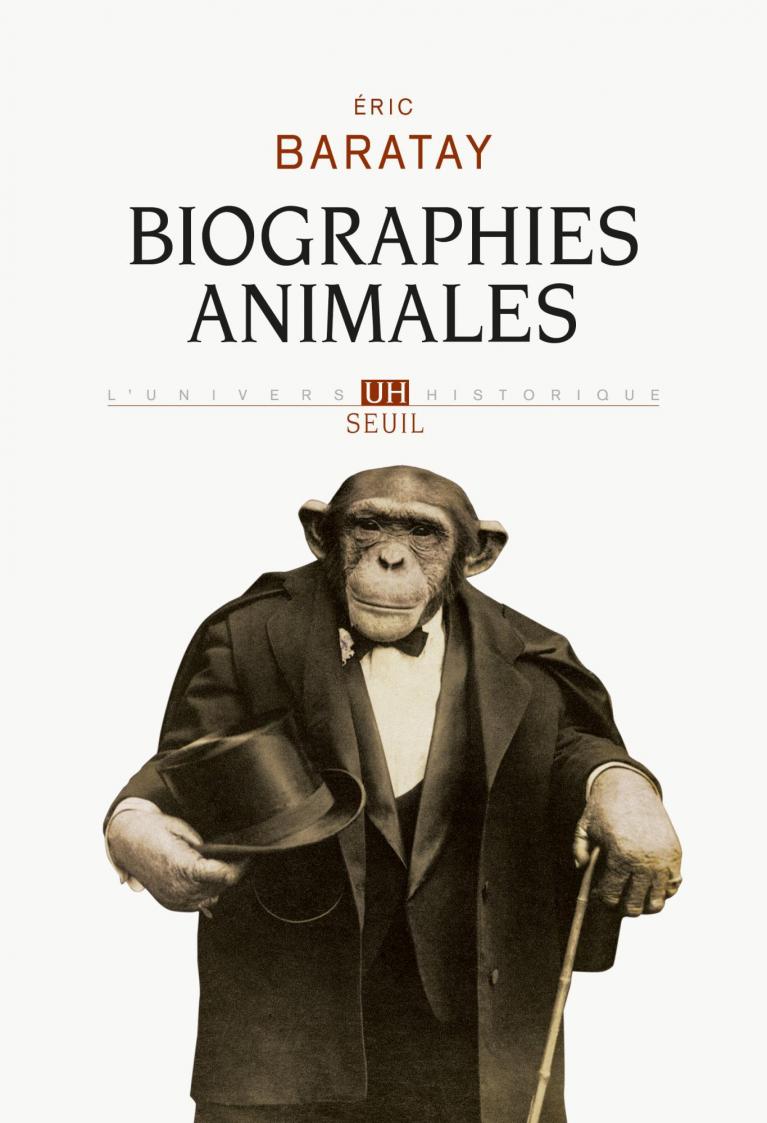
Una famigliola, con i bambini vestiti in modo ridicolo e lussuoso, che doveva allora essere elegantissimo, scantona invece per uscire rapidamente dall’inquadratura, come per paura che quella cinepresa fosse in realtà il mirino di un fucile che minacciava di cancellarli e separarli. Passa una carrozza, la gente si affretta verso casa o verso i propri affari. Finché nell’immagine che brulica di animazione si crea un attimo di vuoto, come quando si ha l’impressione che la clessidra non stia andando né giù né su. E in mezzo a quel vuoto arriva il cane. Arriva scodinzolando da dietro la cinepresa, attraversa quel momentaneo spazio vuoto che lo fa spiccare ai nostri occhi, scende dal marciapiede verso la strada che occupa la parte destra dell’inquadratura e scompare anche lui, come tutti gli altri. Due secondi in un video che dura circa un minuto. Non è l’unico animale che compare nel video: prima avevamo visto un cavallo, ma talmente inglobato nel gruppo meccanico della carrozza che lo tiene al laccio da esserne quasi annullato. Il cane, invece, è libero. Distinto e ben visibile in mezzo al flusso continuo dei bipedi, è un individuo che vive a Aarhus nel 1902.
Anche a lui bisognerebbe chiedere, come alla giovane donna: chi sei? In entrambi i casi la loro vita ha avuto una durata limitata e probabilmente inaccessibile nel suo più recondito significato. Il cane sciolto irrompe nella scena, per ricordarci che mescolata a quella generazione di umani che non rivedremo mai più, perché inghiottita in un passato che non potrà mai tornare se non nella forma fantasmatica di questa pellicola, c’era anche una generazione di animali che abitava lo stesso mondo. Anche loro nati da qualche parte, vissuti in qualche modo singolare e infine arrivati in quel punto esatto della clessidra. Il cane non potrà rispondere alla nostra domanda. Intanto perché il suo corpo non esiste più, come quello della donna: non respira più, né si muove su questa terra, quindi non potrà mai più produrre alcun suono. Poi perché quel cane non faceva parte di una favola di Esopo e quindi non parlava in lingua danese, quand’era in vita, né in qualsiasi altro linguaggio umano. Però la domanda rimane e non è così stupida come potrebbe sembrare. Per dimostrarlo dobbiamo liberarci da molti pregiudizi, sgombrare la testa da vari sentimentalismi, fare i conti con il grande problema dell’antropomorfismo e scegliere la strada impervia ma esaltante della complessità.
Tuttavia, se non vogliamo rischiare di perderci nei meandri di un pensiero incrostato da secoli di leggende, tabù e malintesi, meglio avere una guida. Éric Baratay, storico dell’università di Lione, che ha appena pubblicato un libro dal titolo Cultures félines (XVIIIe-XXIe siècle). Les chats créent leur histoire (Seuil, 2021), mi pare una delle migliori in circolazione. Il libro parla di gatti, non di cani, ma le ricerche che Baratay sta conducendo da diversi anni si applicano a tutto il regno animale. Prima si è occupato degli animali che l’uomo utilizza per i lavori di fatica (Bêtes de somme. Des animaux au service des hommes, 2011), poi ha allargato la prospettiva in favore di un rovesciamento sistematico del punto di vista da cui guardiamo e raccontiamo la storia (Le point de vue animal, une autre version de l’histoire, 2012), infine è passato a un esercizio di microstoria che ricostruisce la biografia di taluni, celebri animali della storia europea (Biographies animales, des vies retrouvées, 2017). L’ultimo suo libro si concentra sui gatti: ma potremmo dire che lo stesso tipo di riflessione vale anche per il cane rimasto impigliato nella clessidra di Aarhus.

Baratay ci guida a prendere atto di un’evidenza che fatica a scacciare l’ombra delle nostre consolidate credenze: il gatto è un’invenzione. Come la giovinezza o la femminilità. Non esiste in quanto prodotto di una natura biologica immutabile, ma consiste in una variabilità di comportamenti nello spazio e nel tempo, che lo rende una creatura storica. Anzi molte creature storiche, che vanno colte nella fluttuazione cronologica e nell’adattamento a un ambiente che muta incessantemente. Sono individui che vivono all’interno di generazioni, le quali cambiano creando la loro storia, come recita il sottotitolo del libro. Non esiste il Gatto Eterno al singolare, ma i gatti storici al plurale. Una volta usciti dall’illusione di una natura felina invariabile, si vedranno milioni di gatti individualizzati dentro una serie di culture feline che si succedono nei secoli all’insegna di una grande plasticità comportamentale. Fare la storia di queste culture vuol dire riconoscere prima di tutto un cambiamento di paradigma fondamentale in Occidente, che si colloca più o meno all’epoca del romanticismo: i gatti, che erano stati guardati per secoli dagli umani con la lente deformante di una leggenda mefistofelica, iniziano a essere rivalutati dagli artisti romantici come un perfetto specchio del proprio mito. Quello dell’artista imprevedibile, maledetto e misterioso, indipendente e solitario. A partire da quel momento, i gatti cominciano a risalire la china della loro cattiva nomea, in virtù della quale il compagno nobile dell’uomo era stato indiscutibilmente per secoli il cane, fino a giungere al fenomeno contemporaneo del “chatchien”, vale a dire dei gatti domestici che diremmo “caninizzati”.
Forme di attenzione che mutano, sguardi umani che si laicizzano. Potrebbe sembrare la solita vicenda di alterna fortuna, simile a quella delle opere d’arte rimaste incomprese per lungo tempo, che improvvisamente diventano le star di un sistema culturale fino ad allora tiepido o ostile. Ma in effetti non è così: nel senso che dovremmo piuttosto rovesciare il punto di vista, per capire cosa sia davvero successo. Sforzarci di vedere cosa è successo a loro, i gatti storici che costruiscono la loro identità sociale all’interno di gruppi generazionali mutevoli, piuttosto che fermarci al nostro limitato orizzonte. Le culture feline del passato, entrate in contatto con un ambiente umano ostile a causa di pregiudizi antichi e tenaci, si sono adattate a quella diffidenza. Diventando a loro volta diffidenti: maledetti, indipendenti, solitari, come da manuale del perfetto felino apparentemente impresso nel marmo della genetica. Le culture feline successive, a partire dal Settecento e soprattutto dall’Ottocento, hanno cominciato invece ad adattarsi alle nuove situazioni ambientali che derivavano dall’epocale mutazione dell’atteggiamento umano. E sono diventate sempre più simili a quelle canine, che per secoli avevano goduto di uno status di relazione privilegiato, più caloroso e rispettoso, con le società umane occidentali che condividevano la loro stessa dimensione spazio-temporale.
Se iniziamo a guardare le cose da questa prospettiva, ogni animale su questa terra si trasforma in un insieme complesso di biologia, società e storia. Diventa un individuo che viene costruito in larga parte dalla sua cultura, intesa come un processo di acquisizione che lo porta a essere, e sopravvivere, nel mondo. Nelle sue straordinarie biografie animali del 2017, Baratay aveva già cercato di ricostruire una storia tutta nuova, per esempio, della famosa giraffa che nel 1826 arriva in Francia, alla corte di Charles X. Oppure del toro Islero che nel 1947 uccide Manolete infilzandogli un’arteria femorale. O ancora dell’asina Modestine che nel 1878 accompagna Stevenson nel suo viaggio nelle Cévennes. Storia tutta nuova, non solo per i contenuti inediti che propone, sforzandosi di rileggere i documenti storici alla ricerca di elementi che ci consentano di avvicinarci a una comprensione più interna possibile del vissuto di quello specifico individuo animale dentro una generazione originale di suoi simili; ma anche per la sorprendente sperimentazione di plurimi stili di narrazione, che alterna stili grafici diversi per aiutare i lettori e le lettrici a seguire le differenti stratificazioni del discorso, uscendo da un’illusione di linearità idealmente antropomorfa.
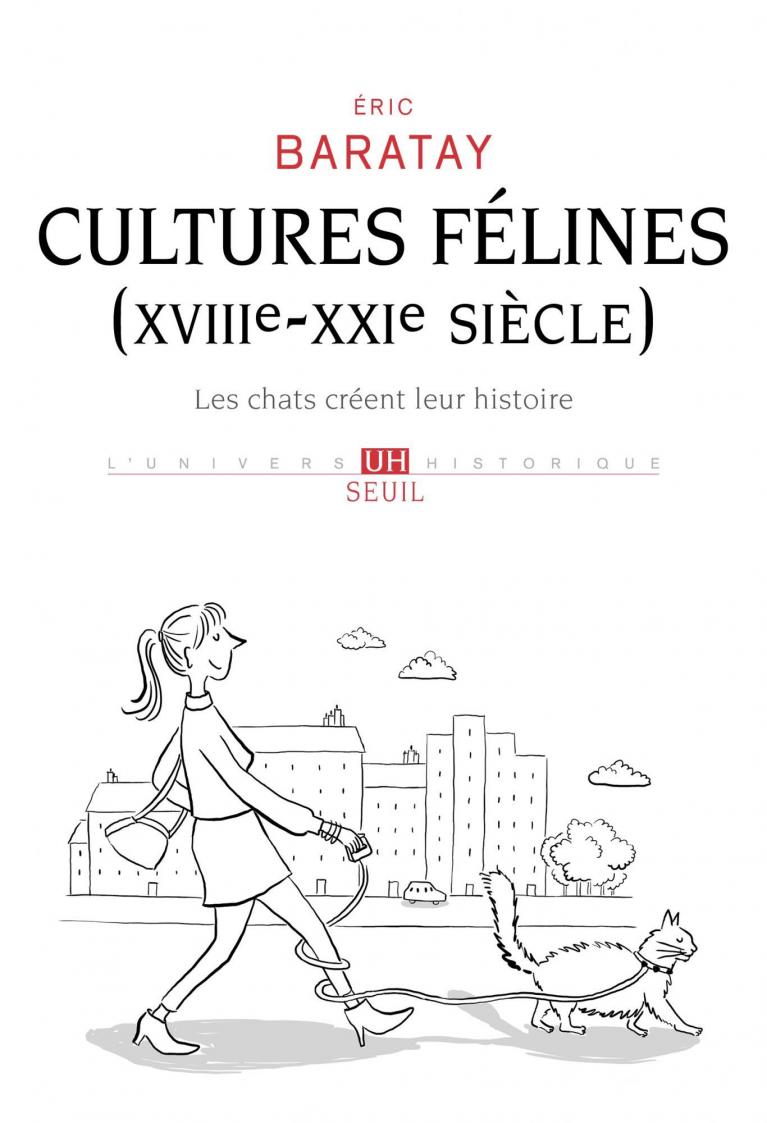
Adesso la domanda posta al cane di Aarhus dovrebbe risultare più chiara. Chi sei? Proprio tu, che attraversi quella strada in quel giorno del 1902. La stessa domanda che lo storico pone alla giraffa che il 30 giugno 1827 arriva a Parigi e ad altri animali celebri di cui rimanga qualche traccia, in mezzo ai miliardi di creature anonime che sono invece rimasti senza storia, come facessero parte della faccia oscura della luna, indistinta e muta. La stessa domanda che ci viene da rivolgere al gatto che vive nell’appartamento accanto, dopo aver capito, grazie all’ultimo libro di Baratay, che anche lui è figlio di una cultura in movimento. Probabilmente diversa anni luce da quella a cui appartenevano i suoi avi. Se ci capitasse in mano qualche documento che parla della vita di quell’individuo in forma di cane che all’inizio del secolo scorso andava a spasso nella città di Aarhus, potremmo cercare di rispondere a tale fatidica domanda. A tentoni, con sperimentazioni narrative forse improbabili, ma almeno desiderose di uscire dai sentieri battuti di quella violenta cancellazione materiale e simbolica di larghe fette del vivente alla quale siamo abituati.
Invece abbiamo soltanto un filmato, in cui il cane appare e scompare in una manciata di secondi. Perfettamente anonimo, come tutti gli esseri umani che compaiono nel video. La clessidra di Aarhus è spietata, ma anche democratica. Ogni individuo, umano o animale che sia, torna al suo stato creaturale. Senza più nome né storia: la giovane donna o i bambini intabarrati nei loro vestiti di lusso, al pari del cavallo da soma e del cane sciolto per strada. Ciascuno di loro torna a essere un granellino di sabbia nel tumultuoso e inarrestabile enigma delle epoche che passano. Ma nel buio di ciò che sono stati, come in quel pungente desiderio di recuperare parti della loro storia che spinge l’umanità a scavare nel passato, sono insieme. E devono rimanere insieme, se non vogliamo fare del racconto della vita sulla terra un ridicolo e brutale monumento a noi stessi, come abbiamo fatto per secoli invisibilizzando ogni fascia debole di quel racconto, dal popolo minuto alle donne. Il cane di Aahrus compare nell’inquadratura, all’improvviso e con la rapidità di uno squarcio che si richiude subito, per ricordarcelo.









