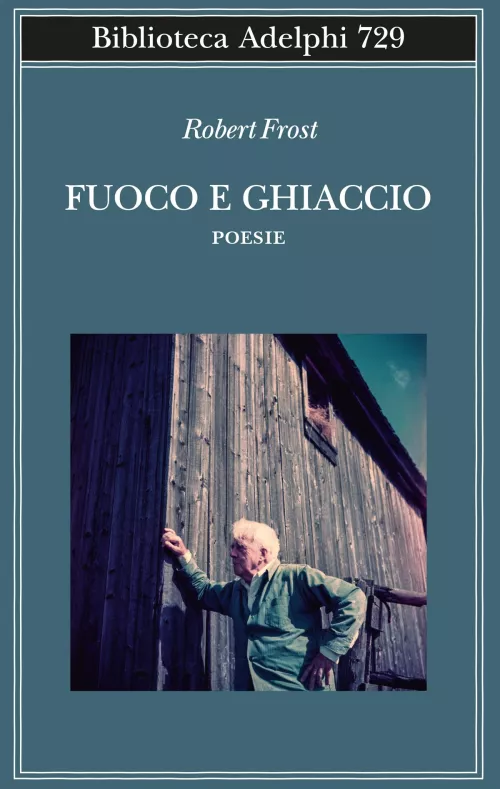Fuoco e ghiaccio / Robert Frost, “Un illustre misconosciuto”
“And you read your Emily Dickinson/ and I my Robert Frost…”.
È in The Dangling Conversation di Simon & Garfunkel (1966) che ho sentito nominare per la prima volta Frost. Avevo diciassette anni, e della poesia angloamericana sapevo quel tanto che mi aveva trasmesso mia madre, insegnante di inglese: classici, soprattutto. Che si trattasse di un poeta importante me lo segnalava la sua presenza accanto a Emily Dickinson, la prediletta di uno dei due malinconici personaggi protagonisti della crepuscolare conversazione evocata da Paul Simon e Art Garfunkel.
La lettura di Conoscenza della notte e altre poesie, una scelta dei suoi testi uscita in quegli anni da Einaudi nella traduzione di Giovanni Giudici, mi lasciò piuttosto freddo. Di lì a poco scoprii T.S. Eliot e Wallace Stevens, e di Frost non mi occupai più. A quanto pare, non ero il solo. “Frost – scrive Ottavio Fatica nel volume appena uscito da Adelphi, Fuoco e ghiaccio, che comprende poesie scritte dal 1912 al 1962 – da noi è rimasto relegato in una penombra larvale. Un illustre misconosciuto”.
Eppure, non si può dire che Frost sia un autore “marginale” o “appartato”: fin dagli anni Dieci del secolo scorso i suoi libri ottennero un grande successo negli Stati Uniti, gli valsero ben quattro premi Pulitzer per la poesia e numerosi altri riconoscimenti; nel 1963 fu chiamato a leggere i suoi versi alla Casa Bianca, nell’ambito della cerimonia di insediamento del presidente J. F. Kennedy. Certo, non aveva i requisiti per essere considerato un poeta di spicco nell’ambito della produzione moderna e contemporanea: nonostante l’apprezzamento di Ezra Pound (conosciuto nel 1912 durante un soggiorno a Londra) i suoi versi avevano poco a che fare con le tendenze “moderniste”; suonavano un po’ attardati, legati a modelli tradizionali (qualcuno lo accostò a Wordsworth). Ancora oggi, a colpire il lettore è la trasparenza delle sue poesie, la loro colloquialità, la “normalità” – apparente – del loro impianto metrico (“Frost – scrive ancora Fatica – aveva liquidato il verso libero: per i suoi gusti era come giocare a tennis senza rete”).
Robert Frost nasce nel 1874 a San Francisco, da una famiglia del New England (lì si trasferirà a undici anni, dopo la morte del padre). Studia a Dartmouth e a Harvard, senza però laurearsi. In seguito cerca di mettere in piedi con la moglie un’azienda agricola (in campagna sono ambientate molte sue poesie) ma deve rinunciare. Trasferitosi in Inghilterra nei primi anni del Novecento, conosce poeti come Edward Thomas, Rupert Brooke, Robert Graves e il già nominato Ezra Pound, e pubblica – a quasi quarant’anni – il primo libro di versi, A Boy’s Will, seguito da North of Boston, che decreta il suo successo al ritorno negli Stati Uniti (1915). In patria, negli anni seguenti, arriva a essere riconosciuto come una sorta di “poeta laureato” (si è detto della sua lettura alla Casa Bianca). Muore nel 1963, a ottantotto anni.
Quello che caratterizza la pagina di Frost, anche a una prima lettura, è – lo abbiamo già ricordato – il frequente, disinvolto ricorso al parlato, la leggibilità e l’adozione di forme metriche più o meno “regolari”, che includono l’uso della rima. Vediamolo in un testo, Revelation (Rivelazione) tratto dalla raccolta A Boy’s Will (1913):
We make ourselves a place apart
Behind light words that tease and flout,
But oh, the agitated heart
Till someone really finds us out.
The pity in the case require
(Or so we say) that in the end
We speak the literal to inspire
The understanding of a friend.
But so with all, from babes that play
At hide-and-seek to God afar,
So all who hide too well away
Must speak and tell us where they are.
Rivelazione
Prendiamo le nostre distanze
dietro vaghe parole sprezzanti
ma il cuore, oh com’è agitato
finché non verranno a stanarci.
Peccato che poi per farci
capire da un amico
(almeno a chiacchiere) diciamo
pane al pane e vino al vino.
Da chi gioca a nascondino
fino a Dio, vale per tutti,
chi si nasconde troppo bene
parli e dov’è ce lo dica.
Il tono, qui e nella maggior parte dei testi, è piano, discorsivo, spesso ragionante. A differenza degli autori “modernisti” suoi contemporanei (penso soprattutto a Eliot), Frost mantiene saldamente la centralità dell’io lirico: il lettore ha sempre la sensazione di un discorso che ha origine in un soggetto ben determinato, mai dissociato, obliquo o plurimo. Molti testi – anche tra i più lirici – sono strutturati come un racconto. Il racconto assume a volte caratteri marcatamente teatrali, ad esempio in poesie come The Death of the Hired Man (Morte di un bracciante) o Home Burial (Sepoltura in casa), entrambe contenute nella raccolta North of Boston. Al soggetto lirico subentra occasionalmente una dramatis persona (nel solco di Browning) come quella che sta al centro di The Pauper Witch of Grafton (La strega povera di Grafton), da New Hampshire (1923).
L’ambientazione delle liriche di Frost è quasi esclusivamente agreste: si parla di stagioni, semine, fienagioni, di alberi e boschi, fiori, campi, mucche e tordi, montagne, sorgenti, fiumi e ruscelli. In un bosco innevato è ambientata una delle poesie più citate, Stopping by Woods on a Snowy Evening (da New Hampshire), in cui ritroviamo il tono piano e trattenuto che caratterizza Frost, la sua delicata reticenza (“Non cosa intende dire, bensì a cosa mira, è la domanda da porsi per Frost, che aveva sviluppato il complesso dell’ulteriorità e gli sarebbe dispiaciuto se una poesia si fosse fermata da qualche parte: le aveva costruite per trasportare il lettore nello sconfinato. Per farsi il nido nell’illimitato”, annota Ottavio Fatica):

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village, though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark, and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.
Sosta vicino a un bosco in una sera di neve
Dovrei saperlo di chi è il bosco.
Però sta di casa in paese;
non vedrà se mi fermo a guardare
il suo bosco riempirsi di neve.
Parrà strano al mio cavallino
fermarsi senza fattorie vicino
tra il bosco e il lago ghiacciato
la sera più buia dell’anno.
E dà una scrollata ai sonagli
per chiedere se c’è uno sbaglio.
C’è un suono ed è il giro del vento
lieve, dei fiocchi ovattati.
Buio e profondo è il bosco, bello da morire,
ma io ho promesse da tenere
e miglia da fare prima di dormire
e miglia da fare prima di dormire.
Dall’andamento colloquiale dell’inizio, attraverso il racconto delle reazioni del cavallino per la sosta inaspettata, che mette in rilievo la singolarità dell’attrazione del suo padrone per la scena naturale, si approda al finale lirico, dove il richiamo del bosco contrasta con quello della vita sociale e affettiva (le “promesse”) e sfocia infine nell’immagine di una metaforica lontananza dal sonno, che fa pensare a una delle liriche più celebri di Goethe, Über allen Gipfeln ist Ruh.
In Frost, il paesaggio naturale domina. La città, centrale nella produzione moderna, non appare. Questo ha portato molti a considerarlo un poeta idilliaco, pacificato e pacificante. Solo nel 1959, in occasione del suo ottantacinquesimo compleanno – riferisce Fatica –, il critico Lionel Trilling, a sorpresa, lo definisce “terrificante”. In effetti, sotto la superficie dell’idillio frostiano si indovinano tensioni oscure, mai del tutto esplicitate, se non ad esempio nella presenza frequente di case abbandonate, nell’incendio selvaggio e insensato di The Bonfire (Il falò, in Mountain Interval) o nel ricorrere, nei titoli, della parola fear (paura): Storm Fear, Fear of God, The Fear of Man, Home Fear, o semplicemente Fear.
I testi di Frost – lo abbiamo osservato – spiccano per la loro chiarezza, per la loro leggibilità. Eppure – o proprio per questo – tradurlo non è per niente facile. Gli elementi di parlato che emergono in quasi tutte le poesie sono difficili da rendere nella nostra lingua senza scadere nel prosastico, nel gergale, nella chiacchiera corrente o nei regionalismi. In più, c’è l’ostacolo della forma tradizionale, sempre legata da rime che hanno una funzione essenziale nella struttura e nella musicalità dei versi. Per questo ci sembra ammirevole (e molto ben riuscito) lo sforzo della traduttrice, Silvia Bre, che – grazie anche alla sua esperienza diretta del fare poetico – riesce a rendere in italiano la scrittura “naturale” e complessa di Frost, piena di trappole e inciampi, prendendosi le giuste libertà, ma restando sostanzialmente fedele all’originale.
Uno dei motti più celebri di Frost (anche se non molti sanno che è suo) è quello che recita “Poetry is what gets lost in translation” (La poesia è ciò che va perso nella traduzione). Nel caso del lavoro di Silvia Bre, direi che la poesia (di Frost) è quello che la traduzione riesce a restituirci e a farci amare, riscoprire o scoprire. E ne valeva la pena.