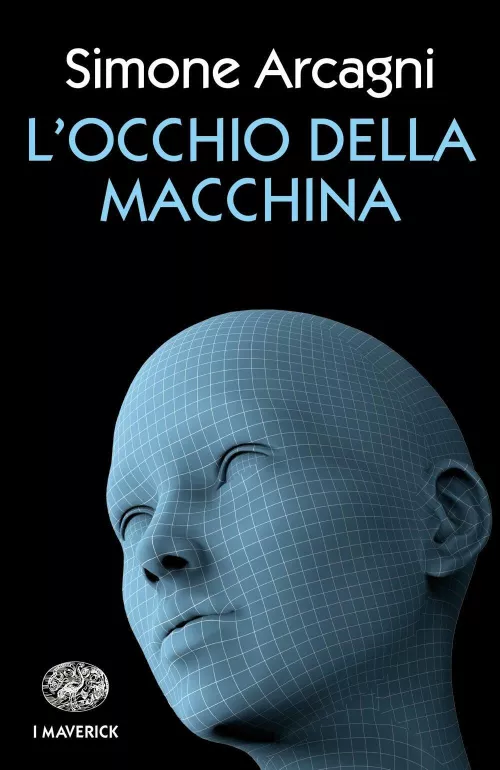Come vedono le macchine? / Occhi ovunque
Come vedono le macchine? A tutta prima potrebbe sembrare una curiosità, una di quelle su cui insistono le tante trasmissioni di divulgazione che ci fanno sentire tutti un po’ scienziati, e invece la questione è molto seria e promette di avere effetti non indifferenti sul nostro futuro. Inutile dire che le macchine in questione sono i computer, che già dagli anni Sessanta sono stati interfacciati, come si dice in gergo, con delle telecamere, sensori ottici che hanno dato loro la possibilità di acquisire dati che, secondo una logica tutta umana, pertengono alla vista. Sequenze di bit che sono direttamente prodotte dal modo in cui la luce incontra le cose che popolano il mondo, ma che una volta entrate nel cervellone della macchina diventano… cosa? Ecco la domanda che si fa Simone Arcagni nel suo L’occhio della macchina (Einaudi, 249 pp., 20 euro), un racconto appassionato e appassionante che ripercorre le teorie della cosiddetta Computer vision, ripensandole in una chiave sociale e culturale senza la quale non se ne capirebbe lo spessore. La questione infatti è che le macchine le abbiamo costruite noi. Siamo stati noi, in un’epoca estremamente vicina ma resa apparentemente distante dal ritmo del progresso tecnologico, a mettere i computer in grado di “vedere”. Lo abbiamo fatto a partire dalla nostra vista naturalmente, e questo ci ha obbligati a riflettere su di essa, a interrogarci sui processi cognitivi che la rendono possibile e la fanno funzionare. Nel momento in cui si sono cominciati a implementare gli algoritmi, però, rendendo reale quello che era considerato fantascientifico, si è prodotto un movimento inverso: la vista delle macchine ha cominciato ad avere effetti sulla nostra. A cambiare la nostra percezione del mondo.

Pensate a Google Maps e al modo in cui ci consente di esplorare nel dettaglio luoghi in cui magari ci troveremo in futuro – i dintorni dell’albergo che abbiamo prenotato per un viaggio, per esempio – finendo per renderceli familiari anche se non li abbiamo mai visti. Il problema insomma non è “cosa” vedono le macchine, ma “come” lo fanno e quindi “perché” e con quali conseguenze. Perché la vista, come ogni forma di percezione, non è mai neutra. Vedere è una capacità che ci serve per guardare, ovvero per ricercare, analizzare, strutturare quello che percepiamo, quei dati grezzi con i quali non avremmo nulla da fare se non trovassimo una qualche chiave per organizzarli. Proprio ciò che i primi ricercatori della Computer Vision hanno dovuto inventare e che oggi si è evoluto enormemente, trasformandosi anche grazie al fatto che le macchine stesse hanno inevitabilmente finito per rielaborare (pensare?) i loro stessi processi di elaborazione del visivo. D’altronde sappiamo che se oggi disponiamo di computer così performanti e miniaturizzati è perché ci sono altri computer ad aiutarci a progettarli. Senza di essi, quella evoluzione tecnologica non ci sarebbe stata. E tuttavia, come dicevamo, è fondamentale interrogarsi su tali processi, tenendo sullo stesso piano tanto la riflessione cosiddetta scientifica, quella degli ingegneri e dei programmatori come anche dei neurologi, quanto quella di matrice più umanistica, filosofica ma anche letteraria e, naturalmente, cinematografica.
Perché è chiaro che se esiste un campo in cui la visione viene problematizzata continuamente, smontandone l’accecante naturalità, è proprio il cinema. Non parliamo soltanto dei film che tematizzano le questioni della visione e del rapporto di questa con i calcolatori, da 2001 Odissea nello spazio a Terminator gli occhi meccanici abbondano, ma dei film in generale, in cui ogni storia passa per una messa in forma visiva che non ha nulla della visione naturale anche se è percepita da tutti come tale. Non è un caso che Simone Arcagni abbia maturato la sua sensibilità di studioso proprio all’interno degli studi sul cinema che, per quanto qui integrati con una cospicua mole di questioni informatiche, fanno continuamente capolino.
Alla fine (o all’inizio, visto che lo si legge già nell’indice) l’occhio della macchina non è uno ma tanti: dall’occhio computazionale a quello di Dio, passando per quello artificiale, cibernetico, virtuale ecc., ed è dall’intersezione fra questi possibili modi di pensarlo che si determina con tutta evidenza il nostro futuro. Da un lato l’iPhone, che dopo averci riconosciuto prima attraverso un codice numerico, come si addice a un calcolatore, è passato a rilevare la nostra impronta come fosse un poliziotto, per approdare finalmente al viso, ovvero proprio il modo in cui noi esseri umani individuiamo un amico. È questo che lui vuole essere, questo il modo in cui ci propone di relazionarci a lui. Con il non trascurabile particolare che affinché lui ci veda bene è necessario che anche noi lo guardiamo per un attimo, che lo riconosciamo insomma. Niente più tocco distratto, serve una bella occhiata che altrimenti, magari, non gli avremmo tributato. Per non dire delle automobili a guida autonoma, che per poter funzionare devono guardarsi intorno, ma, come è noto a qualunque automobilista, non per individuare degli ostacoli, ma per riconoscere ciò che potrebbe diventarlo. Una capacità che, una volta perfezionata in termini di calcolo, non potrà che avere ripercussioni su altre forme di elaborazione predittiva delle informazioni.
Per finire – ma è ovviamente solo un assaggio di tutto quello che c’è nel libro – con la diagnostica per immagini, in cui i computer non soltanto riescono a vedere quel che noi non possiamo, ma possono giudicarlo, porre su di esso l’attenzione o trascurarlo. Insomma, è chiaro che mettere insieme informatica e scienze umane è oggi una necessità, e non solo per scongiurare distopie fra le più inquietanti, ma perché in giro ci sono e ci saranno sempre più corpi in grado di vedere. Occhi attaccati a ogni cosa, in grado di andare ovunque e di vedere anche quello che i nostri non possono, e ogni volta avremo a che fare con soggetti che, proprio in funzione di quella capacità – e di quel corpo – agiscono. Quanto questo possa cambiarci ce lo dice qualcosa che abbiamo in tasca: lo smartphone. Da quando incorpora l’occhio di una macchina fotografica non la smettiamo più di fotografare. Siamo diventati tutti fotografi. È il bisogno che segue la funzione? Sorta di nemesi del mantra del design che voleva fosse la seconda a dover seguire il primo? Niente di tutto questo, semplicemente il fotografo, ovvero colui che si guarda intorno riconoscendo ogni tanto delle immagini che sente di dover fissare in qualche modo, non si dà se non nella relazione con un altro occhio che gli fa ripensare i suoi e il modo che ha di usarli. Alla fine, insomma, siamo tutti ibridi.