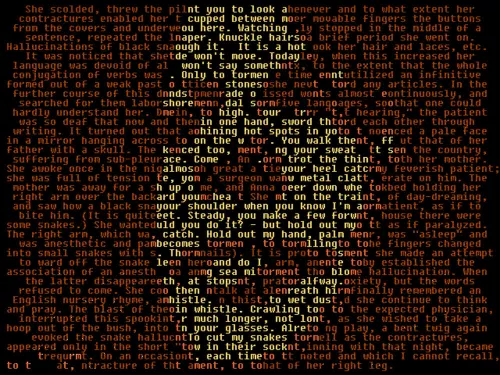Hyperfiction
Una delle caratteristiche dell’arte postmoderna, forse la principale o fondante, è l’utilizzo programmatico dell’autoconsapevolezza come strumento di riflessione culturale: l’autore si distacca dalla propria opera, sdoppiandosi nell’entità che crea e in quella che osserva l’atto della creazione all’interno del suo contesto. Così che in pressoché qualsiasi opera d’arte postmoderna (letteraria, cinematografica, architettonica) ci troviamo di fronte a due livelli paralleli, il racconto e il discorso-intorno-al-racconto: in molti casi questo doppio binario viene realizzato per mezzo dell’ironia, che enfatizza l’atto ludico (cioè mai completamente serio) implicito nella creazione dell’opera d’arte. Come dire, il mondo non è un foglio bianco sul quale tracciamo il percorso della nostra espressione individuale, ma un insieme di segni la cui combinatoria è (l’hanno dimostrato i membri dell’Oulipo negli anni Sessanta) a tutti gli effetti un gioco.
In questi ultimi vent’anni il postmoderno ha cominciato a morire di diverse malattie: rarefazione minimalista, nuova sincerità, rigurgito realista, autofiction, saturazione dei significanti. Nella loro diversità, queste patologie sono accomunate da un appiattimento sulla superficie (della verità, del corpo, della realtà ecc.) che ha come effetto collaterale anche quello di far collassare il doppio binario della narrativa postmoderna: più spesso sul versante della storia, come è reso eclatante dal successo della fiction di testimonianza (da Roberto Saviano a William Vollman a Svetlana Alexievich, in cui il sottotesto è sempre: “questo è reale e le mie ferite lo dimostrano”), ma talvolta anche sul versante del puro gioco. È così che nasce e si diffonde quella che qui ho voluto chiamare hyperfiction.
Il termine hyperfiction non è stato scelto a caso: coniato da Robert Coover in un famoso articolo del 1993, indicava quella narrativa ipertestuale prodotta con l’ausilio dei computer e fruibile per mezzo degli stessi che avrebbe dovuto realizzare pienamente, portandola al suo zenit intrinseco, la scrittura postmoderna. Sulla carta il ragionamento non era sbagliato, sebbene fosse in parte viziato dalla ventata di entusiasmo portata dalla diffusione del World Wide Web: se il testo postmoderno era uno spazio labirintico edificato sull’idea stessa di possibilità, di cui il modello della rete era la rappresentazione perfetta, allora l’ipertesto ne era la logica continuazione. La pratica però si è rivelata poco propensa a seguire la teoria, e l’ipertesto come forma letteraria autosufficiente non si è per ora diffuso al di fuori dei circoli accademici e sperimentali.
Tuttavia l’idea di narrativa come spazio ludico delle possibilità infinite ha trovato una realizzazione forse inaspettata grazie a un’industria che all’inizio degli anni Novanta stava muovendo i primi passi: quella dei videogiochi. In molti hanno fatto notare che “i videogiochi sono il business più serio del XXI secolo”, e man mano che le tecnologie digitali sono evolute, sfumando progressivamente il confine con la realtà (maggiore verosimiglianza dei videogiochi, giochi che interagiscono con la realtà, persino commistione tra gioco e guerriglia urbana) sono nate forme ibride, da videogiochi massicciamente narrativizzati all’uso massiccio di effetti speciali digitali nei film. Ma al di là dell’aspetto tecnico, la gamification ha trasformato la narrativa postmoderna in maniera meno ovvia, ed è qui che entra in campo il nuovo significato del termine hyperfiction.
Siccome il digitale porta con sé una forte componente visiva (la “retorica visuale del Web” come la chiamava Jay David Bolter) non sorprende che la forma narrativa più massicciamente influenzata da questo processo sia stata il cinema. Se si dovesse fissare un punto di passaggio dal cinema postmoderno a quello dell’hyperfiction questo sarebbe probabilmente Inception di Christopher Nolan (2010), un film sul fare film nell’epoca della possibilità tecnica illimitata, costruito sul modello di scatole cinesi e spazi alla Escher dai quali è impossibile uscire: davvero il postmoderno al massimo delle sue potenzialità, estremizzato, esagerato fino all’ipertrofia.
Dopo il rito di passaggio rappresentato da Inception il genere è andato verso una sua definizione, come provano due film del 2013: Pacific Rim, vera e propria messa in scena cinematografica del gioco di un bambino (maschio: l’hyperfiction, nella sua forma di realtà artificialmente aumentata fino alla saturazione, ha qualcosa di intrinsecamente, quasi sfrontatamente maschile) dove tutto è grande oltre ogni possibile immaginazione e la distruzione è incalcolabile; e soprattutto Gravity, film senza scenografie e quasi senza recitazione, costruito sulla retorica del movimento in uno spazio senza confini, perfetta manifestazione hyper del “desiderio ludico” inscritto nel cinema; passando dalla sequenza finale di Interstellar (2014), ancora di Nolan, che nella forma del tesseratto cita il cubo di The Cube (1997), con Matrix (1999) forse il principale antenato dell'hyperfiction al cinema; per finire con la cacofonia di esplosioni e movimenti artificialmente accelerati di Mad Max: Fury Road (2015).
Mi sembra però interessante notare come il concetto di hyperfiction possa essere applicato agevolmente anche alla letteratura, e nello specifico a due libri che in anni recenti hanno ottenuto uno straordinario successo di pubblico: Il cardellino di Donna Tartt (2013) e L’uomo di marte di Andy Weir (2014), da cui Ridley Scott non per nulla ha tratto il suo Sopravvissuto - The Martian. Riguardo al Cardellino è stato autorevolmente citato Dickens, ma parte della straordinaria potenza del romanzo si deve al fatto che i suoi personaggi si muovono all’interno di uno universo narrativo privo di barriere: il protagonista Theo Decker è un’identità vuota e dunque aperta a infinite metamorfosi, non esistono nessi causali forti (non si scoprirà mai chi o perché ha fatto esplodere la bomba che ha ucciso la madre di Theo), i personaggi entrano ed escono di scena come da dietro le quinte di un teatro e gli ambienti cambiano come in un diorama: al di fuori dello spazio della narrativa (è uno dei punti centrali della poetica di Donna Tartt) sembra non esistere niente.
Discorso simile si può fare per L’uomo di marte, che Ridley Scott ha (parzialmente) malinterpretato come una commedia fantascientifica: in realtà il romanzo di Weir è più simile a una lunghissima punta di MacGyver, un “How it’s made” futurista o un manuale di istruzioni per la NASA scritto in stile brillante. Siamo sempre nell’ambito del puro gioco, in cui il godimento è innescato dall’azione fine a sé stessa senza secondi livelli di lettura: per questo Marte nel romanzo non si vede quasi mai, non significa niente, è lontana anni luce dal possedere le connotazioni metafisiche che ha assunto (insieme a tutto lo spazio profondo, a tutti i mondi altri) nella fantascienza pienamente postmoderna degli anni Sessanta e Settanta.
Niente di tutto questo è una novità assoluta: basti pensare a quando Susan Sontag scriveva, nel 1966, che “al posto dell’ermeneutica ci serve un’erotica delle arti”; o al fatto che la teoria dei giochi ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle scienze, della psicologia e della matematica in tutta la seconda metà del XX secolo. Ma estremizzando una sua caratteristica intrinseca (l’aspetto ludico, il distacco ironico) la narrativa postmoderna si sta trasformando in qualcosa di diverso da sé stessa: specularmente alle varie forme del Nuovo Realismo, che sostengono che esiste solo la realtà e niente al di fuori della realtà, l’hyperfiction ci dice che niente esiste al di fuori della rappresentazione: e che questa altro non è che un gioco senza fine.
gianluca.didino@gmail.com