Politica e letteratura / Figure di cartone – Sei valigie di Maxim Biller
Famoso per le sue prese di posizione nette soprattutto contro l’asservimento della letteratura alla critica giornalistica e alla “categorizzazione a priori” dei letterati e dei recensori, oltre che a ciò che noi abbiamo chiamato per molto tempo establishment culturale (di cui scelse a modello la Süddeutsche Zeitung: “the central organ – with its huge circulation – of the narcissist German reactionary left.” (<Tablet World>, 10 Nov, 2014), Biller resta uno degli autori più interessanti del panorama contemporaneo tedesco. Sei valigie traspone in forma narrativa molte delle sue posizioni critico-letterarie, utilizzando in maniera evidente le tecniche della parodia e della riscrittura, ben calibrate nel mosaico di isotopie tematiche, narrative, letterarie.
La più evidente, come è naturale data la sua storia autoriale, è di certo la riflessione sulla scrittura, la lettura e la materialità dell’atto letterario: il testo è costellato di macchine da scrivere, vocabolari – la scrittura plurilingue, la traduzione – fogli, lettere, carta stampata. Il discorso intessuto nel racconto rappresenta e narrativizza le posizioni rispetto al rapporto tra tra politica e letteratura, portate così a un compimento tramite una compatta e rigorosa forma metaletteraria, in un romanzo che lui stesso ha definito una Forschungsfiktion, una “ricerca-finzionale”. Mentre alcuni hanno visto in questo romanzo una provocazione meno accentuata, una ricollocazione tramite la lettura del corpus delle opere dell’autore gli rende lo spessore critico e lo sgancia dalle interpretazioni storico-biografiche (che colgono quindi un aspetto del testo, ma non il complesso). La provocazione intellettuale, metacritica, testimoniale, agisce sul rapporto diegetico, arriva a rimodellare in questo caso la rappresentazione dell’autore nel “falso” racconto autobiografico che comporta la dissoluzione della figura dell’“autore implicito”, e si spinge quindi a criticare la “moda” dell’autofiction, della narrazione autobiografica epica contemporanea, e dell’approccio letterario “per il pubblico”, ricalcando proprio l’andamento della riflessione teorico-critica delle tre lezioni contenute in Literatur und Politik.

Così, come Bruno Schulz nella novella di cui è protagonista (Nella testa di Bruno Schulz, nel volume Taci, memoria, in Italia per L’Orma, trad. di Marco Federici) crea la sua realtà di scrittura restando aderente ai suoi principi poetologici, in Sei valigie Biller “scrive” una sua famiglia, o meglio, mitizza una forma della sua famiglia, partendo da una materia somigliante alla realtà, fino a smussare un’immagine letteraria, e teatralizza l’operazione compositiva in maniera fruibile ed evidente. Nei rapporti intra e intertestuali, nella costruzione di un testo che congiunge gli stilemi tipici del romanzo di genere alla metatestualità, Biller mette in evidenza e sfida lettori e critici alla ricerca di quella ibridità/idiosincrasia eletta dall’autore a caratteristica della letteratura. La cifra satirica stessa non è annullata, ma consegnata alla parodia della riscrittura, a partire dalla ricontestualizzazione della narrazione (fintamente) autobiografica per ritratti, tipica di molte autobiografie del Novecento di lingua tedesca.
La società del tradimento
I testi di Biller sono sempre, a ben guardare, molto espliciti rispetto al senso della poiesis letteraria e anche della lettura come strumenti di riappropriazione della realtà – innanzitutto come materia prima, in seconda battuta come terreno d’azione. Cifra ricorrente delle metafore è il legame con il tradimento, che, come nelle Scritture, è innanzitutto un tradimento di un patto generativo, che, una volta violato, si può ricostituire solo in una prospettiva altrettanto generativa. In un racconto un po’ meno noto in Italia, dal titolo Verrat/ Tradimento si narra del giovane Hugo Niehouss, un teenager di una famiglia borghese benestante di Amburgo, di inclinazioni romantiche, che, come molti tedeschi contemporanei, sviluppa una vera e propria ossessione per tutto ciò che è “ebreo”. Solo quando comincia a indossare una stella di David al collo, a mangiare la Pesach e ad andare in sinagoga, il padre gli rivela che la madre, Andrea Niehouss, si chiamava in realtà Lea Sonnenson, ed è una sopravvissuta alla Shoah, immigrata dalla Polonia e che ha scelto la conversione, perfettamente assimilata nella società. È allora che il protagonista sceglie di aderire completamente alla fede ebraica, di circoncidersi, di abbracciare la sua ascendenza con energia. Di conseguenza – di qui gli elementi più satirici del testo – percorrerà la carriera da giornalista, diventando uno dei più importanti industriali dell’informazione, almeno in parte grazie alla sua identificazione come ebreo. Eppure la relazione con la famiglia ne risente, Hugo prende le distanze da coloro che hanno rifiutato il loro passato, attribuendo a loro il tradimento. Con la madre smette di parlare, finché in un finale che resta però aperto Biller lascia che i due si incontrino e si scambino uno sguardo proprio in una libreria.
In Sei valigie il tema è ri-composto. Un io narrante, inizialmente adolescente, indaga sulle circostanze della condanna a morte di suo nonno, che nel 1959 si era messo in viaggio da Mosca per raggiungere il nipotino appena nato. All’aeroporto il nonno viene fermato per controlli e arrestato per spaccio di denaro con l’ovest, per essere poi giustiziato due mesi dopo. Ogni parte del testo si concentra sulla visione dei fatti da parte di un componente della famiglia, da cui il protagonista viene a conoscenza di eventi taciuti o a lui sconosciuti, di persona o tramite documenti o lettere, con l’intenzione di “scoprire” il delatore.
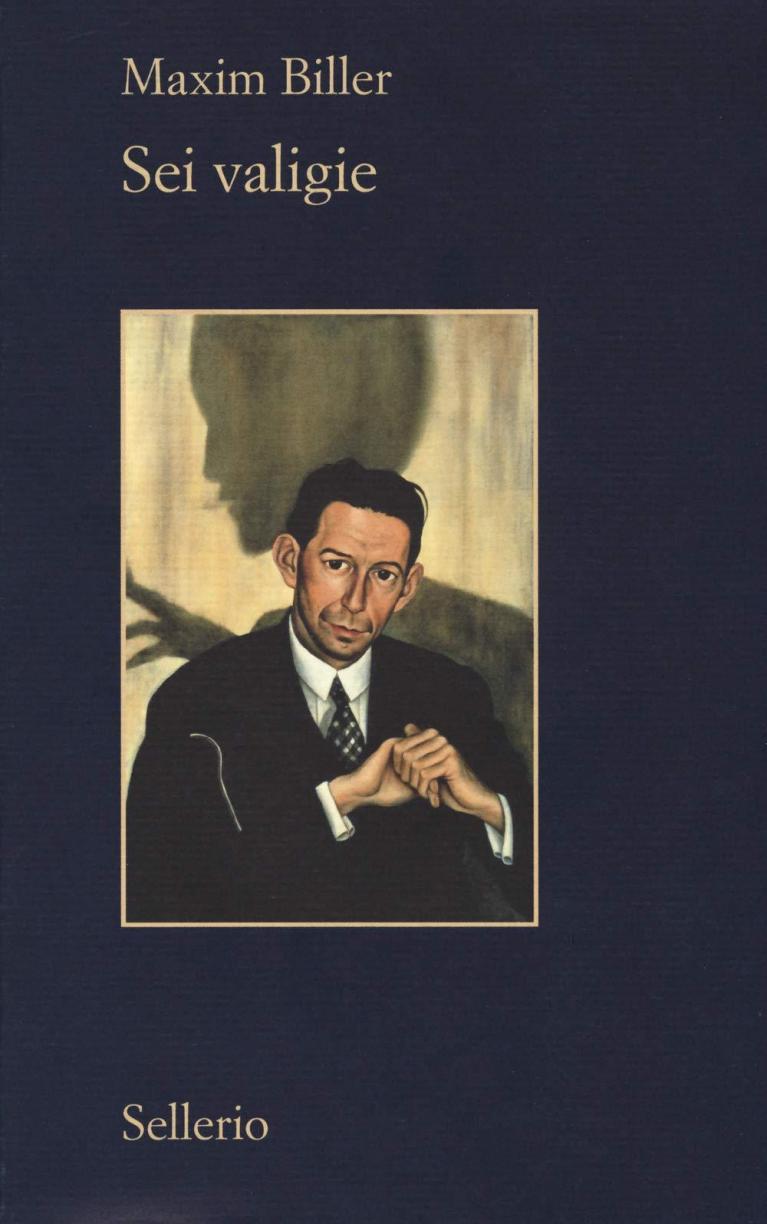
La scelta consente a Biller di attraversare e citare con agilità e stile serrato generi, modi e atteggiamenti autoriali (autobiografia, autobiografia finzionale e fittizia, spy story, mistery, romanzo storico), ibridizzandoli senza annullarli. I personaggi vengono ostentatamente accompagnati in un percorso che dal passato li conduce al presente narrativo: Dima, uno zio che vive in Svizzera, delineato fin nelle prime pagine come “pecora nera” della famiglia, ha passato cinque anni in carcere in Cecoslovacchia per contrabbando e tentativo di emigrazione verso l’ovest, Lev e Wladimir (i due fratelli maggiori) sono da sempre in occidente, Wladimir in Brasile, Lev in Germania, a Berlino Ovest, mentre il padre del narratore, Sjoma, traduttore letterario, e Natalia, la moglie di Dima un tempo erano una coppia. Su queste semplificate tensioni personali si costruisce la “teoria del disvelamento” di Biller. La sfiducia, le allusioni, le omissioni sono le argomentazioni di una serrata ricerca-finzione, condotta con metodo scientifico: su carte d’archivio, lettere e tramite interviste, per giungere alla conclusione che la vita a contatto con i regimi totalitari non può che essere intessuta di inganno, menzogna e fingimenti, laddove il tradimento non può che rivelare e scontornare la sua condizione ex-negativo, la possibilità della fiducia a cui è legata la possibilità di “posarsi”, di fermarsi, la ricerca del luogo da sentire proprio. Ciò che è rappresentato è quindi innanzitutto una indagine delle motivazioni che spingono gli uomini a separarsi e tradirsi, ma anche a mantenere i legami più intensi: chi, della famiglia, ha fatto la spia in quei tempi bui?

A ogni congettura che si rivela nella sua sostanza fantasiosa e superficiale, il narratore inserisce un tassello e costruisce e crea il volume stratificato di personaggi appiattiti. Il narratore stesso deve riconoscersi un dispatriato plurilingue, un ragazzo di origine russo-ebrea. In ultima analisi, ciò che è raffigurato è un autore che conduce uno studio sulla possibilità di tenersi al di qua della morale: “ero un piccolo e cattivo Berja, un saputello, montato, ignorante, la cui preoccupazione maggiore era di non essere sgamato dal padre a fumare e che la madre non trovasse sotto il letto i fazzoletti di carta con cui si asciugava dopo essersi masturbato, e che regolarmente dimenticava lì.”
Figure di cartone
Il livello metaletterario e metacritico non è mai del tutto celato, il “patto” con il lettore non è davvero disatteso e il narratore non è mai inattendibile, perché “appoggiato” in una narrazione evidentemente parodica, con espliciti e frequenti momenti di svelamento.
Fin dal principio siamo messi di fronte alla transtestualità: il ragazzo deve studiare e scrivere di un testo di Brecht, Discorsi di profughi, e dimostra prontamente autonomia di giudizio rispetto alla tradizione e al canone: “Su che cosa dovete scrivere?” “Su una storia di Brecht che trovo incredibilmente sciocca”. Brecht, addomesticato e pertanto falsato, non è modello per il narratore, o meglio, viene rifiutato a priori. L’esergo da Brecht in apertura si configura così come amaramente ironico, ma anche profetico: “Der Pass ist der edelste Teil von einem Meschen.” (Il passaporto è la parte più nobile di un uomo), e l’intertestualità esposta è, come spesso accade, una maschera – o, in questo caso, persino una negazione – per il messaggio letterario più ampio.
Così anche il mascheramento si fa codice: i personaggi sono presentati e si presentano sempre in maschera – fino a sfiorare il pirandelliano – che è anche sempre una strategia di sopravvivenza contemporaneamente della “persona” e del “personaggio”. Accade per tutti, ma valga qui ad esempio la bella Natalia, regista e intellettuale (donna), che ha vissuto e sofferto i campi di concentramento, vive il senso di colpa per aver “lasciato indietro” la sorellina, e continua a essere tormentata dall’impossibilità di una risposta al dilemma dell’antisemitismo, oltre a essere l’unica “sospettata” che non ha legami di sangue diretti con la famiglia – forse, un cliché letterario dei più evidenti. Una lettera ritrovata da Rada, madre del narratore, che svela – diversamente che altrove – il rapporto amoroso tra il marito e la cognata (il più classico degli espedienti narrativi) rende Natalia lo snodo più evidente e spudorato per lo svelamento del livello metanarrativo ed è insieme il palesamento della maschera del narratore sia come personaggio che come “persona”:

Sei mesi dopo la morte di mio padre – aveva trascorso gli ultimi due mesi e mezzo della sua vita perlopiù incosciente nella clinica universitaria di Praga in Karlsplatz, poi in un padiglione piccolo e sporco per malati terminali dell’ospedale Vinohrady – mia madre mi telefonò da Amburgo e disse che nella sua scrivania aveva trovato una vecchia lettera di zia Natalia indirizzata a lui, che lei non avrebbe letto in nessun caso. […]
“Al tuo posto mi sarei arrabbiato che Natalia allora avesse sposato lo zio Dima”, dissi. “Non avrei più smesso di avercela con lei”.
“Se avesse sposato tuo padre – allora ce l’avrei avuta con lei!” […]
“Credi”, chiesi a mia madre, “che abbia anche tradito Dima?”.
“Come faccio a saperlo?”, disse, a un tratto molto seria e spaventata. “Perché insisti con le domande? Stai di nuovo scrivendo qualcosa su di noi?”.
“No, mamma”.
Qui l’autore/narratore si sdoppia, si definisce e si fa delatore, si rende traditore (ma quindi anche trasportatore) di un tipico segreto di famiglia, fino a svelare i particolari sentimentali della relazione nel riportare la lettura integrale della lettera, e a mettere il lettore con ironia, ma anche una certa aggressività, di fronte al voyeurismo di certa letteratura.
Volevo davvero sapere tutto questo?, mi chiesi a Berlino, nella mia cucina, quasi cinquant’anni dopo che Natalia aveva scritto a mio padre da Montréal. Volevo sapere con quali vezzeggiativi mio padre aveva chiamato mia zia? Volevo vedere, parola per parola, riga per riga, quando si baciavano, e quando litigavano e quando la facevano finita?
E infatti il cliché riguarda la scrittura di Natalia, una lettera “troppo” bella, coinvolgente, una narrazione cronologica e introspettiva, dai tratti psicologizzanti, sulla addomesticata concezione della Shoah (e più precisamente anche della letteratura testimoniale “al femminile”). Le domande retoriche della scrivente, espresse e immediatamente riconoscibili come dilemmi dell’antisemitismo, sono da considerarsi (insieme agli interrogativi evocati dalle tecniche di scrittura) parte fondamentale del messaggio del testo: sono rivolte al lettore, chiamato a prendere posizione su una sintesi che di fatto non concede spazio ai dubbi. “Mi chiedo” – scrive Natalia – “perché ci odino … se non ci fossero più ebrei, sentirebbero la nostra mancanza?”. La narrazione procede, la lettura della lettera va avanti, ma il personaggio di Natalia resta, come tutti gli altri, una figura tratteggiata, percepibile come più tonda e oggetto di identificazione grazie proprio alle convenzionalità della letteratura triviale. E infatti, in una parodica tipizzazione tragica, va incontro alla sua fine di solitudine e morte.
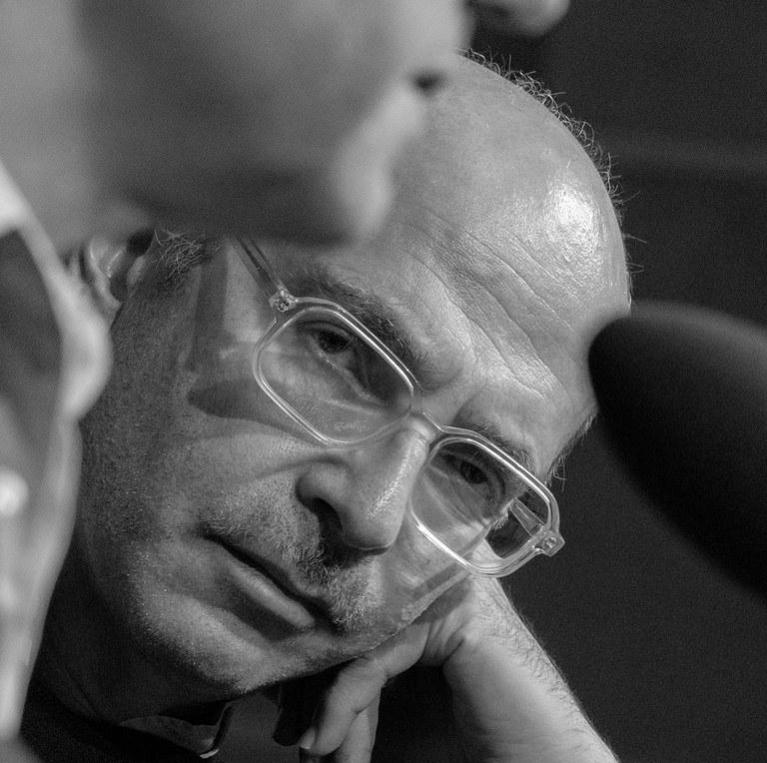
Più palesemente di Natalia, gli altri personaggi sono come ritagliati in uno spesso strato di cartone, per una scenografia già pronta, personaggi tipici di un romanzo di avventure, di una detective o spy story, mitizzati nella loro scarna essenzialità. Nella sua continua e insistente lotta alla categorizzazione, la satira è tutta sul livello metacritico: Biller non la esercita contro il desiderio di venire a conoscenza del proprio passato, o la necessità di trovare un modo coerente per raccontarlo, ma contro l’addomesticamento di quel desiderio e di quella necessità.
Una spia di questa intenzione è proprio in alcune descrizioni dei protagonisti: in maniera apertamente razzista, hanno lineamenti “troppo ebrei”, o uzbeki, identificabili con un “est” vago, che non esiste se non in definizioni letterarie, storicizzate e stereotipate. D’altro canto, la psicologia dei personaggi è evanescente. Ogni protagonista è composto di diversi strati di materiale, che si affastellano col procedere della narrazione. Ma ad ogni pannello, tagliato con andamento netto, i contorni non combaciano con le figure già intagliate. Lo spazio letterario del testo è negli interstizi che si creano tra un pannello e la sua forma preritagliata, è in quel sottile spazio vuoto che si rivela l’intenzione dell’autore e si materializza la possibilità interpretativa del lettore, gradualmente scosso nelle sue sicurezze.

La metamorfosi letteraria riesce nell’intento di illuminare ciò che è essenziale al di là delle categorizzazioni teorico-critiche: il ritratto di un gruppo di persone definite dal non poter essere, non poter stare, non poter appartenere se non a se stessi e alla narrazione condivisa. Non sarà dato sapere chi è e se c’è un traditore, né sapere quali parti del racconto siano basate sui fatti e quali siano del tutto immaginarie, e in questo finale aperto si compie il rimodellamento del rapporto autore-pubblico. Biller insiste nel suo messaggio, la famiglia mitizzata è il precipitato di un’esperienza personale, ma non è la descrizione della difficoltà subita il senso del testo. Il racconto distilla così tutte le istanze dell’autore: narratore, critico, impegnato, ma mai “moralista marcescente”. Tra tutte il rapporto con le proprie ascendenze, con il passato condiviso e personale, con una biografia intellettuale che può diventare “radicale” se svincolata dalla ricerca dell’identità e coniugata con la libertà di narrarsi.
La condizione e scelta narrativa metacritica possiede inoltre tutta la portata politica di azione sul contemporaneo, perché nel ristabilire i rapporti di realtà e verosimiglianza, nel ricontestualizzare la creazione dei personaggi e il rapporto tra l’autore e i propri personaggi, offre la possibilità di stabilire una connessione meno “ridicolizzata” dell’ebraismo con la società che lo recepisce in quanto pensiero, prima fra tutte la società in cui Biller scrive: la Germania che ancora fa i conti con la Shoah. Ma in questo non ritaglia una categoria, bensì rende evidente come la libertà di chiedersi e decidere a chi e cosa si deve un legame, ma anche di riconoscere cosa e a chi si è tenuti a raccontare, o cosa e quando, in una vita, va tutelato e ricostruito, e soprattutto indica perché la memoria in tutte le sue gradazioni – collettiva, sociale, relazionale e individuale – è una questione contemporanea che riguarda tutti, ma in primis chi si attribuisce il compito di scrivere, descrivere e raccontare il mondo.
Sei valigie di Maxim Biller, Sellerio, 2020, pagg. 163, 15 euro (tit. or. Sechs Koffer, Kiepenhauer&Witsch, 2018), trad. di G. Agabio.









