Da Venezia a Reggio Emilia / Damien Hirst. Fantasmagorie della finzione
In un grande lightbox liquido inabissato a Punta della Dogana – come la prua di un vascello arenato, nella città dell’acqua per antonomasia – ci troviamo in uno spazio sottomarino, appunto, dai colori squillanti. Due masse confuse, intuiamo gigantesche, si fronteggiano in lontananza; all’avvicinarsi cauteloso della camera si mettono gradatamente a fuoco, finché d’un tratto riconosciamo due archetipi plurimembri: un’orrorifica Idra e una seducente Dea Kali, che impugna una lama in ciascuna mano. Lo stesso impossibile incontro-scontro è presente, in due versioni, nella medesima sala: in una il colossale gruppo scultoreo in bronzo (cinque metri d’altezza per sei di lunghezza e tre di larghezza) è ricoperto di incrostazioni calcaree, coralli e muffe, conchiglie e madrepore; nell’altro, presentato come una «copia» del precedente, i due corpi tortili si presentano invece perfettamente lisci, glamour e sexy come in un fumetto di Moebius inopinatamente tridimensionalizzato; un ulteriore lightbox presenta una scena simile a quella del primo, ma ora attorno al monumento inabissato si aggirano quattro sommozzatori che lo illuminano, lo riprendono, si apprestano a imbragarlo per farlo riemergere alla luce.


Damien Hirst, Hydra e Kalì, Venezia, 2017.
È l’highlight drammaturgico – cinematografico, anzi – della mostra-kolossal con cui Damien Hirst ha invaso Venezia – tanto estesa da occupare per intero entrambi gli spazi di cui s’è appropriato in città il complice François Pinault: oltre a Punta della Dogana, Palazzo Grassi –, Treasures from the Wreck of the Unbelievable (a cura di Elena Geuna, sino al 3 dicembre). Più che una mostra, una narrazione multimediale (ai numerosi video sottomarini, dalla resa visiva che nulla ha da invidiare alle più stupefacenti riprese di James Cameron, si aggiungono un tutorial interattivo che ci fa entrare nel vascello naufragato, unaserie di disegni e stampe di simulata fattura rinascimentale, soprattutto centinaia di etichette pseudomuseali straripanti di pseudoerudite informazioni, ciascuna evocativa come un racconto): quella del ricchissimo liberto di Antiochia Amotanius (alias Cif Amotan II, alias Aulus Calidius Amotan), vissuto tra la metà del I e l’inizio del II secolo d.C., che, raccolta nella sua hybris d’affrancamento la più preziosa collezione di statue, monili e cimeli provenienti dalle più varie culture dell’antichità, la carica sul più grande vascello mai costruito, l’Apistos (ossia «Incredibile»), indirizzandola a un tempio, da lui costruito per conservarla, sulla costa orientale dell’Africa. Il nuovoantico Titanic però fa ovviamente naufragio, e il Tesoro dell’Incredibile per quasi duemila anni resta immerso sott’acqua. La leggenda del tesoro perduto fiorisce nei secoli – da Pausania ai dotti rinascimentali – finché un anticonuovo liberto del nostro tempo, altrettanto facoltoso e altrettanto desideroso di rivincita, investe tutte le sue risorse nell’impresa del recupero. Individuato il relitto nel 2008, per nove anni si lavora al restauro, all’inventario e all’interpretazione dei reperti: che oggi, per la prima volta, vengono esposti al mondo.

Damien Hirst, Andromeda e il drago, Venezia, 2017.
Tutto finto, ovvio. Tranne l’hybris, e la scommessa miliardaria (sessanta milioni di dollari, si vocifera: costo davvero paragonabile a quello di un blockbuster hollywoodiano), di Damien Hirst. Cioè il «collezionista», un cui auto-busto bronzeo figura a sua volta in mostra: mise en abîme delle infinite marche di finzione esibite (dall’incontro impossibile di figure di mitologie distanti come Kali e l’Idra all’uso di materiali a loro volta impossibili come il marmo di Carrara a scritte ben visibili, a tergo di certe statue, come «1999 Mattolini CHINA»; dalle citazioni di artisti contemporanei, e comunque futuri rispetto al periodo raccontato – Jeff Koons, Pierre Huyghe, Roberto Cuoghi, ma anche l’Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia –, sino a presenze pop grottescamente incongrue come Mowgli e Baloo del Libro della giungla, Pippo e Topolino, addirittura il robottone di Transformers presentato – con incongruenza al quadrato! – come idolo azteco: tutti debitamente fioriti delle incrostazioni sottomarine che fanno da leitmotiv dell’insieme).

Damien Hirst, Transformers, Venezia, 2017.
Questa spettacolare apoteosi iper-barocca del finto – che si contrappone al falso, appunto, per la sua provocatoria evidenza –intende evidentemente decostruire, col sarcasmo e l’arroganza che ben si conoscono nel trickster di Bristol, ogni ipotesi di filologia, attribuzionismo, ordine del discorso museale. Cioè ogni distinzione, appunto, tra vero e falso. L’arte come menzogna, si potrebbe manganellianamente dire: ma rivolta, anziché all’angosciosa decostruzione delle nostre (pseudo)certezze, a una spettacolarizzazione nichilistica – da postremo postmodernista sull’isola deserta – dell’azzeramento della storia. Emblematica la prima opera che ci accoglie a Punta della Dogana, un grande disco calendariale attribuito alla (dagli antichi parimenti inattingibile) cultura azteca. Infatti è proprio il tempo, la cronologia, il vero oggetto della finzione. Non senza intelligenza Hirst si riallaccia così alla discussione in corso sull’anacronismo, sovvertendone però il vettore: da ricerca di una verità preterita dalla violenza della storia (si pensi appunto, per esempio, alle indagini di Cuoghi sugli Assiri) all’allestimento di un luna park, indubbiamente esilarante, ma dall’esito a somma zero: consegnandosi cinicamente, come ha scritto sul manifesto Teresa Macrì, al «godimento futile dell’evento spettacolare» da parte delle orde di visitatori. Intanto già nelle prime settimane di “evento” pare che dai collezionisti (quelli veri) siano arrivati ordini per diversi milioni: e dunque, come ha scritto con asprezza Robert Storr sulla Lettura del Corriere della Sera, se non nella storia dell’arte, l’episodio – come già l’ominoso teschio di diamanti di For the love of God–è destinato a entrare in quella degli investimenti finanziari (ma una storia dei costi materiali dell’arte, sino alle concrezioni di lapislazzuli e malachite esposte da Hirst a Venezia, riuscirebbe assai istruttiva da leggere).

Damien Hirst, Calendario azteco a Punta della Dogana, Venezia, 2017.
L’exploit s’incastona bene, in ogni caso, in una Venezia che ossessivamente s’interroga, in Biennale e fuori, sulle forme della narrazione – e sullo statuto della verità, appunto, che ogni performance narrativa inevitabilmente mette in questione: ben prima, si capisce, della così trendy discussione attuale sulla «postverità». Se la piatta mostra centrale, curata da Christine Macel coll’enfatico quanto generico titolo di Viva Arte Viva, è affollata di opere documentarie dai toni risentitamente autenticisti (che si accontentano, cioè, della mera ostensione di dati“reali”, al di qua di ogni loro elaborazione formale), nei senz’altro più interessanti padiglioni nazionali il discorso, opportunamente, si complica. In quello neozelandese, per esempio, uno spettacolare diorama di Lisa Reihana (una 52enne Maori), In Pursuit of Venus (infected), racconta in mezz’ora di “impossibile” piano-sequenza la storia dell’incontro fra Europei e Polinesiani, riproducendo con ironia sottile i toni edulcorati e oleografici coi quali l’evento veniva raffigurato ai primi dell’Ottocento.

Lisa Reihana, In Pursuit of Venus Infected, Venezia, 2017.
Quest’uso controveritativo dell’anacronismo è ancora più marcato nel lavoro bellissimo della 56enne Tracey Moffatt, che nel Padiglione Australia – intitolato nel suo insieme My Horizon (catalogo Thames and Hudson, a cura di Natalie King) – colloca per esempio Vigil, un fotomontaggio di stills da film di Hollywood dove lo sguardo inquieto, quando non proprio terrorizzato, di star come Elizabeth Taylor e Cary Grant incrocia, in “impossibili” controcampo, le scene drammatiche dei viaggi e dei naufragi dei rifugiati di oggi; ma anche, con allusivo chiasmo, il poetico The White Ghosts Sailed in: un breve ed enigmatico video girato nella baia di Sydney che, dilavato e graffiato in toni seppia, si presenta realizzato dagli Aborigeni nel 1788 (!), all’arrivo delle avanguardie europee al comando del capitano Arthur Phillip.

Tracey Moffatt, The White Ghosts Sailed, Venezia, 2017.
Le immagini, all’inizio solenni ed elegiache, a un certo punto accelerano, si spezzettano – come riprese da un operatore in fuga –, alludendo a una violenza tanto invisibile quanto storicamente documentata. L’uso del finto e dell’anacronismo, con procedimento perfettamente speculare rispetto a quello di Hirst, intende così produrre un documento impossibile, certo, che fa però riferimento a una storia vera: dando voce – in questo caso per immagini – a chi, come gli Aborigeni messi a tacere dalla violenza del tempo, non ha potuto trasmettercela.

Moira Ricci, Da buio a buio. Lupo mannaro, Quadriennale, 2017.
L’autrice che più poeticamente incarna da noi queste tensioni – tra vero e falso, tra impossibile e necessario, tra passato e futuro – è la quarantenne toscana Moira Ricci. Che, a differenza della maggior parte dei suoi coetanei, lavora con lentezza: solo negli ultimi tempi sono stati davvero valorizzati suoi lavori risalenti a diversi anni fa, stratificati nel tempo come del tempo mettono a tema anse torpide e gorghi improvvisi. Risale al 2004, per esempio, la serie 20.12.53-10.08.04; tecnicamente semplici – realizzate con Photoshop –, le immagini hanno un’intensità emotiva lancinante: le foto di famiglia che ritraggono la madre scomparsa sono ritoccate dall’artista inserendo accanto a lei la propria stessa immagine. L’effetto Forrest Gump così ottenuto, però, nulla ha di ludico; e, se è implicita nell’operazione una certa ironia nei confronti dell’abuso patetizzante che nell’arte di oggi viene fatto delle foto di famiglia, lo struggimento trasmesso ha una sua bizzarra quanto innegabile autenticità.




Moira Ricci, 20.12.53, 2004.
Lo stesso si può dire di Dove il cielo è più vicino, un lavoro iniziato nel 2014 che ora si trova esposto nei Chiostri di San Domenico a Reggio Emilia (sino al 9 luglio, nell’ambito del Festival Fotografia Europea, curato da Elio Grazioli e Walter Guadagnini col titolo Mappe del tempo. Memoria, archivi, futuro): all’inizio del percorso vediamo dall’alto, in una lunga ripresa ipnotica realizzata da un drone, un doppio cerchio di fuoco divorare un campoarato già strinato dal crepuscolo estivo; alla fine un altro video ci mostra, accelerando in un’ora un lavoro durato giorni, un gruppo di persone – il padre dell’artista e altri famigliari e vicini di contado –che, a partire da una vecchia trebbia in disuso, costruiscono un’astronave, dall’aspetto fatiscente e improbabile come quello delle prime rudimentali macchine volanti nei filmati d’inizio Novecento. Esposti sono infine dei grandi pannelli sui quali, a grandezza naturale, sono riprodotte le immagini dei contadini che hanno partecipato all’impresa. Ciascuno di loro, con angolazioni diverse, guarda verso l’alto: con un’espressione indefinibile, un misto di attesa fiduciosa e inquietudine sottile, come pre-elaborando la nostalgia del futuro dal quale si troveranno inevitabilmente esclusi. Come in altri lavori “narrativamente” articolati di Ricci (penso alle «leggende rurali» di Da buio a buio, risalenti al 2009 ed esposte da Matteo Lucchetti all’ultima Quadriennale, al Palazzo delle Esposizioni di Roma), non manca un documento (o pseudo-tale) che pretende di fornire una spiegazione all’annoso mistero dei Cropcircles – rinvenuti nelle campagne degli Stati Uniti e altrove, e in genere attribuiti all’attività di astronavi aliene –, un pamphlet tardoseicentesco sul Mowing devil dell’Hartfordshire, il demone con la falce che si sostituisce ai contadini procedendo appunto in circolo.

Moira Ricci, Dove il cielo è più vicino, Reggio Emilia, 2017.
Con Dove il cielo è più vicino Moira Ricci davvero ritorna alla sua terra d’origine, «al suolo che segna il confine dell’universo» (come ha scritto qui Mauro Zanchi); annoda una riflessione antropologica su usi e leggende della propria comunità d’origine nel maremmano (dove il fuoco è davvero uno strumento antico dell’agricoltura) a un discorso di nuovo pseudo-autobiografico sulla propria famiglia e a una non meno commovente, a ben vedere, narrazione fantascientifica a ritroso (un po’ come quella che, nel magnifico inizio in Interstellar di Christopher Nolan, mescolava suggestioni faulkneriane a ipotesi futuribili). I paesaggi rurali, illuminati da colori vibranti che paiono usciti da Terrence Malick, si fanno scenario di uno struggimento da Streben romantico, di cui ricordo l’eguale solo nell’indimenticabile Gattaca di Andrew Niccol. La memoria di un futuro irraggiungibile equivale sempre, per la razza di chi rimane a terra, al venire trafitti da un raggio laser che si chiama nostalgia.
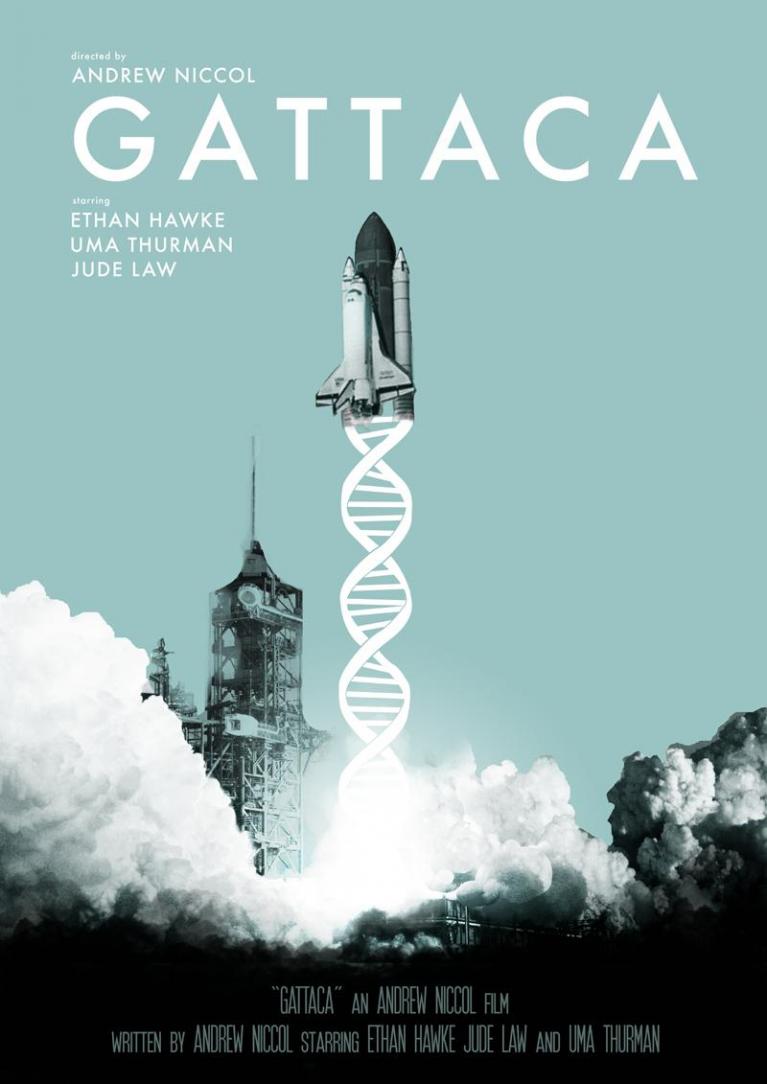

Locandine di Gattaca (1997) e Interstellar (2014).
Una versione più breve di questo articolo è uscita su «Alias» l’11 giugno









