Fidiamoci della nostra stupidità
In Costruzione dell’analisi, con l’affettata ragionevolezza di chi vuol dissipare un dubbio, Freud si riconosce senza false modestie quale terzo dei maestri del sospetto. Non che egli avesse la genuina intenzione di ascriversi a un’araldica destinata a tanta gloria nei decenni a seguire, ma le parole con cui dà avvio al suo scritto non consentono alcuna perplessità sulla sua collocazione nella formidabile terna ricoeuriana, completata, com’è noto, da Marx e Nietzsche. L’analisi, scrive Freud mutuando una critica di un “degnissimo studioso”, obbedisce al principio “testa vinco io, croce perdi tu”, secondo cui, se per certo il consenso del paziente conferma l’interpretazione del terapeuta, il suo eventuale dissenso la conferma con persino maggiore indubitabilità.
L’analista, in effetti, non può accontentarsi del lavoro conscio del paziente, e in specie delle sue resistenze, “da cui nessun analista di professione apprenderà qualcosa di cui non sia già a conoscenza” (S. Freud, Costruzione nell’analisi, Bollati Boringhieri 1977, p. 71), ma deve costruire il materiale che questi ha dimenticato e che si rifiuta di far emergere quale vittima recalcitrante e codarda. Insomma, la psicoanalisi rivendica la sua natura “sospettosa” e la sua vocazione allo scavo, al recupero di materiali andati persi, al dissotterramento di fossili che facciano luce su una vita psichica che “sta sotto” – un fondo invisibile che non si lascia scrutare se non dall’esperto, armato di casco speleo e torcia frontale. Se non bastasse, la pratica speleologica si somma al mestiere del palazzinaro, perché il terapeuta tira su edifici là dove non c’è che la desolazione di campi aridi e muti.
Ma da La Rochefoucauld e Montaigne a Kant, per il tramite di Schopenhauer, e poi di Nietzsche, Marx e Freud, per giungere a Bourdieu, Foucault e fausta progenie, il sospetto vanta una sua fulgida noblesse d’épée: il pensiero moderno e tardo-moderno mostra una propensione quasi infantile per il dubbio corrosivo e sapido che quel che si pensa, che affiora alla soglia della nostra coscienza, che si sporge sulle labbra con la convinzione dell’inquestionato, nasconda invero segreti indicibili. Non stupisce quindi la guerra al sapere comune, alla volgare produzione di senso di quegli animali linguistici che sanno solo commettere errori, sviste, e al più giganteggiano, quanto possono come possono, con qualche motto di spirito. Parte ampia del Novecento ha trovato ragion d’essere nella critica pessimistica del cosiddetto senso comune, ritenuto privo di valore epistemico perché contraddittorio, incoerente, amante corrivo della più sfacciata – ancorché denegata – parzialità. Al meglio, punto di partenza per un’indagine che presto deve disfarsi di quel corredo senza valore, lasciato in dote alla coscienza, la figlia meno nobile dell’umana conoscenza.
Il dilemma è dei più capziosi: quel che crediamo di credere fa da comoda copertura per quel che davvero ci induce a fare quanto facciamo. Pregiudizi appariscenti, scoperti, persino facili da confutare, che si depositano sul fondo del nostro modo di vedere il mondo come si trattasse di oggetti dotati di realtà, “naturalizzati” e “destoricizzati”, direbbe chi è incline alla critica sospettosa: il genere, la razza, la nazione, il capitalismo; non solo si presta credibilità ontologica a entità che sempre dipendono dal fatto che vi crediamo, ma, nel credere che davvero esistano, rimuoviamo questo loro bisogno costitutivo di nutrirsi della nostra credenza. Di qui, la missione del critico novecentesco: demistificare, cioè mostrare la natura tutta costruita, friabile, quasi fantasmatica e meschina, di quelle entità e, con il lavoro speleologico e muratoriale di cui sopra, mostrare come essi derivino da una saldissima illusione commista a un nevrotico bisogno di credervi.
Un recente libro di Anna Maria Lorusso, L’utilità del senso comune (il Mulino 2022), cerca di ristabilire le sorti di tanto vituperato senso. Il testo rintraccia le origini e mappa il funzionamento del senso comune, inteso quale filtro esperienziale della vita ordinaria oltreché riferimento di ogni nostro atto interpretativo. Lo sforzo è monumentale, se è vero che in circa centocinquanta pagine Lorusso perlustra, benché a salti, l’intero canone della riflessione occidentale, da Aristotele a Gadamer e persino oltre. Il tentativo del libro è quello di un’equilibrata difesa, poco incline alla rissa con chi fa del senso comune il campo di indecorose ideologie rudimentali, e volta piuttosto a illuminare la funzione cognitiva del senso comune, che Lorusso presenta come fondamentale per l’interpretazione del mondo in modi che siano consonanti, e quindi comunicabili, con quelli dei nostri simili. Ma dacché il presente scritto, ancorché breve, deve pur tenere svegli per qualche minuto, preferisco attenermi al tenore della polemica e spiegare come e perché l’argomento indiretto di Lorusso contro la critica del senso comune a me pare più che sensato.
I critici del senso comune, come si diceva, ne deplorano il connaturato ruolo di quinta colonna, per cui esso sembra darci orientamento ma invero insuffla ideologia, unita all’ineguagliata sua capacità di ottenere la nostra fiducia. Secondo Pierre Bourdieu, il più solido e acuto dei critici novecenteschi, il senso comune non è che un consenso pratico, dossico, sul senso delle nostre pratiche ordinarie. Dossico e pertanto altamente tossico, perché il carattere di opinione del senso comune, istintivamente riottoso alla messa in questione e alla richiesta di evidenze a supporto, satura l’aria al punto che il regime di inossidabile sperequazione tra dominanti e dominati a questi ultimi fa respirare nient’altro che il veleno obnubilante spirato dai polmoni dei primi.
Il senso comune è il deposito di quella violenza simbolica mediante cui “i dominati applicano categorie costruite dal punto di vista dei dominanti ai rapporti di dominio, facendoli apparire come naturali. […] La violenza simbolica si istituisce tramite l’adesione che il dominato non può non accordare al dominante (quindi al dominio) quando, per pensarlo e per pensarsi o, meglio, per pensare il suo rapporto con il dominante, dispone soltanto di strumenti di conoscenza che ha in comune con lui e che, essendo semplicemente la forma incorporata del rapporto di dominio, fanno apparire questo rapporto come naturale” (P. Bourdieu, Il dominio maschile, Feltrinelli 2009, p. 45).
Che chi legge ne tragga un senso claustrofobico di trappola non può stupire, perché in fondo ci vien detto che ogni nostro atto di conoscenza è un atto di misconoscimento di quanto davvero ci domina e che, ogni volta che tentiamo un via di fuga, invero non facciamo che tendere la corda che ci tiene legati. Ma perché consegnare il senso comune a una figura tanto misera nell’affresco della nostra vita ordinaria? La risposta di Bourdieu è che esso e solo esso assicura la regolarità delle nostre pratiche, l’accordo tra le nostre azioni e le altrui aspettative, la riproduzione senza strappi del mondo della vita, e lo fa in modo da consolidare le nostre credenze meno plausibili e più surrettizie.
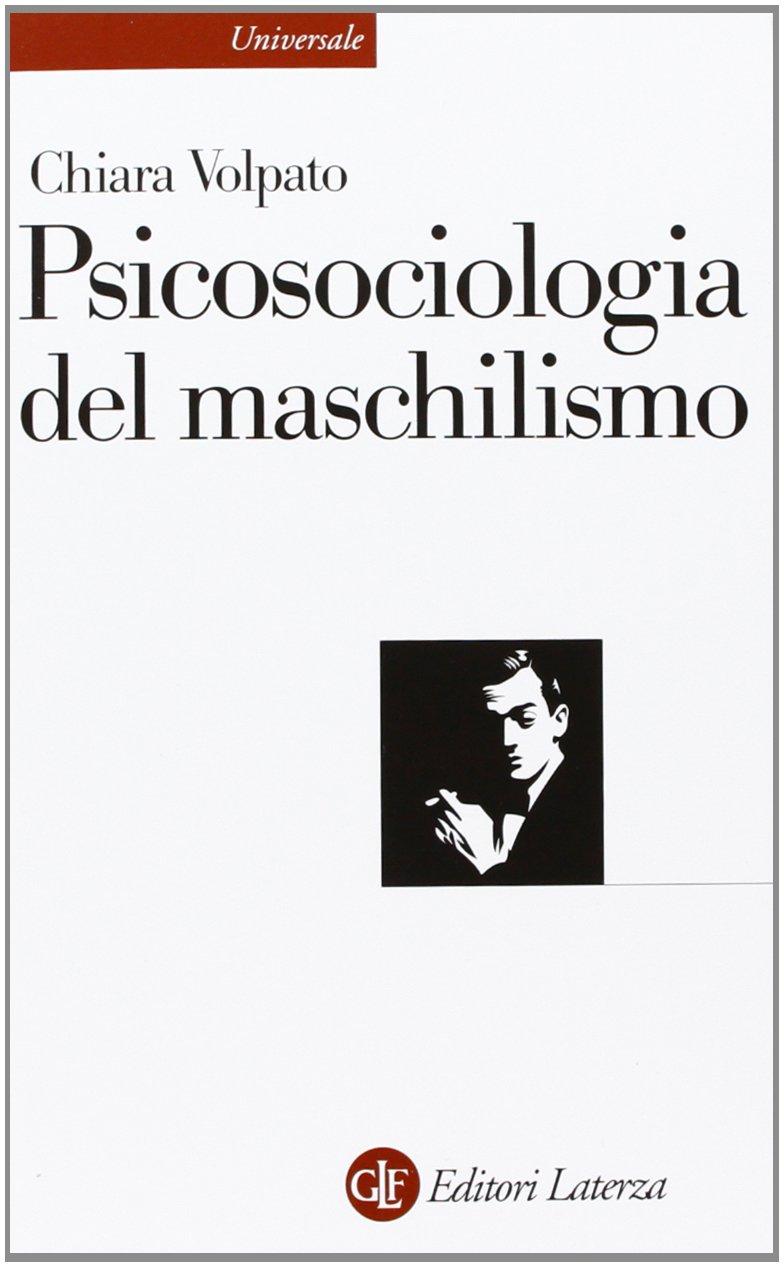
Un esempio sarà d’aiuto. Con vaga ispirazione bourdieusiana, Chiara Volpato parla del neosessismo o sessismo moderno come di quella forma di discriminazione inconsapevole e condiscendente per cui si crede che, nei tempi nostri modernissimi e illuminati, la differenza tra uomo e donna sia un pezzo triste di storia del patriarcato chiuso da tempo nell’archivio delle cattive condotte: mentre “l’ideologia sessista serve proprio a […] legittimare la superiorità maschile mediante un potente sistema di credenze”, “il neosessismo si esprime nella credenza che la parità tra uomo e donna sia stata ormai raggiunta e che quindi le misure di contrasto alla discriminazione siano inopportune” (C. Volpato, Psicosociologia del maschilismo, Laterza 2022, p. 57). Insomma, proprio la convinzione diffusa (direi di senso comune) che la donna oggi abbia raggiunto una tendenziale posizione di parità fa da reagente per un sessismo atavico che semplicemente muta di forma.
E così, continua Volpato, le forme più insidiose di senso comune sessista, ancora ben radicato in dominanti e dominate, prolificano senza disturbo: l’autosessualizzazione per cui le donne si conformano ai canoni estetici maschili e si presentano come oggetti attraenti in competizione tra loro; la caratterizzazione delle donne come inclini alla dolcezza, alla gentilezza, alla comprensione e sempre infuse di un senso rassicurante di solidarietà, di contro a uomini caparbi, ruvidi, egoisti, proclivi all’agonalità più esasperata; la generale credenza secondo cui la psicologia femminile è la sede di un’ineffabile senso dell’intuizione, del linguaggio non verbale che penetra e lenisce, e che invece, come scrive Bourdieu, è “inseparabile dalla sottomissione oggettiva e soggettiva che invita o costringe all’attenzione e alle attenzioni, alla sorveglianza e alla vigilanza” (Bourdieu, Il dominio maschile, p. 41).
Chi potrebbe fidarsi di un senso comune tanto balordo e infido? Meglio non credergli, procedere oltre senza alcun riguardo, scavargli sotto i piedi per rintracciare palmo a palmo le catene che lo trattengono nella sua gabbia diafana. L’analisi di Lorusso, a mio giudizio, fa suo un punto teorico di massimo rilievo quando opta per un andamento, per così dire, di superficie. Nel terzo capitolo, sulla scorta del Roland Barthes più maturo, l’autrice mostra come sia affatto inutile scavare sotto il senso comune, rifiutarne le istanze cocciute, derubricarlo a sequela di sviste. L’obiettivo “non è liberarsi del senso comune, neanche della stupidità del senso comune, ma assumere quella stupidità senza imbarazzo, cioè consapevolmente” (p. 138). Barthes riconosce sì il connaturato fascismo del linguaggio, ma pure lo considera come capace di servire da luogo comune, cioè di ritrovo, e dunque anche di scambio, pertanto sempre esposto a un’auspicabile corruzione. A partire da questa ambiguità più che intima, Barthes muove sul terreno superficiale dei luoghi comuni per creare una forma di “resistenza attiva”, in forza della quale dei “fatti” si possa illuminare il carattere di participio passato: opere di costruzione, esiti della storia e del tempo, che in alcuni momenti chiave mostrano le proprie insufficienze. Il pur comprensibile sussiego dei critici sospettosi nei confronti dei luoghi comuni ne nasconde la capacità di dar luogo a transizioni di fase per cui il portatore di senso comune passa da uno stato di spontanea acquiescenza alle idee diffuse a quello di una (possibile) presa di distanza riflessiva.
In effetti, scrive Lorusso, si verificano sempre le circostanze per una proficua frizione tra “un livello di sapere comune condiviso”, “un livello di sentire non per forza comune” e “un livello di disposizione ad agire condiviso” (p. 107). Anziché rivendicare potestà censoria, il sapere critico deve potersi infiltrare tra le credenze che si sono fatte stereotipi per gonfiarne le venature ed eccitarne l’instabilità. Ad esempio, il linguaggio di genere, con le sue polarità isteriche e sfinite, solleva un problema che favorisce una postura riflessiva attorno a questioni di immediata ricaduta morale e politica: come e perché ci si è convinti che il maschile universale possa fungere da neutro? Come dare spazio al femminile senza invalidare lo stile o trasgredire i protocolli minimi di senso? Chi si sarà escluso quando avremo trovato una formula ospitale per i due generi dominanti? Queste domande, per il fatto solo di esser poste e di circolare con effetto corrosivo, operano quantomeno uno spostamento, utile magari a una trasformazione sul lungo corso.
Certo, evidente in L’utilità del senso comune è la vistosa propensione a riconoscere le virtù più che biasimare i vizi, a considerare il senso comune un corpo vivo che per riprodursi supera con intelligenza e istinto le difficoltà create dall’ambiente. Il senso comune – questo l’assunto ottimistico che inclina l’analisi alla speranza – viaggia sempre sul confine tra adattamento e creatività: là dove emerge un problema di ordine pratico, là dove il problema viene articolato sulla spinta di una riflessione condivisa, si danno le condizioni per una sua opportuna modifica: “L’invito allo schwa può dunque auspicare che l’uso di questo segno si stabilizzi sempre più, fino ad essere condiviso dalla comunità sociale” (p. 93), così come “il politically correct incide sul senso comune [quale] espressione di una sensibilità sociale in evoluzione, che richiede un adeguamento linguistico (che potrà arrivare solo con lenta spontaneità)” (p. 96).
Al netto di incaute fiducie, però, quello che ho descritto come un richiamo alla superficie a me pare suggerimento preziosissimo: l’ostinazione a privare di senso e valore il prodotto di pratiche sociali storiche inibisce la loro spontanea tendenza alla trasformazione. Il rischio è che, tra le opzioni per la trasformazione del sapere sociale, ne rimangano solo due: quella degli esperti illuminati che sanno vedere oltre, scavare sotto e quindi rivelare mediante gigantesche costruzioni (le quali potrebbero presto servire come nuove prigioni), o quella della rivoluzione che rovescia da cima a fondo l’ordine simbolico. Se la seconda opzione, nei decenni scorsi, si è dimostrata poco percorribile, rispetto alla prima a me pare assai più raccomandabile la sortita destabilizzante nei luoghi comuni, che certo “non è al servizio della rivoluzione, ma è la rivoluzione sopra il terreno delle parole” (E. Sanguineti, Ideologia e linguaggio, Feltrinelli 1970, pp. 134-135).









