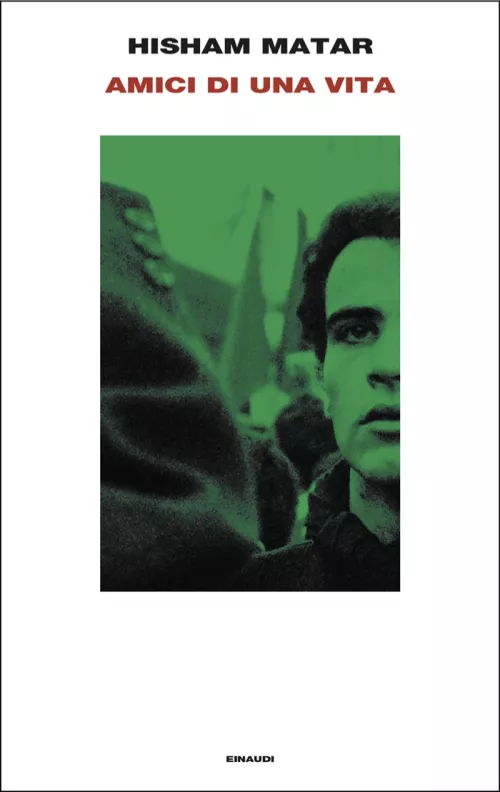Hisham Matar: l'amicizia in esilio
«Ci sono volte in cui l’assenza di mio padre mi pesa sul petto come se ci stesse seduto sopra un bambino». L'incipit di Anatomia di una scomparsa (2011) di Hisham Matar è simmetrico a quello di Amici di una vita (Einaudi 2024, traduzione di Anna Nadotti) dove l'autore scrive: "È ovviamente impossibile sapere con certezza cosa contenga il petto di chiunque" ma, mentre osserva il suo amico Hosam Zowa allontanarsi dalla stazione di King's Cross a Londra per prendere un treno che lo porterà a Parigi e poi in America, si rende conto che nessuno come Hosam era stato così vicino al suo cuore e avverte con certezza che anche lui "nel punto esatto in cui le costole si congiungono, regge un peso invisibile, un peso che da questa distanza riesco a percepire". Nel mondo islamico la "pesatura" del cuore indica che la bilancia stabilirà chi avrà una vita felice e chi, invece, "avrà per dimora il baratro": sarà felice "colui le cui bilance saranno pesanti", l'uomo che avvertirà un peso sul suo cuore. La biografia di Hisham Matar è stata un lungo percorso verso la comprensione, se non l'accettazione, del dolore, che lo porterà a riconciliarsi con la vita: "La mia famiglia se n'era andata (dalla Libia n.d.r.) nel 1979, trentatré anni prima.
Questo era lo iato che divideva l'uomo dal ragazzino di otto anni che allora ero. L'aereo avrebbe solcato quel baratro" scrive in Il ritorno (2001). Parte da New York quando compie quarant'anni, mentre la Libia andava in pezzi, e per di più – scrive in questo lucido memoir – "il primo settembre, lo stesso giorno in cui, nel lontano 1969, un giovane capitano di nome Muammar Gheddafi aveva detronizzato re Idris e si erano delineati gran parte dei tratti distintivi della mia vita – il luogo in cui vivo, la lingua in cui scrivo, la lingua in cui ora sto scrivendo – tutto ciò rendeva difficile sottrarsi all'idea che fosse all'opera una qualche volontà divina". Il peso sul cuore accompagna Hisham che, nella sua vita vera, vedrà suo padre, fiero oppositore di Gheddafi, rapito da agenti dei servizi segreti egiziani, consegnato al regime libico e incarcerato a Tripoli. Leggerà le sue lettere di scuse alla famiglia, alla moglie e ai due figli, per il dolore e le difficoltà che stavano affrontando per causa sua ma dove ribadiva che non avrebbe mai cambiato idea. Poi la carneficina del 2010 durante la quale i detenuti politici della prigione di Abu Salim, dove si trovava il padre di Matar, furono fucilati in massa, erano più di milletrecento, l'esecuzione durò sei ore. Ma la notizia che suo padre poteva essersi salvato raggiunse Matar proprio mentre stava per pubblicare Il ritorno.
Dopo vent'anni che non lo vedeva, sapere che forse era ancora vivo lo scosse profondamente. Scrisse sul Guardian: "Dov'è l'uomo che amavo far ridere? Dov'è colui che rispondeva alle mie lettere solo se erano scritte in arabo? Dov'è l'uomo che pronunciava la parola 'pazienza' come una promessa? Dov'è colui al quale avevo promesso una nipotina di nome Taswahin, ovvero 'donna che uguaglia qualsiasi uomo'? Dov'è l'uomo che mi chiamava Sharh Elbal, ovvero 'colui che placa la mente'?". Intanto, su iniziativa del Pen Club, venne pubblicato su Time, il 16 gennaio 2010, un appello firmato da circa trecento scrittori tra cui Rushdie, Ishiguro, Coetzee, McEwan, Zadie Smith, in cui si sollecitava l'allora Ministro degli Esteri britannico, David Miliband, a richiedere al governo libico il ripristino dei diritti umani e informazioni precise sulla sorte di Jaballa Matar, il padre di Hisham. In rete si trova un pezzo del 1 giugno del 2007 su Internazionale, tradotto – come sempre fa il settimanale italiano – da un articolo di Hisham Matar uscito su El Pais: "La vita ci insegna che si può trovare la pace nell'irrevocabilità della morte. Con me non è stato così: la perdita di mio padre continua a non darmi pace. Mio padre non è incarcerato ma non è neanche libero; non è morto ma non è neanche vivo. Il mio lutto si rinnova quotidianamente ed è impossibile da elaborare e da cancellare. (...) Quello che voglio è sapere cosa è successo a mio padre.
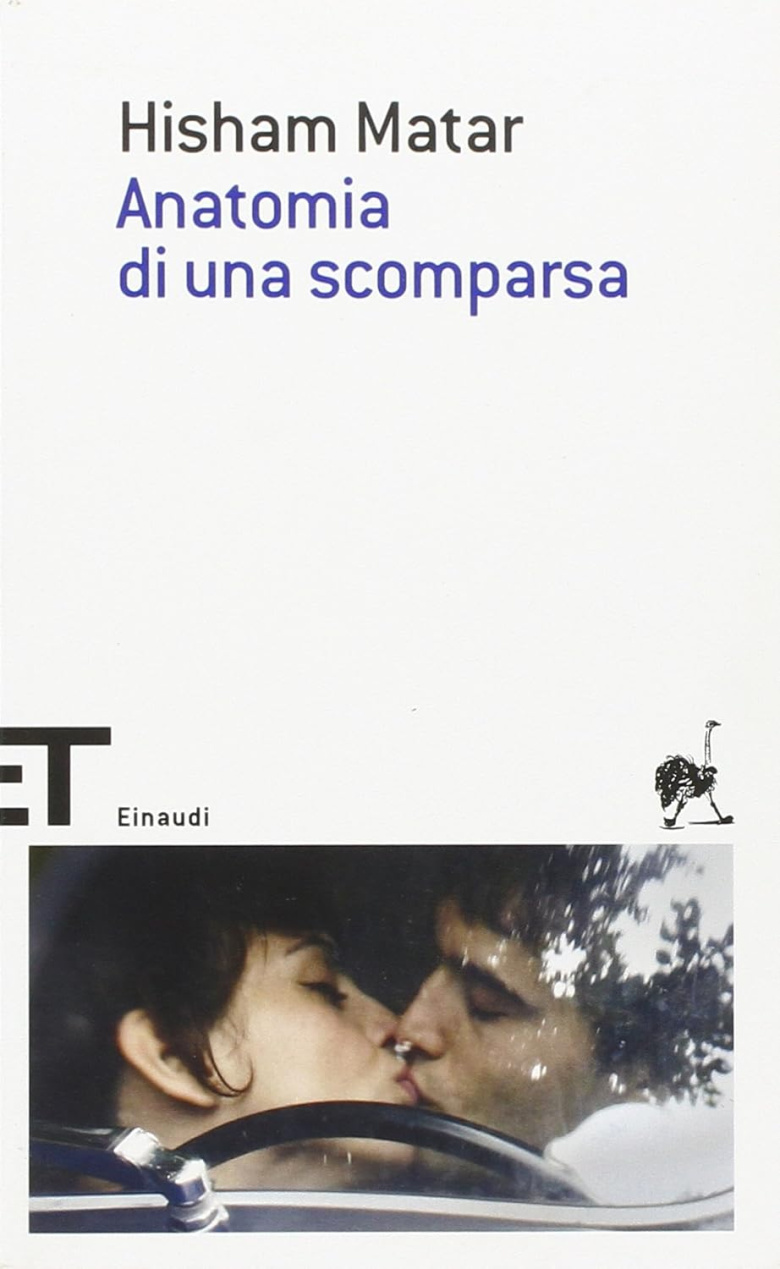
Se è vivo, voglio vederlo e parlargli. Se ha infranto la legge, dovrebbe essere processato e avere la possibilità di difendersi. Se è morto voglio sapere come, dove e quando. Voglio una data, un racconto dettagliato. Voglio sapere dov'è sepolto il suo corpo". Forse è per questo che le pagine più belle di Amici di una vita sono quelle in cui il narratore, Khaled, parla e interagisce con suo padre: "L'amore per lui mi si gonfiò nel petto, massiccio e solido come una pietra". Sono pagine che colpiscono per l'assenza di sentimentalismo, mentre emergono un amore e un rispetto profondo per la figura paterna: "indipendentemente da quanto il tempo ci ha trasformati e trasfigurati, qualcosa di noi deve sussistere e restare percepibile a coloro che abbiamo passato tanto tempo ad amare" scrive in un'altra occasione. Il romanzo abbraccia circa tre decenni, dalla metà degli anni '80 agli anni successivi alla caduta di Gheddafi nel 2011. Mentre racconta la "primavera araba" e il sovvertimento politico in Libia, si sofferma sul peso fisico e morale che il narratore, Khaled, deve sopportare a Londra, dove è costretto a vivere di nascosto, mentendo alla famiglia. Khaled, esiliato dalla Libia in Scozia per studiare, aveva pianificato di trascorrere un giorno a Londra, per partecipare con un amico a una manifestazione contro Gheddafi presso l'ambasciata libica. Ma le cose prendono una piega inaspettata e lui finisce per rimanere lì per sempre.
A Londra, Khaled fa amicizia con due connazionali, Mustafa e Hosam, e con Rana, una studentessa libanese della sua università. È un romanzo di amicizie maschili ma Rana, che ha un ruolo meno importante nella sua vita rispetto agli altri due, facilita inavvertitamente il suo incontro con Hosam, che Khaled aveva conosciuto prima di incontrarlo davvero. Risale al 1980 la prima volta che Khaled aveva sentito il suo nome, alla radio. Prima del notiziario, con molta emozione, lo speaker aveva letto il breve racconto di Hosam Zowa Quel che è dato e quel che è preso, la storia di un uomo che viene poco a poco divorato da un gatto, una sorta di allegoria politica del regime di Gheddafi. Khaled, adolescente, ne fu impressionato e si accese quel giorno il suo interesse per la letteratura, fino a fargli vincere una borsa per andare a studiare all'Università di Edimburgo. A Edimburgo Khaled conosce Hosam e Mustafa, che era stato allievo nella classe dove suo padre insegnava. Nella piccola comunità libica di Edimburgo ci sono "lettori", ragazzi che sono lì per imparare e progredire e "spie" che ascoltano, guardano, controllano la corrispondenza senza preoccuparsi di nasconderlo, affinché tutti sappiano che qualcuno può riferire al governo del loro paese gli eventuali comportamenti antisistema dei libici espatriati.
Mustafa convince Khaled a partecipare a una manifestazione contro il regime sotto l'ambasciata libica a Londra. Ma dalle finestre dell'ambasciata qualcuno spara sulla folla e Khaled e Mustafa vengono feriti in modo grave. Da questo momento la loro vita cambia e sarà un susseguirsi di bugie, di disorientamento, di elaborazione del trauma, di ansia. Denunciati come traditori non possono tornare a studiare a Edimburgo. Vivono vite indipendenti ma sono legati tacitamente dall'essere due sopravvissuti: la sparatoria non viene mai menzionata ma è sempre tra loro – "Ci univa l'affetto reciproco e la complessa intimità di due che hanno condiviso un destino terribile" – li rafforza e li separa, mentre le loro esistenze divergono: Mustafa tornerà in Libia, come anche Hosam, per entrare nelle forze rivoluzionarie contro Gheddafi. Khaled resta a Londra, tormentato dai dubbi.
Amici di una vita è un romanzo sull'amicizia, sulla vita da espatriati, sui rapporti con la terra d'origine, sulla politica che ha il potere di imprimere direzioni alle vite degli uomini e si intreccia con l'esplorazione dei sentimenti e degli effetti che un evento tragico può avere sull'esistenza quotidiana. È un grande romanzo sull'ambiguità: sull'amicizia quando è insidiata dalla gelosia, sulla vicinanza e l'affetto quando sono messi in crisi dal sospetto, sulle scelte di vita quando una decisione può incrinare la solidarietà. Ed è un esercizio letterario che regala pagine commoventi, pieno di riferimenti agli autori che hanno contato per Matar – Virginia Woolf, TS Eliot, Ford Madox Ford, Jean Rhys, Henry James, Robert Browning, Sylvia Plath e Conrad, di cui i tre amici parlano a lungo, uno straniero in Inghilterra, come loro – ma anche audace nella sua resa formale: il romanzo inizia dalla sua conclusione, in una sorta di narrazione a spirale, tornando ai momenti cruciali e sovrapponendo presente e passato. I capitoli brevi facilitano la lettura e il ritmo rallenta quando le esperienze che si raccontano sono intense e accelera per dar conto dei fatti che accadono e delle storie del passato. Tutti e tre gli amici amano i libri e mi è tornato in mente il romanzo del senegalese Mohamed Mbougar Sarr La più recondita memoria degli uomini (2022).
Parlandone qui, dicevo che nessun autore alla moda parlerebbe oggi di letteratura con l'ingenua passione con cui ne parla Sarr e – posso ora aggiungere – con cui ne parla anche Matar: nel suo romanzo fa dire a Khaled di essere meravigliato nel vedere quanti autori e autrici che lui e i suoi amici avevano letto e ammirato avessero a un certo punto delle loro vite vissuto così vicino a loro. Hosam amava segnare sulla mappa di Londra, con una X nera e poi con le iniziali in rosso degli scrittori, le strade dove avevano vissuto "VW, FMF, JC, EP, TSE, RLS e così via (...). Dobbiamo vederle tutte, – disse. VW era ovviamente Virginia Woolf". Perché coloro che sono persi in mare devono alzare gli occhi alle stelle. "Sostammo davanti all'edificio bianco a Hyde Park Gate. Era la casa dove Woolf era nata e aveva vissuto i primi vent'anni della sua vita. Indugiammo sui gradini, come se fossimo attesi, poi percorremmo le poche decine di metri fino a Hyde Park e cercammo di indovinare da quale ingresso sarebbe entrata".