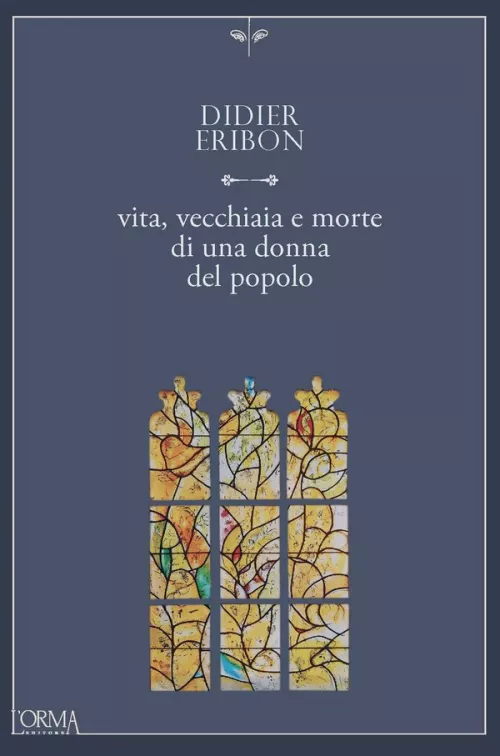Didier Eribon: chi parla per gli anziani?
Ricordo un solo figlio, in letteratura, Romain Gary, innamorato della madre senza che Freud lo tormentasse troppo e che riesce perciò a restituirne un ritratto in La promessa dell'alba (1960) con sense of humour e luminosità: racconta che il suo più grande sforzo nella vita era riuscire a disperarsi, ma niente da fare, restava in lui sempre qualcosa che continuava a sorridere, grazie a quella madre eccentrica e un po' folle che si era ritrovato e che gli aveva insegnato a prendere la vita con filosofia. Molti altri scrittori intrattengono con le madri relazioni contorte, in perpetuo scontro tra il loro io desideroso di emancipazione e le malvagità di una Medea, strega e assassina o le vischiosità ricattatorie di una Madonna, santa, martire e angelo del focolare. Madri che si prostituiscono per mandare i soldi agli affidatari della figlia senza padre, madri che puzzano, madri che finalmente muoiono per far scoprire al figlio cosa significa sentirsi libero, madri idealizzate: gli scrittori maschi, dal romanzo ottocentesco fino a quello contemporaneo, non ce la fanno a uscire dagli stereotipi, condannati a ripetere i cliché partoriti da un'immaginazione morbosa e moralista, spalleggiati da una società che fa fatica a evolvere e rinchiude ancora la figura femminile in convenzioni, tra l'eroismo del sacrificarsi nelle avversità e la catarsi dei sentimenti, con i femminicidi a cristallizzare i destini esemplari delle donne, cui il patriarcato, di cui si annunciano con ottimismo gli ultimi colpi di coda, chiede ancora di immolarsi.
Ci vorrebbero scrittrici donne a raccontare le altre madri. Gli uomini, soprattutto se omosessuali, non fanno avanzare d'un passo la figura della madre contemporanea, che resta prigioniera di ossessioni di cui lei non sa nulla, ma che i figli si premurano di imputarle come colpe, rinfacciandogliele puntigliosamente nei loro romanzi. Il percorso da compiere è tuttavia ancora lungo se dobbiamo trarre conclusioni dall'occhio che cade su quello che una donna, Donatella Di Pietrantonio, fresca di premio Strega e vincitrice di un Campiello, scrive. Dice la Di Pietrantonio: "la madre è un luogo", una terra cui si appartiene, radici che ci tengono in vita e che è impossibile recidere: così in L'Arminuta (2017). La lingua si aggiorna conformandosi alla modernità delle frasi fatte che vanno di moda: nel volenteroso intento di esaltarla la madre viene retrocessa da persona a "luogo" dove, probabilmente, "abitare", visto che "si abita" ormai qualunque cosa. La madre proletaria di Didier Eribon è la protagonista di questo suo memoir, una sorta di romanzo-saggio, intitolato Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo, traduzione di Annalisa Romani (L'Orma, 2024).
Come la madre contadina di Inès Cagnati (1937-2007) che giganteggia nei suoi due romanzi Génie la Matta e Giorno di vacanza, senza comparire quasi mai, anche quella operaia di Eribon, pur latitando, riempie il libro della sua presenza. Dietro c'è Questa non è un'autobiografia (2005) del sociologo Pierre Bourdieu, maestro di Eribon: è da lì che parte Eribon, dal concetto di vita vissuta che si fa autoanalisi e, se Bourdieu aborrisce il genere "autobiografia" giudicandolo falso, Eribon accoglie la lezione trasformando il memoir, che potrebbe sembrare un ritratto-omaggio alla madre morta, in una denuncia della società che emargina le persone anziane.

In un'intervista ha detto: "Ho voluto politicizzare il tema della vecchiaia, delle case di riposo, del sistema sanitario, nell'impossibilità delle persone anziane di prendere la parola, di costituirsi in movimento sociale, di protestare. Ho voluto farmi portavoce delle loro sofferenze e delle ingiustizie che subiscono, come aveva fatto nel 1970 Simone de Beauvoir con quel libro poco letto che è La terza età. Per riflettere su cosa significa invecchiare per le classi operaie, per le donne della classe operaia".
Eribon non si abbandona a una denigrazione della madre – risparmiandoci l'imbarazzo che si prova leggendo le sgradevoli riflessioni di scrittori che si accorgono a cinquant'anni di essere stati rovinati dalla genitrice, che avrebbero dovuto uccidere simbolicamente a diciotto, per non parlarne mai più – accennando appena al fatto che non la sopportava per via del suo razzismo, rilevando con delicatezza la distanza tra lui, un intellettuale, e una persona come lei, non istruita; del fatto che sua madre, giovane operaia combattiva nel sindacato, votasse ora i partiti di destra. Odiava suo padre ma amava sua madre e questo libro che parla di lei negli ultimi mesi della sua vita, quando i figli sono costretti a ricoverarla in una Rsa dove si lascerà morire, sfugge a due micidiali trabocchetti: la confessione del figlio gay in cerca di redenzione tardiva e la mitizzazione della figura materna, alla Roland Barthes.
Eribon non si crede Proust, il vero atto d'amore verso sua madre è immaginarla quando litigava con le infermiere, quando rifiutava il cibo scadente dell'ospizio, quando racconta di aver provato per un certo periodo, dopo che era morta, l'impulso di chiamarla per chiederle "una cosa qualsiasi". Verso la fine il memoir diventa un saggio. "Dopo aver salutato mia madre, all'indomani del suo ricovero nella casa di riposo, mi sono detto che avrei dovuto rileggere due libri che conoscevo bene e che intuivo potessero aiutarmi a capire quel che stava accadendo: La terza età di Simone de Beauvoir e La solitudine del morente di Norbert Elias. Successe tutto talmente in fretta che li ho riletti solo dopo la sua morte". Così il libro si chiude con un appassionato resoconto sulla terza età, condizione che sfugge al registro concettuale, come se né la politica né la filosofia non potessero o non volessero vedere né la vecchiaia né le persone anziane, non solo segregate socialmente in universi concentrazionari come gli ospizi, ma anche occultate concettualmente.
La linea di demarcazione della sociologia e della filosofia non sembra passare più "tra Ragione e Sragione ma tra Giovinezza e Vecchiaia, tra Buona Salute e Incapacità fisica, tra Corpo valido e Corpo dipendente. E questa esclusione della vecchiaia dall'ordine del discorso e della teoria potrebbe essere descritta (...) come uno degli aspetti di una configurazione culturale generale, che è l'altro versante della relegazione culturale degli anziani". In Ritorno a Reims (2009) Didier Eribon aveva intrecciato, come fa qui, l'autobiografia con l'indagine sociologica e il suo percorso individuale si agganciava all'analisi delle circostanze che plasmano il destino sociale delle persone. Lì era il rapporto col padre: "Con una stretta al cuore ho ripensato a lui, rimpiangendo di non averlo rivisto. Di non aver cercato di capirlo. Di non aver tentato, in passato, di parlargli. Di avere lasciato che la violenza del mondo sociale prevalesse su di me, come aveva prevalso su di lui". In Vita vecchiaia e morte di una donna del popolo il discorso si allarga alla "politica fondamentale": chi parla per conto degli anziani? Chi può prendere la parola in questa società escludente? Chi si farà carico di dare una voce alle persone, così tante, "tra le più dominate, le più deprivate, le più vulnerabili?".
L'uomo che si fa portavoce dei vecchi e dei poveri riscatta il narcisismo dello scrittore, i suoi sensi di colpa nei confronti della madre rimpiccioliscono di fronte alla mancanza di parola degli umili e degli sfruttati, e un libro che avrebbe potuto essere l'ennesima autoconfessione di un omosessuale sulla dipendenza materna diventa la domanda rivolta a chi legge su chi si preoccupa di ciò che sono, di ciò che vivono, di ciò che pensano e vogliono coloro a cui la vecchiaia impedisce di farlo. La scrittura e l'autocoscienza diventano un mezzo e un invito ad agire, in questo libro che è il passaggio di testimone da Didier Eribon a noi lettori.