I 50 anni di The Dark Side of the Moon
Fa sempre un certo effetto ripeterlo: settecento e più settimane consecutive nella classifica dei duecento dischi più venduti di Billboard. Dal 1973 al 1988, quindici anni, suppergiù. Un primato che ha dell’incredibile, sottolineato non solo in virtù della sua esorbitanza, ma anche perché rappresenta uno degli ossimori più vistosi del pop, genere che di regola viene confezionato con una data di scadenza un passo oltre l’immediato. Mi sono chiesto cosa potesse essere successo nel 1988 perché il disco uscisse infine dalle classifiche di vendita.
Molte cose, a ben vedere, ma siccome di mezzo ci sono i Pink Floyd e un disco che aveva l’ambizione di raccontare l’alienazione, la follia e la paura della morte, è suggestivo notare, anche soltanto in chiave aneddotica, che quell’anno sui banchi delle farmacie americane apparve un antidepressivo come il Prozac, la pillola della felicità, e che, per somma di circostanze, le classifiche di vendita dei dischi furono scalate, a livello planetario, da un motivetto ch’era impossibile non fischiettare, a immagine dei sette nani, andando al lavoro, Don’t worry be happy di Bobby McFerrin.
Cominciamo allora col dire che se c’è una cosa che The Dark Side of the Moon non fa è rifuggire dalle preoccupazioni. Anzi, se c’è un disco sulle preoccupazioni, quello è proprio The Dark Side of the Moon. Del disco è stato scritto molto, forse tutto, sicuramente troppo, ma tirarsi indietro, come si suol dire, non è facile. La tentazione di andare a sondare, lo spazio di due facciate di un Long Playing, la faccia oscura della luna, è irrestibile anche a cinquant’anni dalla pubblicazione (1° marzo 1973, per l’edizione americana). Quel che sappiamo per certo è che i Pink Floyd sono stati a lungo considerati, a torto o a ragione, fantascientifici.
Quale commento sonoro all’allunaggio della missione Apollo 11 del 20 luglio del 1969 la BBC scelse proprio la musica dei Pink Floyd. Sappiamo anche che fra loro e il regista Stanley Kubrick vi furono dei contatti, c’è chi dice già per 2001: Odissea nello spazio, di certo per Arancia meccanica, ma non se ne fece nulla in entrambi i casi. Sappiamo pure che Michelangelo Antonioni infilò la loro musica in Zabriskie Point. Quando il regista girò la famosa scena finale, la scena dell’esplosione, quella in cui tutto saltava per aria, e pareva che a saltare per aria fosse il sogno americano nella sua totalità, lasciò che fossero i Pink Floyd a punteggiare la deflagrazione.
Già nei primi anni, epoca Syd Barrett, le loro performance dal vivo si presentavano come degli happening visivi e sonori. Dei viaggi oltre le porte della percezione, avrebbe detto Aldous Huxley qualche anno prima (o anche Jim Morrison, loro illustre contemporaneo), esperienze sovente coadiuvate e assistite dall’acido lisergico: una band di rock predisposta per l’accelerazione insterstellare, proprio come recitava uno dei primi titoli del gruppo. Dopo averlo giocosamente evocato e per molti versi invocato, i Pink Floyd pagarono a caro prezzo la prossimità con lo squilibrio percettivo, lasciando sul campo il loro gioiello, Syd Barrett, il diamante grezzo, il fulcro creativo della band, allontanato dagli altri membri dopo che i suoi problemi di salute mentale lo avevano trasformato in una sfinge, sorta di genio ammutolito oltre che immolato, come ci è stato ripetuto all’infinito, sull’altare della psichedelia.

Le prime canzoni dei Pink Floyd, nelle parole dello scrittore Michele Mari, erano fatte di “idee splendidamente infantili” (Rosso Floyd, ed. Einaudi, 2010). Syd Barrett era un pifferaio sorpreso alle porte dell’alba (The piper at the gates of dawn è il titolo dell’esordio discografico del 1967), e accanto alle accelerazioni interstellari poteva infilare come se niente fosse una lode alla bicicletta. Sempre Mari: “Syd ci ha insegnato il valore della semplicità perché della semplicità aveva il coraggio, tutte quelle nenie demenziali, quelle rime puerili, prendete una canzone come Bike, c’è tutto Syd lì, la gioia di un bambino per la sua prima bicicletta, l’entusiasmo per il cestino agganciato al manubrio, il disagio very british di non poterla dare alla bambina che gli piace tanto perché quella bambina sarebbe perfetta per lui, ma…”.
Il dopo Barrett è un’altra storia. È come se, progressivamente, dopo le nenie demenziali e l’evocazione del fantomatico altrove percettivo, il gruppo si fosse ritrovato di fronte lo spettro del disagio mentale vero. La storia dei Pink Floyd, in estrema sintesi, sta tutta qui. Il resto – la proverbiale maniacalità in studio d’incisione, il perfezionismo esasperato, la megalomania, l’iperbole dei concerti e delle tournée (ve lo ricordate quel maiale gigantesco che incombeva sugli spettatori durante gli spettacoli o il muro costruito e poi demolito a fine concerto?), o ancora il live a Pompei, forse uno degli happening più iconici del rock, a fianco, che so, del festival di Woodstock o del concerto sul tetto dei Beatles: David Gilmour a torso nudo con la Stratocaster a tracolla e Roger Waters di nero vestito che riversano ondate di liquido psichedelico in un luogo pregno di silenzio e di mistero, qualcosa di assolutamente magico.
Per non parlare dell’eterno battibecco da cortile fra Roger Waters e David Gilmour, sfociato di recente in accuse pesantissime del clan Gilmour nei confronti dell’antico sodale. La follia insomma, incessantemente evocata nelle canzoni del gruppo (Shine on you crazy diamond; Brain damage; If; Wish you were here; The trial e via elencando, fino al titolo di un intero disco, A momentary lapse of reason), da un certo punto in poi s’è configurata come l’ago dell’instabile equilibrio della band (un paradosso fra i tanti) e, insieme, una geniale trovata in termini di posizionamento del prodotto sul mercato.
Come si sia arrivati a tanto – l’esorcizzazione della follia come leitmotiv e come fonte di calore per i fan di mezzo mondo – è materia complessa. La storia dei Pink Floyd continua a essere oggetto di studi e di ipotesi che contribuiscono ad alimentarne il fascino e l’irresolubilità. Una cosa però è certa, ed è che dai corteggiamenti espliciti, sfociati appunto nell’autentico disagio mentale di Syd Barrett e conseguente allontanamento dalla band, la follia, pur se incessantemente evocata, ha assunto, negli anni, un aspetto vieppiù rassicurante e in fondo innocuo. Dalla dimensione clinica i Pink Floyd sono transitati a fatica verso un che di estetizzante (la maniacalità e il perfezionismo di cui sopra), controllando tutto quanto poteva essere controllato, fatto salvo l’incontrollabile (i rapporti fra Waters e Gilmour), addomesticando di fatto il disordine vero, così da poterlo contemplare a distanza di sicurezza. Una sana inquietudine esistenziale in luogo della schizofrenia clinica.

Nelle scorse settimane i Pink Floyd hanno dato alle stampe ben diciotto dischi che documentano alcuni dei concerti che la band tenne in giro per il mondo nel 1972. Si tratta di registrazioni di fortuna, qualità pessima, delle tracce a tratti inascoltabili, un’operazione non commerciale volta a tutelare i diritti su questo materiale. Il copyright europeo prevede infatti che se un dato materiale sonoro non viene utilizzato nei primi cinquant’anni dalla realizzazione, i diritti su quel materiale vanno perduti. Lo stesso era già successo nel 2021, con la pubblicazione di dodici dischi live registrati dalla band fra il 1970 e il 1972. Questa nuova ondata di pubblicazioni ci offre anzitutto uno sguardo diretto sul percorso attraverso il quale i Pink Floyd arrivarono in studio per incidere il disco The Dark Side of the Moon. Com’era consuetudine della band, durante i concerti capitava che presentassero in anteprima i brani che sarebbero apparsi sul disco successivo.
Una prassi non molto amata dai discografici ma che la band ha sempre rivendicato. È dunque con una certa emozione che – qualità sonora a parte – si ascoltano le tracce non ancora perfezionate che sarebbero poi confluite, di lì a poco, su The Dark Side of the Moon quando nessuno, fra il pubblico presente ai concerti, aveva mai sentito Us and them oppure Breathe. Già soltanto questo, per il fan, è motivo di commozione e di struggimento. I pezzi ci sono tutti, i suoni pure, mancano ancora le transizioni, le voci off, gli effetti sonori, i dettagli, tutto il lavoro di affinamento svolto in studio dall’ingegnere del suono Alan Parsons.
The dark side of the moon per molti versi segna un punto di svolta, il definitivo passaggio della band verso la contemplazione della follia da un osservatorio meno incandescente. Qualcosa forse di più rassicurante sul piano clinico, ma che si rivelerà poi problematico sul piano delle dinamiche interne al gruppo. Per molti questo è il loro disco migliore; per altri è semplicemente, e in assoluto, il disco perfetto. Già, dirà qualcuno, e come la mettiamo con Wish you were here, come la mettiamo con The Wall? A ognuno, va da sé, il suo disco preferito, inutile alimentare ulteriori tensioni. Il fatto però è che quelle settecento e più settimane consecutive nella classifica di vendita di Billboard qualcosa dovranno pur significare, no? Com’è possibile che sia successo per The Dark Side of the Moon e non, poniamo, per Sgt. Pepper’s dei Beatles o per Rubber Soul?
Non per i Rolling Stones o per Michael Jackson. Nessun disco, nella storia del pop e del rock, ha mai raggiunto un simile traguardo di longevità nella hit parade. Ad oggi The Dark Side of the Moon ha trascorso, in totale, novecentoventisette settimane nella classifiche di Billboard (è uscito e rientrato in classifica diverse volte dopo la sua prima fuoriuscita nel 1988). Il secondo classificato – Doo-Wops & Hooligans di Bruno Mars – non arriva a cinquecento, praticamente la metà. Nevermind dei Nirvana è fermo a trecentoquarantotto. Led Zeppelin IV dei Led Zeppelin a duecentottantanove. The Dark Side of the Moon è dunque, da questo punto di vista, un’anomalia. Le ragioni di questo successo lungo mezzo secolo sono probabilmente molte.

La qualità delle canzoni, certo. L’innovazione tecnologica che ne fa un disco del futuro ancora oggi, cinquant’anni dopo la pubblicazione. L’evocazione della follia, pure, perché no, e fors’anche la correzione di prospettiva sul disagio mentale di cui si diceva: la follia trasformata in bene di consumo, il brivido di sperimentare per un attimo, sul divano di casa, senza pillole, senza spendimento alcuno, un black out della ragione. Mettiamoci pure il richiamo del titolo, e persino la copertina, di per sé una griffe, un colpo di genio. Mettiamoci pure il fatto che quello era un disco da avere perché ce l’avevano tutti, come il frigorifero o, più tardi, l’i-Phone. Tutto vero. Ma davvero basta? Possibile che dietro questo disco non vi siano ragioni più profonde che ne spieghino l’ostinato successo?
Nel rivedere il documentario Making The Dark Side of The Moon realizzato venti anni fa da Simon Hilton per conto dei Pink Floyd, a trent’anni dalla pubblicazione del disco, una cosa mi ha particolarmente colpito. Non tanto la ricostruzione del processo creativo o le innovazioni tecnologiche che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, tutte cose di per sé rilevanti e illuminanti per l’appassionato così come per il professionista, quanto il fatto che tutti e quattro i membri del gruppo, Roger Waters, David Gimour, Richard Wright e Nick Mason, tennero a sottolineare una cosa, la stessa, e cioè che quel disco, pubblicato il 1° marzo del 1973, fu realizzato quando tutti loro stavano diventando adulti. Stavamo cambiando, dice David Gilmour nel documentario. Roger Waters (altra inquadratura, Gilmour non presente) dice: mi accorsi che questa era la vita, non una prova.
In quei mesi, e la recente pubblicazione dei dischi live ne è fedele testimonianza, i Pink Floyd stavano dentro un vortice di concerti, registrazioni, interviste, film, viaggi intercontinentali e quant’altro. La macchina dello show business a pieno regime. A tenerli in equilibrio, allora, era il sentimento d’amicizia che li legava. Erano in fondo quattro ragazzi inglesi che avevano coronato un sogno. Dal punto di vista delle relazioni personali, quei mesi, il periodo che va da Meddle a The Dark Side of the Moon fu, a detta dei diretti interessati, il più felice della loro storia, quello in cui si sentivano più uniti. Stavano però entrando nell’età adulta sotto un’enorme pressione esterna. La stagione delle nenie infantili e dei giochi di luce all’UFO di Londra erano un ricordo.
La gioventù non era soltanto andata perduta, ma era andata perduta nella follia di Syd Barrett. Roger Waters, autore dei testi del gruppo, cominciò a mettere a fuoco lo stato d’inquietudine che era comune ai quattro. Ecco dunque emergere lo stress dell’essere una rockstar e la paura dell’invecchiamento (Time), quella della morte (The great gig in the sky); leggenda vuole che prima di entrare in cabina a registrare la parte vocale, qualcuno dei quattro avesse detto alla cantante Clare Torry: entra in cabina e pensa alla morte. C’è chi sostiene che le cose andarono diversamente, ma a me piace immaginare che sia andata proprio così (non ho paura di morire, sentiamo dire poco prima della parte vocale a Gerry O’Driscoll, addetto alle pulizie negli studi di Abbey Road, ogni momento è buono, non mi importa. Perché dovrei aver paura della morte? Non ve n’è motivo. Prima o poi tocca andare).
Clare Torry entrò in cabina e dopo un paio di tentativi se ne uscì con qualcosa che era a metà fra un orgasmo celestiale e un abbraccio vocale che riassumeva il lancinante bisogno di risposte che questo disco chiedeva a nome nostro, a nome di tutti, ben sapendo che quelle domande erano destinate a restare senza risposta), l’avidità che fa girare il mondo (Money; da notare, proprio come in Zabriskie Point, le esplosioni e le fiamme del videoclip: bruciamo tutto o, anche, mandiamo tutto all’aria), e beninteso lo spettro della follia (Brain damage; Eclipse) che fa da sfondo all’intero lavoro.
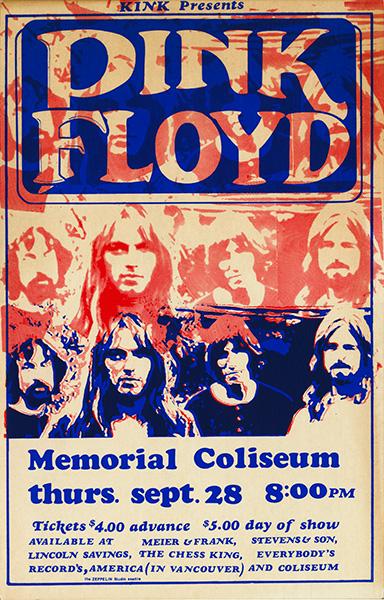
Proviamo dunque a ipotizzare questo, anche soltanto per gioco e con quel filo di ingenuità che i Pink Floyd sempre reclamano: che The Dark Side of the Moon sia non solo il disco della maturità dei Pink Floyd, ma il disco che traghettò il rock e il suo popolo nell’età adulta, con tutta la serietà (ma anche con l’energia, lo sdegno e la potenza della gioventù) che questo passaggio comporta. Di concept album il rock ne aveva già prodotti, pensiamo soltanto a Tommy degli Who, ovviamente al Sgt. Pepper beatlesiano, Pet Sounds dei Beach Boys, o all’irrisione del sogno americano grazie a un’accolita di fricchettoni californiani in Freak Out! di Frank Zappa. Tutti questi dischi, proprio come The Dark Side of the Moon, avevano l’ambizione di allontanarsi dalla dimensione giovanilistico-adolescenziale tipica del rock. The Dark Side of the Moon partiva da una prospettiva che presupponeva uno sguardo adulto, o quanto meno una presa di distanza dalla dimensione meramente ludica del pop. Ad alcuni questo potrà forse sembrare un tradimento, un prendersi sul serio da cui il rock s’era quasi sempre tenuto alla larga, ma la fuga dalla dimensione giocosa dei primi Pink Floyd (quello che Gilmour avrebbe poi severamente definito ciarpame psichedelico) era il primo passo verso la maturità. Una maturità individuale ma anche collettiva: trovare un sound e un perché oltre Barrett, qualcosa di alternativo al binario su cui l’antico leader aveva instradato il gruppo. Echoes, dal disco Meddle, ne era stato il primo felice appostamento. The Dark Side of the Moon ne indicava invece la piena fioritura.
The Dark Side of the Moon è in fondo un disco che racconta l’alienazione del diventare adulti, la follia ultima, il dover infine affrontare la vita senza più i giochi di luce sforzandosi però nel contempo, grazie alla tecnologia e al perfezionismo esasperato, di piegare la realtà, di contenerla per non farsene travolgere. È un disco che registra la transizione da uno stato di magia e di incanto a qualcosa di drammaticamente reale, qualcosa che ha, potenzialmente, facoltà di annientarci. Questo senso di angoscia i Pink Floyd riuscirono a restituirlo in modo mirabile, addolcendolo però grazie a una musica ispirata come poche, trasferendo quell’angoscia in una sorta di quadro entro cui, accanto alle canzoni, forse le più compiute che avessero mai realizzato fino ad allora, si mescolano delle voci, delle frasi che paiono giungere da un’altra dimensione, riflessioni d’ogni genere, suoni stranianti che piovono negli altoparlanti da un luogo che ci è precluso. È insomma un’esplorazione a tutto campo della mente umana, un viaggio che ha l’ambizione di traghettarci in un’altra dimensione. Ma è anche un disco insieme elusivo e di tutti, pop e sperimentale, da tenere in sottofondo o da ruminarci su per giorni, qualcosa che in molti avevano tentato di fare prima di allora e altrettanti si provarono a fare dopo, senza mai riuscirci. Il suo colossale e ostinato successo è sicuramente il segno che quel prisma ha colpito un bersaglio che sta dentro ognuno di noi, non è stato un successo casuale o dettato da un colpo di fortuna: il prisma che si affaccia in copertina è il prisma delle nostre ansie e delle nostre paure, il dilemma di fronte al mistero che stiamo attraversando, qualcosa che ha facoltà di interrogarci tutti in modo indistinto, generazione dopo generazione.









