I documenti di Alejandro Zambra
“A volte la vita”, afferma Julio Ramón Ribeyro (1929-1994), “si compiace di offrirci compendi allegorici della realtà o, meglio, citazioni magnificamente scelte dal grande testo della storia che viviamo” (Scritti apolidi, La Nuova Frontiera, trad. a cura di Gina Maneri, p. 25). Qualche riga prima, in un altro dei frammenti contenuti in questo zibaldone che, per la sua unitarietà, pare un diario, scrive: “Dato che siamo imperfetti, la nostra memoria è imperfetta e ci restituisce soltanto quello che non può distruggerci” (p. 24).
In altre parole, di nuovo le sue, ma stavolta parafrasate: del dolore e del piacere si può avere il ricordo, tuttavia, non siamo in grado di ricostruire la sensazione di quel ricordo. Altrimenti, vale la pena aggiungere, ce ne andremmo in giro fino alla fine dei nostri giorni scorticati da stati di coscienza permeabili a qualsiasi stimolo esterno o interno capace di riportarci ogni volta a un daccapo che ha tutte le caratteristiche della tortura.
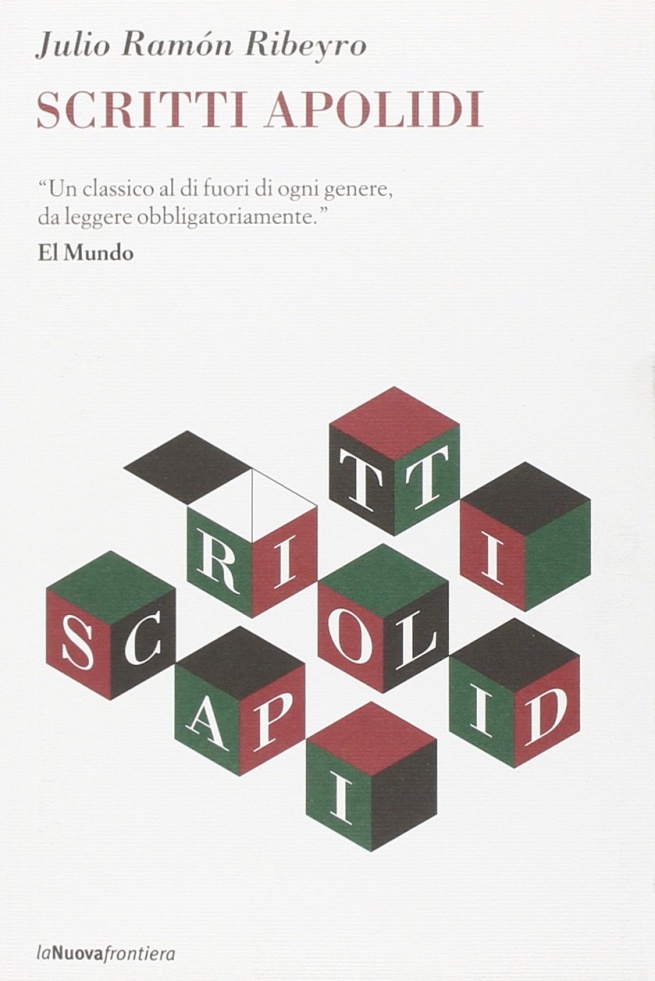 Scritti apolidi, Julio Ramon Ribeyro
Scritti apolidi, Julio Ramon Ribeyro
Con il pudore sentimentale che contraddistingue le pagine del libro I miei documenti (Sellerio, trad. di Maria Nicola), Alejandro Zambra, tra le voci più meritevoli di attenzione dell’attuale panorama letterario ispanoamericano, riprende il cammino tracciato dal maestro peruviano delle forme brevi facendo della sobrietà emotiva un riconoscibile tratto anche della sua scrittura. Non solo: sono undici racconti da cui scaturisce un marcato “effetto romanzesco”, lo stesso che qualche anno fa l’autore cileno coglieva in alcuni racconti di Ribeyro (il riferimento è a una delle note critiche ora contenute in No leer, non ancora tradotto in italiano), favorito, nel caso di Zambra, da un solido principio di organizzazione testuale che salda le vicende congiungendone le varie parti – personaggi, luoghi, oggetti – oltre i confini del singolo racconto.
 Alejandro Zambra
Alejandro Zambra
Si tratta della scelta di scomporre la voce principale in due punti di vista: uno appartiene a un io narrante che durante la scrittura riflette sulle debolezze della sua presa di posizione sulla realtà: “rileggo, cambio delle frasi, preciso dei nomi. Cerco di ricordare meglio: di più e meglio. Taglio e incollo, ingrandisco il carattere, cambio il font, l’interlinea. Vorrei chiudere questo file e lasciarlo per sempre nella cartella Documenti” (p. 31). L’altro, l’io narrato, è un quarantenne cileno cui l’autore affida la narrazione in prima persona di un’infanzia e di una giovinezza manipolate fino alla smaterializzazione dell’elemento autobiografico e alla sua conseguente condensazione nella dimensione finzionale: “Mio padre era un computer, mia madre una macchina da scrivere. Io ero un quaderno vuoto e adesso sono un libro” (ibid.).
Le due voci si confondono e si sovrappongono spesso, ma senza mai disturbare la lettura. Anzi, il lettore approfitta di queste interferenze, come dei salti cronologici, per entrare nell’immaginario e nell’affettività di chi, mi riferisco ai protagonisti dei bellissimi “I miei documenti”, “Camilo”, “Assistenza per viaggiatori” e “Instituto Nacional”, ha dato un ritmo alla propria crescita seguendo il sillabare imposto dalla dittatura prima e dal pinochetismo poi. Ecco un elenco, non esaustivo di tutte le varianti presenti nel libro del medesimo personaggio: i primi palpeggiamenti, tra chierichetti, consumati sulle note di ciò che è rimasto dell’ebbrezza rivoluzionaria, vale a dire un pugno di successi della Nueva canción latinoamericana; la lista dei presidenti del Cile studiata a memoria a scuola, dove è normale omettere il nome di Salvador Allende; un’importante amicizia con un ragazzo più grande sullo sfondo del plebiscito per il nuovo mandato di Pinochet; il migliore lavoro dei vent’anni ottenuto in un ufficio per telefonisti ai tempi dell’arresto del dittatore, nel 1998...
E così via, fino agli anni duemila, con la lunga transizione democratica. I suoi sviluppi assomigliano alle inutili vie percorse dal protagonista di “Io fumavo benissimo” per cercare di abbandonare le sigarette. Il testo è anche un esplicito omaggio ad alcuni maestri che lo accompagnano nell’impresa di “[smettere] di provare a smettere di fumare” (p. 140). Oltre a Ribeyro, che senza le sigarette non riusciva a scrivere, la voce narrante evoca, tra i grandi delle lettere latinoamericane, Clarice Lispector e l’eccentrico copione della sua morte, i pericolosi calcoli di Nicanor Parra, da cui deduce di essersi fumato negli anni il denaro per l’acquisto di una casa, Juan Carlos Onetti di pessimo umore mentre scrive Il pozzo: “Macché esistenzialismo: mancanza di sigarette” (p. 139).
Questa via crucis del tabacco ha uno scopo, più improrogabile della disintossicazione: risolvere la questione dell’emicrania di cui soffre da sempre, conosciuta anche come suicide headache: “né ripassare la vita intera al ritmo della psicoanalisi [...] Né rinunciare al formaggio, al vino, alle mandorle, ai pistacchi. Né consumare una farmacia e mezza di farmaci aggressivi” (p. 126) riescono a placare il dolore che, quando arriva, spinge la vittima a sbattere la testa contro il muro per cercare di stare meglio.
Come è facile intuire, il sollievo manca sempre. Al suo posto, la presenza costante di uno sforzo encomiabile, quello di diventare contemporaneamente interprete e spettatore della propria esistenza, per offrire a chi sta dall’altra parte della pagina quei “compendi allegorici della realtà” che autori come Ribeyro hanno nobilitato e che Alejandro Zambra maneggia come pochi sanno fare.









