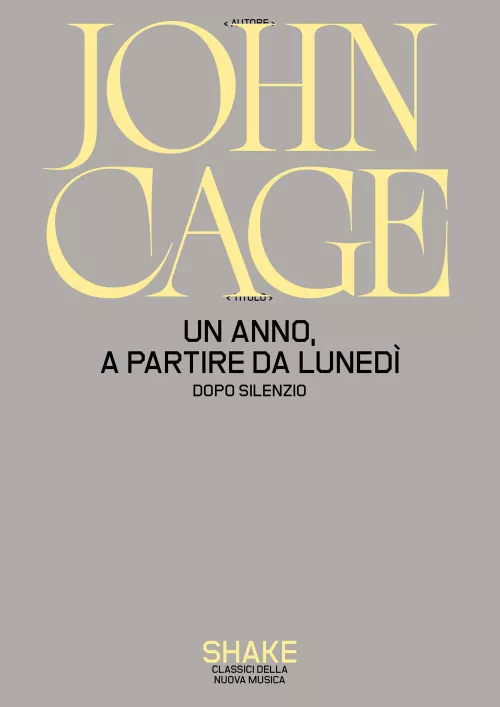John Cage dopo il silenzio
Mentre studiava con Schönberg, il giovane Cage si sentì dire: “Per comporre devi possedere il senso dell’armonia”. Ma l’allievo aveva già capito di non averlo proprio, quel senso. Allora il compositore viennese si fece perentorio: Cage avrebbe sempre incontrato qualche ostacolo, e sarebbe stato come andare a sbattere contro un muro impenetrabile. Il compositore-filosofo, comunque, non si perse d’animo; se ne fece una ragione e ribatté: “In questo caso dedicherò l’esistenza a sbattere la testa contro quel muro”. Un aneddoto, questo, riportato da John Cage nel suo volume forse più noto: “Silence”; pubblicato negli Stati Uniti nel 1961.
Negli anni successivi, però, il nostro fece ancora molte conferenze, scrisse articoli, annotò appunti, e redasse una sorta di diario; insomma, si dimostrò sempre meno interessato alla musica, come scrive lui stesso nella prefazione a un importante volume appena pubblicato da Shake Edizioni, nel 2023, e intitolato “Un anno, a partire da lunedì. Dopo il silenzio” (egregiamente tradotto da Giancarlo Carlotti e da Ermanno “Gomma” Guarnieri). La collana è quella dedicata ai classici della nuova musica; e il provvidenziale volume di cui ci andiamo ad occupare è ‘importante’ perché rende fruibile in italiano una importante mole di riflessioni che negli Stati Uniti era già stata pubblicata nel 1979.
D’altra parte, Cage lo dice esplicitamente, nella sintetica ma icastica prefazione al tomo in questione: “Il motivo per cui sono sempre meno interessato alla musica non è solo perché trovo più utili in senso estetico i rumori e i suoni ambientali rispetto ai suoni prodotti dalle culture musicali del mondo, ma perché, se andiamo al sodo, un compositore è semplicemente uno che dice agli altri che cosa fare. Trovo che sia un modo sgradevole di far fare le cose. A me piacerebbe che le nostre attività fossero più sociali e anarchiche” (p. VII).
Ed effettivamente è proprio “anarchia” la parola più giusta per definire l’orizzonte estetico disegnato dall’opera e dalla riflessione di John Cage. Un orizzonte che è lo stesso compositore a voler sin da subito ‘liberare’ da improprie ed ingiustificate assiologie, gerarchie o sistematizzazioni di sorta. Ai suoi occhi, infatti, quel che è ormai da tempo venuto a mancare è proprio il ruolo fondante del “principio unificatore” – indipendentemente dal quale nessun sistema avrebbe mai potuto venire ragionevolmente costruito. Né alcuna “misurazione”, né alcun “potere” sarebbero stati più realmente legittimabili.
Per questo, rileva lo stesso Cage, già nelle prime pagine del nostro Zibaldone, ormai bisogna “guardare in tutte le direzioni, non in una sola” (p. 7). D’altro canto, solo dove nessun principio ordinatore impone la postura a partire dalla quale muoversi (vuoi nel mondo delle note, vuoi nel mondo della figurazione, vuoi in quello della scrittura), sarà possibile muoversi liberamente in ogni direzione, e fare finalmente “quello che non è necessario, come ad esempio ‘spostare sabbia da una parte all’altra della spiaggia” (pp. 5-6). Il fatto è che ormai ogni scelta equivale ad ogni altra; tanto, ad accadere sarà sempre quel che forse non sarebbe mai dovuto accadere. Perciò, rileva Cage: “dicono che la musica totalmente determinata e la musica indeterminata suonano uguali” (p. 6). Se non v’è principio ordinatore, se non v’è arché che imponga una direzione al nostro procedere, allora quel che sembra determinato (da condizioni, da regole, da assiologie...) non lo è affatto; e apparirà da ultimo perfettamente in-determinato.
È noto che tale consapevolezza stava maturando da ormai più di qualche decennio; si pensi solo al famosissimo rebus magrittiano trasformato in “opera” con il titolo di Ceci n’est pas une pipe. Ma anche le rivoluzioni prima atonale e poi dodecafonica avviate da Schönberg (quella dodecafonica elaborata sulla scia di Joseph Matthias Hauer) già nei primi due decenni del Ventesimo secolo andavano in questa direzione. Per non parlare di un analogo terremoto concettuale operato nell’ambito delle arti visive da Marcel Duchamp; che già nel 1913, e poi ancora nel 1914, doveva sconcertare lo stanco mondo dell’arte prima con una ruota di bicicletta e poi con un semplicissimo scolabottiglie. Oggetti di uso comune sottratti alla prassi quotidiana, che li avrebbe voluti intenzionati a questo o quello scopo. Separati dal contesto sempre funzionale in cui è inscritta la vita degli umani, tali oggetti avrebbero reso finalmente evidente l’essenza più vera dell’opera d’arte; anche di quelle apparentemente prodotte da una competenza tecnica e da un’abilità manuale di cui sembrano capaci solo i ‘geni’.
L’arte si libera sì dal mito della “padronanza tecnica” o del virtuosismo stilistico, ma soprattutto si libera dal pregiudizio che l’aveva sempre voluta espressione di uno stile o di una qualche urgenza semantica. L’arte ritrova, dunque, e proprio negli anni destinati ad accogliere l’esplosione di non poche avanguardie estetiche (dal dadaismo al futurismo, dal cubismo all’astrattismo, dal suprematismo al neoplasticismo, dal surrealismo alla metafisica), la propria più profonda e originaria “innocenza”. La propria inestirpabile “gratuità”. Scoprendo di poter vivere solo se sostenuta dalla ‘sacra’ aleatorietà originariamente frequentata (come avrebbero mostrato molti antropologi proprio in quegli anni) dal “rito”.
Non è un caso che anche Cage, pur appartenendo a una generazione successiva (essendo egli nato nel 1912, proprio mentre le avanguardie artistiche mettevano a ferro e fuoco la tradizione, in ogni ambito della creatività), prema sull’acceleratore di questo sconquasso epistemologico e, in perfetta sintonia con le operazioni beuysiane e con quelle di Fluxus, cerchi di dare corpo alla lucida presa di coscienza del fatto che “non ci sono più le vecchie ragioni per fare le cose” (p. 8). E dunque neppure delle ragioni specificamente ‘estetiche’ per dare libero sfogo alla creatività.
Ormai non sembra più possibile la definizione di un ambito universalmente riconoscibile come “estetico”. Certo, Cage sa bene che “la gente chiede ancora definizioni, ma è ormai abbastanza chiaro che nulla può essere definito. Per non parlare dell’arte, del suo scopo ecc. Non siamo nemmeno sicuri delle carote (che siano quel che pensiamo siano, quanto sono velenose, chi le ha coltivate e in quali circostanze)” (p. 9).
Insomma, l’arte deve farsi vita; come avrebbe ribadito anche l’artista dal cappello di feltro (Beuys) – e non la vita, arte, come volevano invece i pur disinibiti protagonisti del cosiddetto decadentismo europeo. E che l’arte dovesse farsi vita non significava che si dovesse estetizzare l’esistenza, quando piuttosto che era forse giunto il momento di trasformare la creatività in forza vitale e propulsiva in grado di modificare realmente la realtà di tutti e di ognuno. A Cage sembra ormai chiarissimo che “oggi il nostro vero lavoro, se amiamo l’umanità e il mondo in cui viviamo, è la rivoluzione” (p. VII).

A lui interessa ormai soltanto questo: che “le nostre attività (le attività artistiche) siano più sociali e anarchiche” (p. VII). D’altro canto, come gli fece notare un amico, egli era già da sempre impegnato a migliorare il mondo; ma ora si trattava di fare un passo ulteriore, di passare davvero all’azione. Cioè, di praticare anche le discipline orientali (è noto, e appare chiaramente anche dalla lettura di queste pagine, che Cage è sempre stato seriamente interessato alle pratiche e alle teorie Zen) “socialmente, cioè non solo nella nostra testa ma fuori di essa, nel mondo, dove si trovava ormai anche il nostro sistema nervoso” (p. VII).
Il nostro compositore ne è fermamente convinto: ormai quello a venire non sarà più un mondo fondato sul lavoro; “presto, tutto quanto ci sarà richiesto sarà un’ora di lavoro all’anno” (p. 7). Per questo non si trattava neppure di impegnarsi a scrivere musica. In questo senso, egli sembrava aver preso alla lettera le parole di Schönberg, che un giorno gli aveva detto: “il mio scopo, quando vi insegno, è quello di rendervi impossibile scrivere musica” (p. 46). Anche se, per altro verso, forse, solo l’impossibile merita di esser davvero perseguito.
Sì, solo l’infattibile sembra poter essere fatto; anche perché, se l’uno è sempre molteplice, anche il diverso non potrà che continuare a negare la propria diversità. Ma allora, se l’uno è sempre diverso da sé, come stupirsi del fatto che, nel cercare una cosa, “se ne trovi un’altra” (p. 56)? E soprattutto del fatto che “una mente unica funzioni in maniere (tanto) diverse” (p. 56)?
A questo proposito Cage ne è certissimo: le menti funzionano in maniera sempre diversa. E proprio questo risulta “interessante”, ai suoi occhi. Non a caso egli avrebbe potuto ritenere quanto mai opportuno “considerare anche il successo di qualsiasi tipo un disastroso fallimento” (p. 130). Il fatto è che “nulla ha la giusta misura” (p. 130). Con buona pace di Aristotele che, proprio sulla “giusta misura” avrebbe cercato di fondare un ethos in qualche modo utile agli umani. Il fatto è che le consonanze, le corrispondenze e gli accordi si determinano sempre indipendentemente dai nostri progetti e dai nostri calcoli; e anche dalle nostre misurazioni. A mostrarcelo è la vita stessa, in ogni sua, anche apparentemente secondaria, manifestazione.
Interessante è poi, a questo proposito, anche un episodio che Cage racconta nel paragrafo intitolato: Come passare, scalciare, cadere e correre. “Una volta che in gruppo stavamo andando in macchina a Boston ci fermammo a un ristorante lungo la strada a pranzare. C’era un tavolo accanto a una finestra all’angolo da cui potevamo guardare fuori, verso uno stagno dove la gente nuotava e si tuffava. C’erano degli scivoli fatti apposta per buttarsi in acqua. Il ristorante aveva un juke-box. Qualcuno ci infilò dentro una monetina. Notai che la musica che ne usciva accompagnava i nuotatori, anche se loro non la sentivano” (p. 131).
Quel che conta è insomma imparare ad ascoltare il silenzio, che non è mai vuoto, come il nostro scriveva già nel precedente Silence. Si tratta piuttosto di riconoscere la musica che viene eseguita dalle cose e dalla natura, nonché dalle situazioni… anche indipendentemente dalla nostra volontà di accordare in certo modo i timbri, le altezze e i ritmi dell’esistere; cioè di comporre musica, in senso proprio.
Non a caso per lui “un modo di scrivere musica è studiare Duchamp” (p. 72).
Non a caso, all’artista francese sono dedicate, in questo volume, alcune bellissime pagine che consiglio di leggere con molta attenzione perché ci aiutano tanto a comprendere Cage quanto a gettare nuova luce sull’opera di Marcel Duchamp.
Per Cage è sufficiente prendere un qualsivoglia oggetto, e rovesciarlo: ed ecco che diventerà un Duchamp (Cfr. p. 72). In ciò la radice di quella indeterminazione in cui il nostro riconosce il cuore essenziale della propria grammatica musicale. Siamo verso la metà degli anni Sessanta, quando Cage scrive che “un compositore scrive in questo momento in maniera indeterminata. Gli esecutori non sono più suoi servi, ma uomini liberi. Un compositore scrive le parti, ma poiché non definisce le relazioni tra di esse, non scrive una partitura. Le fonti sonore si trovano in una molteplicità di punti nello spazio rispetto al pubblico in modo che ogni ascoltatore possa averne un’esperienza da sé” (p. 29).
E dunque se, in accordo con Coomaraswamy, egli ritiene che “la funzione dell’arte sia quella di imitare la Natura” (pp. 28-29), ciò non significa che lo si possa inscrivere in una prospettiva banalmente ‘realistica’. Come era stato precisato anche da Beuys (ma prima ancora da Leopardi), non si trattava cioè di imitare le forme di oggetti che peraltro non sono mai identici a sé stessi e mutano in continuazione. Della natura, cioè, si sarebbe piuttosto trattato di “imitare le modalità operative” (p. 29). Un po’ alla Goethe, potremmo forse dire.
D’altronde, della natura cambieremo sempre immagine a seconda degli sviluppi che vengono realizzati in campo scientifico. E soprattutto, sempre della natura, secondo il nostro compositore bisogna sì imparare ad ascoltare i suoni, ma anche a guardarli. Così come si tratta di ascoltare i colori (ne sapeva qualcosa già Kandinsky, affascinato appunto dal cosiddetto “suono giallo”).
Il fatto è che bisogna essere anarchici sino in fondo, ed imparare a superare qualsivoglia steccato disciplinare; anche la separazione di materia e spirito (cfr. p.110). Perché “siamo liberi come gli uccelli. Solo che gli uccelli non sono liberi” (p. 117). Certo, il nostro lo diceva già nel precedente Silence, che in questa nuova musica non accade nulla oltre ai suoni, quelli scritti e quelli non scritti (quelli non scritti compaiono nella partitura come silenzi, aprendo le porte della musica ai suoni dell’ambiente circostante). Per lui, infatti, non vi sono né spazio vuoto né tempo vuoto; per questo non riusciremo mai a creare il silenzio ‘puro’. Non si tratta cioè di accentuare la contrapposizione tra suono e silenzio, che è solo apparente. Ma di riconoscere piuttosto i suoni di cui è già ricco il silenzio: in primis quello custodito in ogni suono; lo stesso da cui quest’ultimo è destinato, forse, proprio all’indeterminazione. Ossia, al non esser mai quel che sembra essere.
Perciò, sempre secondo Cage, non si tratta di continuare a dire “sì” o “no”, contrapponendo l’affermazione alla negazione; o di giocare con le contrapposizioni e le divisioni; sempre eccessivamente rigide. Ma di aggiornare piuttosto lo stile di vita già proposto da Meister Eckart: sperimentando il nulla dell’esistente e nell’esistente quale vera e propria condizione di possibilità del compenetrarsi da parte di molti centri – “come le persone possono fare le cose senza che venga detto loro o detto dagli altri cosa fare” (p. 161).
Così come accade appunto in questo bellissimo e preziosissimo volume; in cui, un po’ come sarebbe accaduto a un altro capolavoro, Il giro del giorno in ottanta mondi di Julio Cortázar – anche lo scrittore argentino, infatti, viaggia intorno al mondo e alla sua storia senza muoversi dalla sua scrivania –, mette insieme, affastellandoli l’uno sull’altro, appunti, racconti, riflessioni, saggi, aforismi, come in una sorta di vero e proprio Zibaldone del Ventesimo secolo.
D’altronde, entrambi questi capolavori risalgono alla metà degli anni Sessanta; e sono due libri egualmente “pazzi,” da fuori di testa, per dirla con Cortázar. Due capolavori anche ‘poetici, se intendiamo per poesia, come suggerito da Cage, non tanto un’espressione linguistica ricca di significati molteplici, metaforici e non univocamente determinabili, quanto piuttosto l’irruzione nel linguaggio proposizionale del valore costruttivo e decisivo del suono, del ritmo e degli accenti. Di tutto ciò di cui è pregno il silenzio (per Cage, infatti, “non esiste silenzio che non sia pregno di suono” (p. 97)). Di quel “nulla che accade” proprio quando siamo immersi nel fragore del silenzio, e magari ci capita miracolosamente di “udire anche la musica che producono le spore sparate dai basidi” (p. 32); quella che, solo se non riconosciuta, ci costringe “a darci da fare con i microfoni” (p. 32).