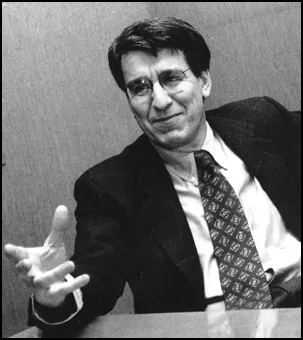Luigi Manconi. La musica è leggera
Negli ultimi anni in Italia i libri sulla canzone, e in generale su quella che gli anglosassoni chiamano popular music, si sono moltiplicati. Il loro taglio è assai vario ed eterogeneo: si va dalle monografie più o meno agiografiche alle interviste (auto)celebrative, dagli album fotografici alle antologie e ai dizionari, dagli studi sociologici, storici, linguistici, alle analisi più propriamente musicologiche (molto molto rare). A prevalere, comunque, è lo sguardo devoto del fan. Anche nei saggi di carattere più accademico, sembra di avvertire ad ogni riga lo sforzo che l’autore fa per dissimulare il proprio personale coinvolgimento in questo insidiosissimo oggetto d’indagine. Studiare Mogol-Battisti non è come studiare l’abate Zanella o la fotosintesi clorofilliana; nemmeno il cattedratico più rigoroso riesce a dimenticare di essere (stato) un ragazzo italiano, un figlio come tanti del Paese dei Cantautori: quando si occupa dell’opera di Vasco, il distacco scientifico è sempre sul punto di sciogliersi in un coro da gita scolastica. Su ogni pagina aleggia la scena del film di Nanni Moretti (Bianca, 1984) in cui, mollemente appoggiato a un vecchio juke-box in un’aula della “Scuola Marylin Monroe”, il prof. Apicella recita ai suoi alunni gli immortali senari di Gino Paoli.
Luigi Manconi, sociologo di formazione, storico dirigente di Lotta Continua, poi portavoce dei Verdi e senatore della Repubblica, sotto lo pseudonimo di Simone Dessì è stato negli Anni Settanta – con la collana “Il pane e le rose”, per l’editore Savelli – uno degli iniziatori della pubblicistica “impegnata” sull’argomento, nonché animatore della rivista Muzak. Nel suo libro (La musica è leggera. Racconto su mezzo secolo di canzoni. Milano, Il Saggiatore, 2012, pp. 506, 16 euro) il punto di vista del cittadino cantautorizzato domina incontrastato e senza schermi. Chi fosse alla ricerca di un’analisi “scientifica” di cinquant’anni di canzone italiana dovrà rivolgersi altrove; qui non si fa storia: si fa un racconto, appunto; un memoriale insomma, o – a dirla tutta – un’autobiografia su mezzo secolo di musica leggera.
Leggendo, ripensavo a una categoria psicologica che negli anni del cosiddetto riflusso (1976-1980) era in gran voga: quella di vissuto. Alle implacabili (e spesso noiosissime) analisi socio-politico-economiche, da un certo momento in avanti si era sostituita una libera e appassionata autoaffabulazione. La realtà delle cose andava ormai ricercata non nei piani criminali dell’imperialismo, ma nella turbata esperienza di Pino, di Sara, di Stefy, così come loro la ricostruivano in una riunione di autocoscienza tra compagni/e o sul divano del loro psicanalista. Ecco: della musica leggera Manconi ci propone in questo libro il suo personalissimo vissuto.
Che invidia. Chi di noi non vorrebbe avere l’opportunità di ripercorrere pubblicamente per 500 pagine la propria vita, canzone per canzone? L’autore di La musica è leggera lo fa con ammirevole coraggio, senza alcun timore di quella prima persona che da bambini ci hanno insegnato a coprire pudicamente, come la bocca che sbadiglia.
Così, la vicenda della canzone italiana degli ultimi cinquant’anni appare segnata da una serie di incontri (o di mancati incontri) con Manconi: “[In uno dei vicoli tra Campo de’ Fiori e Trastevere] mi imbattei – sarà stato il settembre o ottobre del ’73 – in Francesco De Gregori. Mi colpì immediatamente perché era alto e bello”; “Riconobbi subito in quell’uomo Lucio Dalla. C’eravamo incontrati a una cena qualche giorno prima…”; “Per anni, Alice fu una mia privatissima icona (…) La incontrai una sola volta, alla fine degli anni ’90…”; “L’unica volta che ho incontrato di persona Giovanni Lindo Ferretti è stato nel 1999 a Roma, a Palazzo Chigi…”; “A Milano non ebbi mai occasione di incontrare Eugenio Finardi; e d’altra parte, la sua musica non era quella a me più congeniale… Poi – ma eravamo già intorno alla metà degli anni ’80 o forse dopo – mi capitò di partecipare con lui a una puntata del Maurizio Costanzo Show…”.
L’egotismo che informa il racconto manconiano è talmente gagliardo e innocente da risultare alla fine simpatico, affascinante, contagioso. Sarei quasi tentato di imitarlo, e scrivere: “Ho incontrato Luigi Manconi nel 1978 a Milano, in riva al naviglio di Via Ascanio Sforza, sede de l’Orchestra, la prima cooperativa di musicisti in Italia, di cui ero socio fondatore insieme a Franco Fabbri, Moni Ovadia e altri. Allora suonavo negli Stormy Six; lui era venuto a trovarci per parlare di un libro in corso di pubblicazione da Savelli. Ricordo il suo accento sardo, che mi faceva sognare quello dei miei remoti antenati sassaresi… Molti anni più tardi, quando abitavo in zona Venezia, e da anni mi dedicavo prevalentemente alla poesia, mi arrivò – del tutto inaspettata – una sua telefonata, durante la quale si professava ammiratore del nostro vecchio gruppo…”.
Ma lasciamo riposare l’ego dei sessantenni e torniamo a toni recensori più tradizionali. Oltre alla freschezza di alcuni aneddoti e alla messa in opera di un punto di vista onestamente soggettivo, del tutto estraneo alle ipocrisie accademiche che caratterizzano gran parte degli studi italiani sull’argomento, La musica è leggera presenta altri pregi. Il primo, a mio modo di vedere, è l’applicazione alla canzone della categoria di sentimental-kitsch. Non è cosa da poco. Nemmeno gli studiosi più agguerriti e rigorosi hanno il coraggio di riconoscere tanto apertamente il peso che il sentimentalismo adolescenziale (loro e altrui) ha sul giudizio intorno al valore di questo o di quel pezzo, di questo o di quell’autore, e della canzone in generale. Grande e geniale, nel Paese dei Cantautori, è quello che io ascoltavo quand’ero giovane. Poesia è qualsiasi sdolcinata cantilena, qualsiasi metafora pretenziosa abbia solleticato la mia pubertà. Quando si trova di fronte alla sua canzone preferita, neanche l’esimio studioso di Petrarca riesce a percepire la goffaggine di quei versi, la loro tronfia mediocrità, la loro melensaggine. La nozione di kitsch sembra sia del tutto ignota ai nostri sociologi, ai nostri linguisti, ai nostri critici musicali. Leggendo molti studi sulla canzone, l’impressione è un po’ quella che si avrebbe sentendo discettare di una gondola di plastica (“Ricordo di Venezia”) come se fosse una scultura di Michelangelo.
In un apposito capitolo, Manconi definisce il sentimental-kitsch (di cui “la musica leggera è il mezzo di comunicazione più efficace”) come “un lato debole, infantile e sottoculturale, che si esprime nella passione – a volte negata, a volte compiaciuta – per oggetti, linguaggi e vicende che, in genere, sono lontani dalla nostra sensibilità riconosciuta e dai nostri gusti dichiarati”. La sua tesi, insomma, è che convivano, anche nelle persone più avvertite e più critiche, due estetiche: una ufficiale (“dichiarata”), che privilegia le opere di alta qualità, l’altra segreta, o semplicemente privata, nella quale trovano spazio i più svariati prodotti sottoculturali (di cui la canzone “d’autore” è solo una versione aggiornata). È un po’ quello che sosteneva Umberto Eco molti anni fa contro gli arcigni “apocalittici” della cultura, quando faceva osservare che la stessa persona può studiare Aristotele la mattina, leggere Topolino il pomeriggio e ascoltare un concerto di free-jazz la sera. Ma molti anni, appunto, sono passati, e le spalle degli intellettuali italiani sono meno larghe di quelle di Eco (o di Franco Fortini, di Italo Calvino, etc.). La mia impressione è che il pluralismo estetico sia ormai solo un modello ideale, se non un alibi, che nasconde il dominio sempre più incontrastato – anche presso molte persone “colte” – di quello che Manconi chiama sentimental-kitsch.
Nel libro mi ha colpito tra l’altro il richiamo – accanto ai soliti Pavese, Prévert, Neruda – a poeti come Camillo Sbarbaro, Giovanni Raboni, Vittorio Sereni, Elio Pagliarani, Giorgio Cesarano, Luciano Erba, Maurizio Cucchi, persino a un notevole dialettale come Paolo Bertolani, noto a pochi appassionati. Le letture poetiche di Manconi, evidentemente, vanno ben al di là di quelle – poco più che scolastiche – di tanti critici della canzone. E tuttavia il riferimento alla poesia, nel libro, resta sostanzialmente marginale. Peccato. Per capire che cosa sia il sentimental-kitsch, forse, sarebbe stato utile fornire qualche esempio di poesia “genuina”, e magari operare un sereno ma puntuale confronto tra il lavoro dei poeti e quello dei cantautori.
L’obiezione che si fa di solito a questo genere di operazioni è che i testi delle canzoni non possono essere separati dalla musica, dalla melodia e dal canto, perché a dover essere giudicato è il risultato d’insieme: la canzone è un oggetto estetico complesso. Verissimo. Il fatto è che in Italia, ancora oggi, le competenze dei critici – siano essi linguisti o sociologi, storici o giornalisti – sono per lo più letterarie: quasi nessuno di loro ha gli strumenti per valutare una canzone sul piano musicale. Così, il ricorrente confronto tra poesia e canzone (un vero tormentone culturale) resta condizionato da un giudizio, del tutto implicito e non argomentato, sulla qualità delle composizioni. La musica di un pezzo di successo, nel Paese dei Cantautori, è bella per definizione; il valore poetico dei suoi versi non è valutabile in sé. Il critico, certo, sarebbe anche in grado di giudicare il testo, ma farlo senza tener conto della musica non è corretto, e sulla musica egli ammette di non possedere specifiche competenze.
Giudicare la musica non si può, giudicare il testo non si deve. Logica vorrebbe che – in queste condizioni – il giudizio fosse sospeso. Invece, come sappiamo, la storia della canzone italiana è piena di capolavori. Chi ha stabilito che lo siano? Sostanzialmente, il pubblico. È lui, da molti anni, il solo critico accreditato. Il suo criterio è: a me mi piace.
Ma è possibile accontentarsi degli oracoli provenienti da vendite, classifiche e nostalgie collettive? Negli anni in cui Manconi inaugurava la collana “Il pane e le rose”, l’atteggiamento emergente nei confronti della canzone era un’attenzione appassionata e sospettosa. Il pubblico italiano cominciava a stancarsi dei cliché di tanta musica “commerciale” (proprio in quegli anni l’attributo assume un significato negativo), era curioso, pieno di aspettative; la critica si mobilitava per dare un orientamento al bisogno di novità e di qualità, per smontare gli idoli e i dogmi estetici. La legittimazione culturale della canzone – oggi più che acquisita – è anche il frutto di quell’investimento “politico” (in senso lato) sulle potenzialità artistiche e culturali di questo genere popolare. La canzone – negli Anni Settanta – è stata presa terribilmente sul serio; è allora che la musica “leggera” ha cominciato ad avere un peso enorme nella nostra cultura. Critici come Manconi, il compianto Giaime Pintor junior, o il giovane Gino Castaldo, hanno avuto il merito di promuovere un dibattito culturale adeguato all’importanza della canzone nell’immaginario degli italiani di quegli anni. In La musica è leggera, quello spirito battagliero sembra stemperarsi in una rassegna di aneddoti e nostalgiche rammemorazioni, dove Paolo Conte e Giuni Russo, Enzo Jannacci e Max Pezzali galleggiano nello stesso brodo postmoderno. Certo, Manconi ha qua e là un sussulto di intransigenza; ma da uno come lui era forse lecito aspettarsi qualcosa di più di una playlist commentata.