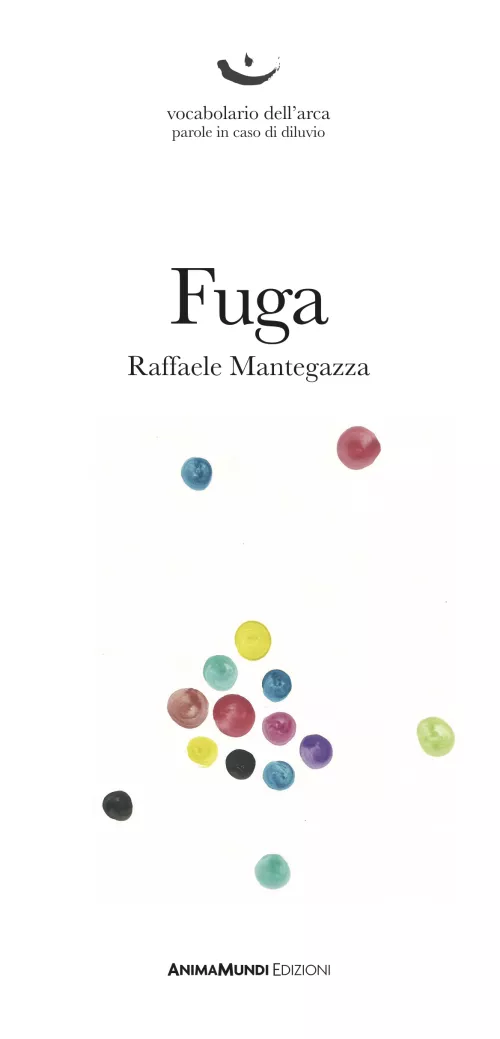Otto tipi di fuga
Sono parecchi anni ormai che la parola “fuga” ha assunto un’accezione positiva molto lontana dal suo significato originario di “resa”, come vorrebbe la retorica bellicista. Mediterraneo, il film di Gabriele Salvatores che vinse l’Oscar più di trent’anni fa, si apriva con una citazione del filosofo Henri Laborit («In tempi come questi la fuga è l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare»), tratta dal suo Elogio della fuga risalente al 1976, e si chiudeva con una presa di posizione ancora più esplicita: «Dedicato a tutti quelli che stanno scappando».
Fuga, il bel saggio di Raffaele Mantegazza pubblicato di recente da AnimaMundi Edizioni, censisce ben otto tipologie di fuga: le fughe fallite, quelle per e dalla libertà, le fughe in altri tempi, le fughe creative, quelle sacre, quelle imparate e infine quelle ricordate. Alla prima categoria, quella dei fallimenti, Mantegazza ascrive giustamente Kafka in relazione a Praga, che vedeva come una tirannica figura materna che lo tratteneva con “gli artigli di mammina”. Ma le madri tiranniche degli scrittori, responsabili di queste fughe mancate, o riuscite ma in modi goffi e precipitosi, non si contano, e spesso hanno il nome che comincia per A, come la marchesa Adelaide Antici per Giacomo Leopardi, o Adele Lehr per Carlo Emilio Gadda, o ancora Amelia Censi per Giorgio Manganelli, la cui tremenda possessività costrinse il figlio a una fuga leggendaria verso Roma a bordo di una Lambretta battezzata “Bakunina” (leggendaria anche nel senso di inverosimile, secondo alcuni).
Il saggio di Mantegazza, breve ma denso di riferimenti, ha un approccio comparatistico che analizza il concetto di fuga spaziando attraverso le diverse espressioni artistiche, ma la letteratura resta indubbiamente il suo centro di gravità. Il merito maggiore dell’autore è quello di essere riuscito a “nascondere tutto l'apparato libresco, e far parere che i giudizi, gli aforismi, i paradossi vengano fuori come fischiettando, perché questa è l'arte dei saggisti artisti, e quel che li distingue dal professorone, il quale invece per ogni ideuzza scomoda mezza storia della filosofia”, come scrisse Italo Calvino in una bellissima lettera a Elsa de Giorgi.
Fra le declinazioni del tema affrontate da Mantegazza non poteva mancare quella biblica e pittorica della Fuga in Egitto, soggetto praticato da generazioni di artisti nei secoli, come segnalato da una bella mostra svoltasi a Cremona l’anno scorso, che l’autore attualizza ricordando che in sostanza questa storia mette in scena “il destino di una famiglia di profughi”, non dissimile da quello di tanti disperati che approdano sulle nostre coste per scampare alla miseria e alle guerre di casa loro.
Curiosamente, una delle declinazioni più morbide e trasognate di quel tema pittorico fu opera di Caravaggio, il campione del naturalismo più crudo, l’artista della fuga per eccellenza, a partire proprio dagli ovvi riferimenti biografici (come la fuga mai chiarita da Milano, la fuga da Roma per il bando capitale, e infine la fuga da La Valletta per un reato talmente infamante da causargli l’espulsione dall’ordine dei Cavalieri di Malta come “membrum putridum et foetidum”), ma questo dipende soprattutto dal fatto che lui rappresentò il momento più idilliaco e bucolico di quel dramma, cioè il riposo durante la fuga in Egitto, quando la sacra famiglia si concede una sosta perché consapevole di aver scampato il pericolo. Anche in questo caso l’attualizzazione nasce spontanea, ricordando una costante dei racconti dei volontari che solcano il Mediterraneo per salvare i profughi che fuggono dall’Africa, ossia il fatto che la prima cosa che questi fanno, una volta che sono issati sulla nave e si sentono al sicuro, è proprio addormentarsi fiduciosi.

E qui il giovane Caravaggio, pur avendo inserito nella composizione l’anomalo e trascendentale angelo musicista, non manca di realismo nel dettaglio del sacco col materasso arrotolato su cui è poggiato san Giuseppe, molto probabilmente il materasso personale dell’artista, riconoscibile dalla fascia verde sullo spessore che infatti ritroviamo identico nel “triclinio plebeo” del Bacco degli Uffizi (non a caso gli unici suoi dipinti eseguiti su una tovaglia di lino di Fiandra); in pratica il classico materasso povero da piegare come il famigerato “cubo” della naja. E se c’è un dettaglio che identifica immediatamente i traslochi improvvisi e disperati dei nullatenenti è appunto il materasso, la cosa più preziosa, come nella famosa foto del 5 luglio 1913 che fissa una tappa del calvario di Amedeo Modigliani, lo sgombero della comune di rue Delta, con il carretto stipato solo dai materassi e dai suoi quadri.
Ma Mantegazza ci mette in guardia dall’idealizzare troppo la fuga, e ci avverte che non è sempre sinonimo di resistenza, come non significa sempre resa; è semplicemente uno strumento, e come tale dipende dallo scopo che ci si prefigge.
Prendiamo Rimbaud. Cosa rappresenta la sua fuga in Africa? Una capitolazione? L’ammissione che l’arte non può cambiare il mondo? Sì, certo, abbiamo perso il riformatore della lirica moderna, il veggente, così maturo per la sua età, ma come non amare il Rimbaud "fuggiasco" di Una stagione all'inferno, il Rimbaud sconfitto e "negro" che ricomincia da zero all’altro capo del mondo e tace ostinatamente rifiutando qualsiasi lusinga letteraria che gli giunge dalla Francia? Quante opere vale quel silenzio? O qualcuno crede che esistano inferni che non precipitano in uno di quei silenzi? A ben vedere, la sua fama oggi deriva sia dai libri che scrisse che da quelli che si rifiutò di scrivere, e nel suo destino africano troviamo inscritto il destino stesso di ogni opera d’arte, che, come affermava Maurice Blanchot, non è fatta per essere compiuta, ma per essere abbandonata.
Nel capitolo sulle “fughe imparate”, Mantegazza cita un brano di Walter Benjamin che tesse l’elogio dello scappare di casa da ragazzi, inteso come una sorta di fuga educativa da cui potrebbe dipendere “la fortuna di tutta una vita”. È vero, quella è l’età giusta, da grandi è impossibile fuggire con spensieratezza: si va via sempre con un occhio soltanto, l'altro resta indietro, supplichevole, a cercare d’immaginare quale effetto avrà la propria assenza sugli altri: cosa penseranno trovando il nostro letto vuoto? Impossibile saperlo, se non tornando indietro in quel luogo che pure già ci è, inspiegabilmente, estraneo, che è forse il motivo che spinse Wakefield a tornare, perché “solo nel breve istante del ritorno ci è dato di assistere improvvisamente alla nostra assenza”, come diceva Proust.
Benjamin ha ragione, eppure se c’è qualcuno che sbagliò clamorosamente i tempi della sua fuga fu proprio lui, che non capì quanto fosse incombente e minaccioso per un ebreo il pericolo nazista. Sordo alle continue profferte dell’amico Gershom Scholem, che da Gerusalemme gli offriva da anni un lavoro e una sistemazione, Benjamin si decise ad abbandonare la sua abitazione parigina, scappando in treno verso il sud della Francia ancora libero, solo quando le truppe di Hitler passarono sotto l’Arco di Trionfo. A Lourdes, in una pensione con vista sui Pirenei, aspettò due mesi i documenti per espatriare. Ma Lourdes non fece il miracolo, e così s’incamminò sulla route Lister, un impervio sentiero che valicava le montagne parallelamente alla strada ufficiale, di norma percorso solo da contrabbandieri che attraversavano clandestinamente il confine tra Francia e Spagna. Era il 25 settembre 1940.
La route Lister rappresenta l’ultimo dei suoi Passages, e forse non è un caso che l’intellettuale europeo che più di ogni altro coltivò un’autentica vocazione interdisciplinare, l’inclassificabile sempre in movimento da un ambito culturale a un altro, si sia tolto la vita proprio quando fu bloccato a una frontiera. Oggi che quelle barriere non esistono più, che quel sentiero si può percorrere liberamente in entrambi i sensi, la route Lister è diventata meta di pellegrinaggi letterari, una specie di Camino de Santiago laico dove far trekking espiativo e omaggiare la memoria di chi, come Benjamin, incarnò meravigliosamente “la bellezza e la purezza dell’insuccesso”. Ma proprio la sua tragica fine introduce secondo me la fuga per eccellenza, l’unica che non ho trovato nel bel libro di Mantegazza: il suicidio come la fuga estrema, la fuga dalla realtà, la fuga dal sé che si consuma a costo della propria soppressione, così come teorizzato dallo psicologo sociale Roy Baumeister. Una fuga senza ritorno e obbligata, se concordiamo con Guido Morselli, il quale sosteneva che “nessuno si è mai tolto volontariamente la vita. Il suicidio è una condanna a morte della cui esecuzione il giudice incarica il condannato”.