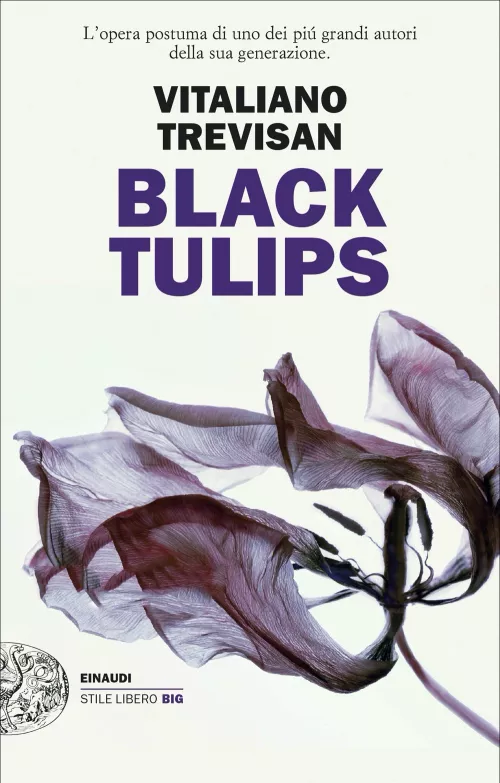Paesaggio terminale di Vitaliano Trevisan
Da un po’ di tempo a questa parte si fa un gran parlare di landscape, il termine inglese con cui si indica comunemente il paesaggio. Questo vocabolo, fuso con altri, ha generato tutta una famiglia di parole macedonia, come memoryscape, inscape youthscape, walkscape, bookscape, groundscape, mindscape o lastscape, che in patria magari esistevano già (inscape la coniò il poeta vittoriano Gerald Manley Hopkins, ed è la coscienza del paesaggio, come la montagna Sainte-Victoire per Cézanne), ma che qui hanno trovato nuova linfa rinnovando la tradizione dell’interiorità applicata a qualcosa di molto concreto (come il romanzo La città interiore di Mauro Covacich).
Walkscape, ad esempio, è un saggio di Francesco Careri sul camminare come pratica estetica; Mindscape è il titolo di un libro di Vittorio Lingiardi che parla del rapporto fra psiche e paesaggio; Groundscape era una mostra fotografica di Stefano Cioffi sulle superfici che calpestiamo quotidianamente; e un tipico caso di Bookscape è il finale del film Le invasioni barbariche, col primo piano delle copertine di cinque libri che riassumono la vita di un uomo coltivato che ha deciso di farla finita.
Chiudendo Black tulips, il libro postumo di Vitaliano Trevisan, la prima parola che mi è venuta in mente è proprio lastscape. Rispetto alle sue consorelle sopracitate, lastscape non è ancora in voga da noi, tant’è che la trovai citata solo in una biografia inglese di Mark Rothko, e forse l’associazione fra il libro di Trevisan e Rothko nasce appunto da un episodio specifico della vita del grande artista americano raccontato dal suo amico Brian O’Doherty. Questi era presente nel dicembre 1969, quando Rothko, già gravemente malato e depresso per la separazione dalla moglie, diede un party nel suo studio sulla 69esima per presentare i suoi ultimi dipinti cupissimi della serie Black on Grey, che considerava i più audaci che avesse mai fatto. Lastscape li definì Brian, paesaggi psichici terminali, ultimi orizzonti che il guardo escludono, come una premonizione di morte. Il collega e amico Robert Motherwell ricorda che quella sera Mark occupò per tutto il tempo il centro del grande atelier (una rimessa per carrozze del XIX secolo) senza aprir bocca e con lo sguardo perso dietro le spesse lenti, mentre sulle note del Don Giovanni di Mozart intorno a lui ruotavano gli invitati come i fedeli della Mecca, probabilmente ignari di trovarsi di fronte a qualcosa che si concepisce solo al culmine della disperazione, per usare il titolo di un libro di Cioran che Rothko aveva sul comodino meno di due mesi dopo, quando si tolse la vita.
Ecco, Black tulips per me appartiene a questo genere di opere. Parla del viaggio di Vitaliano Trevisan in Nigeria assieme a una prostituta sua amica conosciuta in Veneto (il tulipano nero in botanica è anche detto “Queen of the night”), ed è l’ultimo libro che ha scritto, “inviato a Einaudi qualche mese prima di morire”, come riportato in seconda di copertina.
Già la scelta dei tempi è paradossale. Lui decide di andarsene in un momento anomalo, al termine del processo creativo, quando ogni autore è curioso di conoscere il destino della sua nuova opera. Normalmente si muore con un libro a metà, interrotto, mentre lui ha diligentemente consegnato all'editore il testo finito e revisionato, rispettando così i termini contrattuali, e poi gli ha voltato le spalle. Ma la risposta la dà lo stesso Trevisan nelle prime pagine, quando confessa: “Cammino, come gli antichi, con lo sguardo rivolto al passato. Il futuro non ho mai saputo né vederlo né ritrovarlo, non sono mai riuscito a vedere me stesso nel futuro”.
Sebbene il biglietto di addio di Trevisan abbia chiarito che il suo non fu un gesto d’impulso, è molto probabile che Black tulips non sia stato scritto con quell’intenzione. C’era sicuramente, nel progetto del viaggio a Lagos, la volontà di eclissarsi e ricominciare da zero, di immergersi anonimamente nella folla di un altro continente e cambiare vita e lavoro, aggiornando così il bizzarro catalogo di mestieri svolti (vedi Works), seppure sempre con un modello letterario in testa (“Rimbaud trafficava in armi, io venderò pezzi di ricambio e abbandonerò la scrittura”), ma si rese subito conto della velleità della cosa (“realizzo il fatto di essere l’unico pallido […] posso scordarmi questo vizio di scomparire”) e rinunciò.

Il racconto non ha un andamento lineare (“quello che è accaduto è accaduto, se prima questo e poi quello non ricordo”), anche perché i libri di Trevisan hanno più trauma che trama, e poi non si è portato nulla per il viaggio, né il suo solito taccuino e neppure la macchina fotografica. Lo seguiamo per le strade polverose della Nigeria, tra gli sfasciacarrozze, gli hotel, inseguendo i ricordi più strampalati, da un premio letterario a Bari ai suoi rapporti con le prostitute nigeriane, che sono le parti più commoventi del libro.
Alcune pagine sono di una tenerezza infinita, come quelle su Hellen, una ragazza originaria di Benin City che una sera caricò in macchina per accompagnarla alla stazione di Verona e con la quale finì a letto senza pagare; un personaggio che ricorda la “buona ammirevole Molly” del Viaggio al termine della notte di Céline, perché al fondo, per entrambi, “l’importante è non rimanere soli, la notte, nella nostra stanzetta”. Durante i suoi giri notturni spesso, “una volta in macchina”, queste ragazze “si facevano così ostili, scorbutiche, impenetrabili, che scaricarle era un sollievo”, ma non Hellen, che si fidò di lui e gli fece sentire “tutta la sua disperazione”.
Con una lingua ossessiva e dai maestri dichiarati (Thomas Bernhard e Samuel Beckett su tutti), ma che resta adamantina anche nel cuore della tenebra, Trevisan riconosce le affinità con queste anime perse, che quanto più esibiscono il loro corpo tanto più risultano lontane e irraggiungibili, al pari degli scrittori autobiografici, che quanto più espongono il loro vissuto, come in una resa dei conti col proprio passato, tanto più sono soli, chiusi e disperati, perché tutti al fondo custodiscono qualcosa d'incondivisibile: un sogno di purezza, una nostalgia o una ferita immedicabile.
L’intera l’esperienza africana di Trevisan sembra improntata al desiderio di evitare facili pregiudizi, di non giudicare quella realtà con gli schemi paternalistici occidentali, da “oyibo” (bianco), a partire dalla condizione delle prostitute nigeriane che cercano fortuna da noi per una libera scelta più che per essere state ingannate, dato che “la professione viene considerata come una sorta di lavoro a termine, il tempo necessario per accumulare i soldi per mettere in piedi una qualche attività”.
Ma c’è un punto, che si salda proprio col discorso sul sesso, durante questo suo viaggio, che lo trova impossibilitato ad accettare il punto di vista nigeriano, ed è forse il momento più toccante del romanzo. Si tratta della scoperta di un cadavere in putrefazione, un corpo femminile nudo abbandonato a bordo strada a cui nessuno fa caso, tranne lui. Accanto a questo corpo martoriato passano e si fermano diversi pulmini, da cui scendono tutte persone totalmente indifferenti alla vista e all’odore. Questa indifferenza gli è incomprensibile, ne chiede conto ad Ade, la sua accompagnatrice nigeriana, e ottiene una risposta terribile: “se è ancora lì significa che non aveva nessuno, e dunque, in un certo senso, vuol dire che era già morta. Non ci si ritrova da soli per caso”. Questa conclusione è il segno dell’inappartenenza. Per quanti sforzi di comprensione può fare, Trevisan e le prostitute nigeriane restano delle monadi inconciliabili, esiliate una per una nella tortuosa irriducibilità della propria voce e del proprio dolore. La furia del dileguare, la sensazione che tutto stia sempre, continuamente, per finire, che ogni cosa o persona viva una specie di conto alla rovescia, come una corsa verso il nulla, è sua e solo sua, di uno che (come scriveva in Il Ponte), leggeva tutti i giorni la pagina dei morti del Giornale di Vicenza per aggiornare “la partita doppia della vita e della morte”. Non c’è possibilità di condivisione con nessuno per chi, come scriveva in Un mondo meraviglioso, ha fatto della propria vita “uno spaventoso assolo fuori tempo”, e dentro di sé ha “una sorgente di tristezza che si esaurirà solo con la morte”. Questa resta un’attitudine squisitamente occidentale, molto difficilmente esportabile. Luigi Baldacci la chiamava “la funzione Ruysch”, dalle mummie di Federico, quelle che fa parlare Leopardi, e l’attribuiva a un filone di autori che guardano la vita dal punto di vista della morte.
Al di là del profondo rispetto che si deve a chi sceglie di morire di propria mano, e ancora di più se è uno scrittore (dimensione tra le più fragili e spesso connaturata alla depressione), credo che un artista irriducibile come lui, che contava i passi perché vedeva e temeva la voragine sotto l’asfalto, sapesse perfettamente che non avrebbe avuto sconti.
Forse è stata proprio l'idea nobilissima e inarrivabile di letteratura che coltivava ad avergli armato la mano, quella della letteratura come esperienza della scomparsa, postulata da Blanchot, secondo la quale l’opera scritta, una volta fatta, non testimonia altro che la dissoluzione dell’autore.
Leggi anche
Jacopo Bulgarini d’Elci, Vitaliano Trevisan. Un ponte, un crollo
Gian Mario Villalta, Vitaliano Trevisan, alle estreme conseguenze