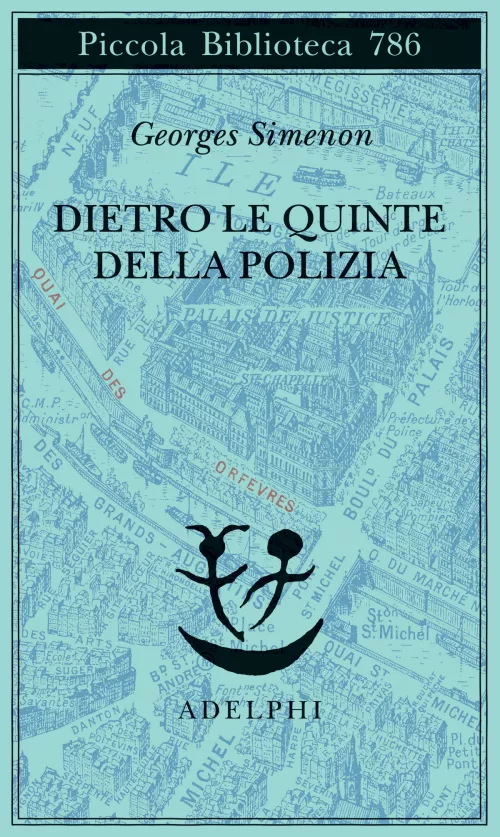Simenon, dietro le quinte della polizia
Spesso nella vita comune, come nel commercio e nelle professioni, vige il detto “il nome è una garanzia”, e con Simenon non si sbaglia. Anche se non sono romanzi con Maigret o senza Maigret, anche se non sono racconti brevi o lunghi, il suo graffio esiste sempre, marcato e indelebile. È quanto avviene ora con la collana di Adelphi dedicata agli articoli sparsi in riviste di ogni genere, ambientate in mare o in terra ferma. Questa volta è di scena la Polizia (Georges Simenon, Dietro le quinte della polizia, Adelphi 2022).
Negli anni 30, da poco nato Maigret con Pietro il lettone, Simenon viene invitato a visitare gli ambienti della Polizia criminale e di sicurezza. E non si lascia scappare l’occasione, osservando e scrivendo articoli che vengono pubblicati da “Paris Soir”, a “Je sais tout”, a “Voilà”, a “Police et Reportage”. Tra queste svetta “Détective”, ideata da Gallimard nel 1928 per descrivere fatti di cronaca, nera ma soprattutto vera. Vi furono coinvolti intellettuali come Jean Genet e Simone De Beauvoir, firme illustri come Cocteau e Bove, uomini di spettacolo come Fritz Lang e Alain Resnais. Con spirito eversivo e una scrittura di avanguardia, “Detective” fece circolare al suo interno, senza rassicurazioni, le tossine del delitto, come si può constatare nella parziale ripubblicazione da parte di Meridiano Zero nel 2001.
Gli scritti che compaiono nel volume ora uscito in realtà non sono di cronaca nera nel senso classico del termine. Di certo si parla di casi, di omicidi, di sentenze, di condannati e in questo senso lo si può leggere come una consueta raccolta di vicende processuali. Nella filigrana delle pagine che scorrono velocemente emergono però le fattezze umane e letterarie dell’autore. Il suo occhio è una sorta di faro perennemente alimentato dalla curiosità verso i luoghi, verso gli altri, verso le storie, qualunque esse siano. Egli gironzola, fuma la pipa, si diverte, ascolta, osserva inesauribile attorno a sé i volti, i movimenti, le storie individuali, e le racconta entrando nella pelle altrui senza perdersi, lasciandosi portare come osserva un fedele studioso (Lacassin, Conversazione con Simenon, Lindau 2004). Il tutto è tradotto sulla carta con la leggendaria facilità che gli è propria, da artigiano senza indugi stilistici, senza sprecare una virgola, con quella rara capacità di far lievitare dalle righe scritte le descrizioni visive. Celebri sono gli “incipit” dei romanzi dove il lettore entra nella scena e ne diviene muto spettatore. Come non ricordare l’esordio di La camera azzurra (1964) con i due amanti che in quella stanza tramano per cambiare il proprio destino, o la tensione spesso vana del dott. Mahé in Il clan dei Mahé (1946), nel cercare di aver successo nel pescare?
E in questa raccolta di articoli non può passare sotto silenzio l’esordio di “Il pronto intervento”: “Nella grande stanza, dove due finestre sono aperte nella notte, sono in quattro, quattro impiegati dall’aria paciosa. Due di loro indossano un camice grigio, un altro, che ha molto caldo, è in maniche di camicia, mentre il quarto che ha appena finito di mangiare un panino con il salame, raccoglie le briciole, poi appallottola la carta unta e la getta nella stufa” (p. 157).
La curiosità in Simenon si congiunge a un’altra caratteristica: quella per i dettagli. Maigret, ed è l’esempio tipico, per riprendere quanto scritto da Luca Bavassano in “Maigret e il cibo, ovvero il metodo del torpore” in Racconti a tavola (Historica Edizioni, 2019), "non ha un metodo quale viene comunemente inteso, non sviluppa una rigorosa concatenazione di ragionamenti a partire da dettagli rivelatori, non segue (...) alcun “paradigma indiziario” comune ai classici della narrativa poliziesca". "È invece proprio l’assenza di un metodo che consente a Maigret di farsi “impregnare” dagli ambienti sempre diversi in cui si svolgono le inchieste, di immedesimarsi nei più diversi personaggi, di "fiutare" l'anima delle persone e delle cose". Esemplificativo è il "colloquio con il criminologo americano, appositamente giunto a Parigi per studiare il suo metodo": "Dev'essere deluso lei che sperava di studiare i miei metodi, come diceva stamattina... La faccio sguazzare nella pioggia... La porto in un banalissimo municipio, poi le faccio mangiare del pollo al vino... Cosa vuole che le spieghi?... Io le cose le sento..." (Cecile è morta, 1942)

Il commissario intuisce, comprende, non ha schemi, cerca i segni, i nessi, non le cause. “Un lampo di trionfo negli occhi di Maigret. Era sicuro, non si basava che sulle intuizioni, sul dettaglio “infime” diremmo noi il più essenziale” (L’affare Picpus, 1954). La sua è la “strategia della percezione sensibile” che vuole avvicinarsi all’essenzialità dell’uomo assegnando rilevanza ai “segni secondari”, alle trasmissioni di significati elementari quali le impressioni sensoriali, gli sguardi, i movimenti muscolari del volto, gli sbocchi di calore, le comunicazioni non verbali “preferendo alle parole ed al linguaggio le attitudini, il non detto portatore di emozioni” (L’affare Picpus, citato). Di qui anche la simpatia di Sciascia per questo detective che ha più sviluppato il dato ‘umano’ nell’indagine e la capacità di assorbire “come una spugna gli elementi psicologici e ambientali da cui sono scattati i delitti”. (Sciascia, Il metodo di Maigret, Adelphi, 2018).
Poi gli indizi vengono riuniti in una attività mentale rielaborativa individuando l’ipotesi non statistica o matematica ma probabile, plausibile, verosimile (M. Bonfantini, Semiosi o abduzione, Bompiani, 2004). È l’appello all’istinto, all’intuizione sulle facoltà razionali, celebrando una sorta di ritorno al sapere comune, collettivo, cui si richiama un uomo come il nostro commissario “comune”, ordinario, senza particolari doti, mosso da una incontrastata sensibilità intuitiva, come peraltro indica l’uso frequente di verbi quali “sentire”, “annusare”, “avere l’impressione”.
Questo binomio stringente di curiosità e attenzione ai dettagli è esaltato in un’altra peculiarità, meno nota rispetto alla scrittura ma egualmente significativa, la fotografia, come dimostrano alcune raccolte (L’oeil de Simenon, Galerie National Jeu de Paume, 2004, Les photographies de Simenon, Musée de la photographie à Charleroi, 2001, Fotografie di viaggio, Archinto, 2006) e commenti (Benoit Denis “Georges Simenon. Les obsessions du voyageur”, La Quinzaine, 2008).
In realtà Simenon non ha mai cercato di esprimere idee, ma la sua attenzione è sempre stata concentrata sulle persone, sui “male amati dalla vita”, in quanto ogni esistenza merita di essere narrata. Vuole arrivare a descrivere l’“uomo nudo” fuori dalla storia e dalla società, una sorta di personaggio eterno ed essenziale che merita attenzione e comprensione. I momenti della storia gli sono indifferenti perché lo sfondo delle esperienze individuali non ha guerre, provocando però qualche irritazione nei suoi fedeli lettori. Simenon ha attraversato un secolo lugubre, pieno di macerie che non si coglie nelle sue opere. Anzi egli è talmente insensibile da indicare nel 1940 quale assassino un ebreo in “Sconosciuti in casa” ora ripubblicato come Gli intrusi, e nelle Memorie intime (1981) descrivere il suo barcamenarsi in quel periodo, non connivente con i tedeschi ma malleabile per evitare guai. È pur sempre innegabile il suo interesse per i perdenti e i ribelli, per le loro esperienze lacerate. È dal mondo della sua infanzia che ha tratto il materiale di base per un’opera sconfinata: da esperienze familiari, da un’educazione cattolica anche se ne ha rifiutato i contenuti sessuofobici da perseverante cacciatore di femmine.
Ha però attinto quella sorta di “pietas” che condanna il peccato e non il peccatore, quel monito per cui si comprende e non si giudica. Descrive gente modesta, destini che si rompono in una cornice in cui il vivere è un esercizio temibile perché ci si può imbattere in un ostacolo che frantuma, disgregando così anche le più ottimistiche premesse. Questo qualcosa è un’anomalia che là dove c’era la quotidianità ne scuote la superficie, irrompe nella calma piatta della scena. È il caso dei sospetti in una comunità puritana (La morte di Belle, 1952), l’illusione per un’altra esistenza (Il borgomastro di Furnes,1939), la fuga verso l’ignoto (Lettera al mio giudice, 1947), il matrimonio rotto (In caso di disgrazia, 1956). Dopo la fiammata tutto ritorna come prima, spesso peggio di prima, esaurito il sogno di “lasciare un mondo nero e fantomatico, un’esistenza irrigidita, la paura dell’altrui genere” (La fuga del signor Monde, 1945).
Crescono sogni incompiuti (L’uomo che guardava passare i treni, 1938), si alimenta l’incomunicabilità di cui il sesso meccanico è la variante più palese. E Simenon lo sa bene, questo Dostoevskij tranquillo, senza ansie metafisiche, senza idioti tormentati o santi alla ricerca della verità. Con un mondo privato non adamantino, scarsamente coraggioso, conservatore nel profondo, egli si è riscattato mostrando la solitudine e la debolezza degli uomini in un mondo crudele, con genuina sensibilità per il loro dolore, convinto che alla fine costoro, questi poveri eroi, si assumeranno il peso del proprio destino come in ogni tragedia. Senza trucchi, senza compiacere il lettore.
E la domanda è sempre la stessa: perché questo scrittore continua ad essere letto dopo tanti anni, dopo una diffusione planetaria già avvenuta? Una risposta la fornisce lo stesso Simenon “quello che cerco è che la gente mi legga. Se mi leggono vuol dire che non mi sono sbagliato sull’uomo. Se i personaggi fossero falsi, non mi leggerebbero ovunque”. Forse sarà stato, come sostiene taluno, “un imbecille di genio”, ma di certo continua a stupire. Sempre in positivo.
Per un errore redazionale, ora corretto, abbiamo omesso di di segnalare le citazioni dal saggio di Luca Bavassano, “Maigret e il cibo, ovvero il metodo del torpore”, tratto dal volume Racconti a tavola, Historica Edizioni, 2019. Ce ne scusiamo con l'interessato e con i lettori.