Una tragedia americana
Quella mattina, Ureka imbocca l’autostrada sul lago. A metà del ponte accosta e fa scendere il figlio Elijah, cinque anni. “Devi andare da Dio”, gli sussurra prima di spingerlo giù dal parapetto. Poi tocca a Joshua, dieci mesi. Da quell’altezza è un volo da mozzare il fiato, uno schianto nell’acqua. Una volta sola, la donna risale in macchina e si allontana. La arrestano la sera stessa in Texas, in una cittadina a mezz’ora di distanza.
Questa è una storia che dista anni luce dai temi che impegnano le prime pagine: Israele e l’Ucraina, l’immigrazione, i processi di Trump e l’età di Biden. Eppure illumina, più di tanti editoriali, la faccia scomoda degli Stati Uniti – quella che la politica elude e il discorso pubblico fatica a intercettare. È una tragedia tutta americana ed è la mappa di una condizione. Per cogliere gli umori e i non detti, la rabbia e lo scontento di questo tempo elettorale, vale dunque la pena tornare indietro nel tempo e ripercorrere i passi che conducono a quel ponte.
Succede nel 2021 nel profondo Sud e la notizia rimbalza sui media nazionali. Gli ingredienti sono irresistibili: una madre che leva la mano contro i figli, una vita burrascosa e un finale dove spunta la mano di Dio. La foto di Ureka finisce ovunque e farne uno stereotipo è fin troppo facile – afroamericana, homeless, disoccupata, precedenti con la giustizia. I dettagli si sprecano e il vento del pregiudizio travolge ogni pietà. Non ci avrei fatto caso se non fosse accaduto in Nord Louisiana, nella città dove vivo. Però per settimane quaggiù non si è parlato d’altro e dopo un po’ la vicenda ha iniziato a ossessionarmi. Così ho esplorato gli archivi, ricostruito i passaggi mancanti. Poi ho lasciato che a parlare fosse la dimensione del quotidiano e d’un tratto i tasselli sono andati al loro posto.
L’ultimo atto di questa tragedia si svolge a Cross Lake, un bacino artificiale creato negli anni Venti in quella che allora era aperta campagna. È un paradiso naturale, una meta classica del fine settimana locale e chissà quante domeniche ha trascorso qui Ureka. Lungo le sue sponde si riproducono le linee di faglia che segnano tante realtà a Sud. Un fatiscente quartiere afroamericano dove gli spari sono all’ordine del giorno; un parco ombroso da cui i bianchi preferiscono tenersi alla larga e sulla riva una sfilata di ville con giardini che digradano verso l’acqua e pontili privati. Basta avere gli occhi per vedere come si distribuisce la linea del colore, ma qui va così e nessuno ci fa caso.
A dare l’allarme è un giardiniere che lavora in zona. Ha visto un bambino galleggiare al largo: forse un incidente, forse un gioco finito male. Poco dopo, un’increspatura nell’acqua rivela alla motovedetta della Guardia costiera un corpo immobile di schiena. Elijah. Quando lo chiamano, si dibatte terrorizzato. Ha il viso e il corpo tumefatti dall’impatto con l’acqua ma è vivo. Non c’è niente da fare invece per il piccolo Joshua.
I fratelli devono aver trascorso in acqua una o due ore, concludono gli inquirenti. E come abbia fatto Elijah a sopravvivere resta un mistero o un miracolo. “È stata la mano di Dio a tenerlo a galla. Non sapeva nuotare e sua madre ne era a conoscenza”, commenta sui social Miss Mara in un post molto apprezzato e non è una battuta. Nella Bible Belt, dove le chiese sono più numerose dei supermercati, Dio è una presenza palpabile. “Jesus changes everything”, ammonisce la pubblicità sulla fiancata del bus. “Jesus 2024, our only hope”, suggerisce la versione elettorale e vista la situazione quasi viene voglia di crederci. In questo mondo, le ultime parole di Ureka ai figli hanno un suono familiare. Evocano la religiosità così diffusa nella comunità afroamericana, il linguaggio della Bibbia e quello di tutti i giorni: sono il sacrificio di Isacco, la predica della domenica, i discorsi di Martin Luther King.
L’ultima notte insieme, Ureka e i bambini la trascorrono in un motel. Al risveglio, vanno in un drugstore e comprano degli snack per colazione. Sono diretti a casa della nonna, dove vive la sorella tredicenne, ma non arriveranno mai. La madre svolta in autostrada e la ragazzina si salva.
Un ultimo moto d’affetto? Di nuovo la mano di Dio? Non lo sapremo mai e poco importa. Quel che conta, di nuovo, sono gli snodi del quotidiano – a partire dal motel, uno delle migliaia che punteggiano le periferie americane. Un tempo paradiso degli automobilisti, sono ormai una tappa obbligata nel circuito sempre più affollato della povertà. L’ultimo conteggio parla di almeno 653 mila persone che trascorrono le notti in casa di amici, in macchina, in tenda, nei rifugi per senzatetto e, appunto, negli hotel più economici. È il 12 per cento più dell’anno precedente, un livello record.
È la ragione per cui Ureka e i bambini arrivano lì. Negli ultimi sei mesi hanno dormito in macchina: per quanto squallida, quella camera è un sollievo – la sicurezza di un tetto sulla testa, una doccia a disposizione. E qui cade l’interrogativo che pesa come un macigno su questa storia. Come succede che una donna di 32 anni e i suoi figli piccoli arrivano a questo punto? Nessuno può dire che non sapeva. Questa non è una disperazione che si consuma in silenzio, ma un urlo prolungato di angoscia.
All’indomani dei fatti, la madre e le due sorelle si chiamano fuori. Sapevano che era senza casa e lavoro, avevano sentito dire che dormiva in macchina: però chi poteva immaginare che andava a finire così? Evocano problemi di salute mentale (“Aveva bisogno di aiuto, ma non sapevamo come”) e si dicono preoccupate per i bambini – anche se l’esistenza del piccolo Joshua è stata una sorpresa. “La prima volta che mia madre ha visto quel nipote è stato nella bara”, garantisce una sorella.
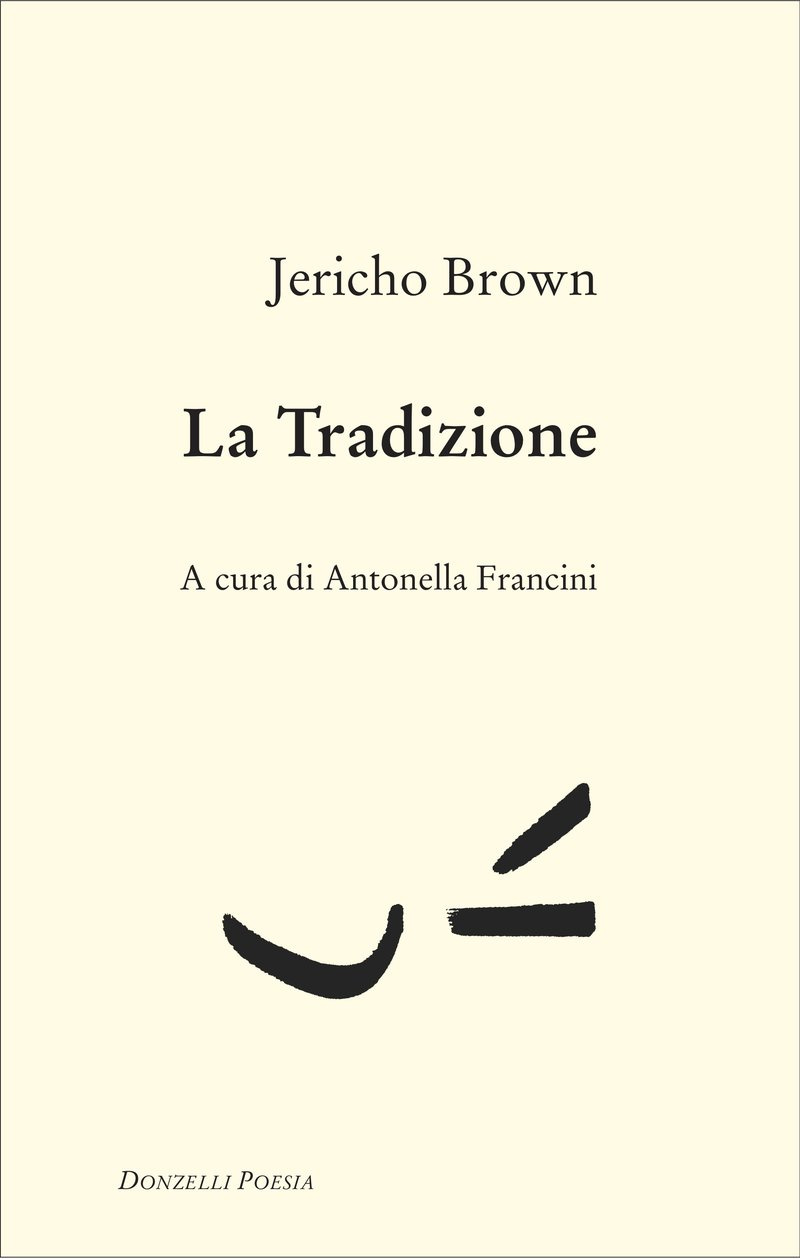
Nessuno menziona il padre dei bambini e nessuno degli amici si fa avanti.
Si parla molto della solitudine degli americani ed è un aspetto che colpisce chi arriva dall’Italia, dove famiglia e socialità sono valori forti. Il surgeon general Vivek Murthy l’ha dichiarata una epidemia in piena regola, come il fumo di sigaretta e l’obesità. È un tema serio e ha un ruolo in questa storia, ma alla luce dell’epilogo la domanda più pressante non riguarda i singoli ma le istituzioni.
Non è un mistero che da anni siano in affanno e la conferma della loro assenza è arrivata dalla pandemia, nota sul York Times il sociologo Eric Klinenberg. “Mentre altri paesi costruivano fiducia e solidarietà, l’America – durante e dopo il 2020 – ha lasciato milioni di persone a combattere per conto proprio”. Nel frangente più drammatico della storia recente, gli americani si sono ritrovati in una situazione di isolamento strutturale, “abbandonati dai datori di lavoro, privati di uno scopo e di cure”.
Quella ferita non si è mai rimarginata. Al contrario, le diseguaglianze si sono approfondite, il paese è diviso, i prezzi sono alle stelle, 12 americani su cento vivono in povertà e la fame resta un’emergenza drammatica. Se oggi le rassicurazioni di Biden sull’economia lasciano il tempo che trovano e Trump macina punti nei sondaggi, conclude Klinenberg, è perché “per milioni di americani, la sfiducia è lo stato più razionale”. Basti ricordare la sorte del Child Poverty Reduction Act. È stata una delle azioni più efficaci dell’amministrazione Biden e nel 2021 ha dimezzato il numero dei bambini in povertà estrema. Peccato che l’anno dopo il provvedimento sia stato abolito riportando cinque milioni di bambini al punto di prima.
In questo senso, la parabola di Ureka è esemplare. Ha trascorsi con la giustizia e ripetuti contatti con i servizi sociali. Dopo alcuni arresti, la figlia è stata affidata alla nonna e lei rinviata a “lezioni di genitorialità e gestione della rabbia”. Si defila e tutto finisce lì. Poi la vita continua: ha due bambini, si trasferisce, si separa, perde il lavoro e torna alla casella di partenza. Ultima destinazione, un motel nei sobborghi. Le opportunità di alterare il suo percorso o almeno proteggere i suoi figli non sono mancate, ma la rete che dovrebbe sostenerla è così fragile che la sua caduta si avvita nel vuoto.
È una trama che sembra uscire dalla pagine di Jesmyn Ward, che scrive dal Mississippi. E più volte, scrivendo, sono tornata al suo romanzo Canta, spirito, canta (NN 2019) che accompagna una madre in viaggio con i due figli piccoli verso il carcere dov’è recluso il padre. Un’altra guida mi è arrivata dai versi di Jericho Brown, nato e cresciuto nella stessa città di Ureka, in uno dei quartieri più difficili, premio Pulitzer con la raccolta La tradizione (Donzelli, 2022). Entrambi gli autori sono afroamericani e scrivono della loro comunità: il loro racconto è una bussola preziosa per orientarsi in un mondo spesso relegato a poche righe in cronaca. È un invito a capire e al tempo stesso una spinta ad allargare lo sguardo. Immaginare in bianco e nero il confine del bisogno è infatti fuori luogo come immaginare che sia un’esclusiva del Sud più arretrato – magari le cose fossero così facili.
L’epilogo arriva nel settembre 2023. Ureka è accusata di omicidio di secondo grado e tentato omicidio. Al processo piange ricordando i figli. “È stato il mostro dentro di me”, dice. I medici hanno però escluso l’infermità mentale e la giustizia segue il suo corso. La giuria raggiunge il verdetto nel giro di un’ora e la condanna all’ergastolo.
Il giorno dopo, restano solo le domande. Questa è la storia di una donna e le sue ragioni appartengono solo a lei. Ed è la storia di com’è facile perdersi e affondare in una società di ricchezze favolose e disperate povertà, dove il pregiudizio fatica a morire e lo svantaggio e la fragilità sembrano non avere più diritto di cittadinanza. A queste condizioni, la rabbia, il pessimismo e la crudeltà che scandiscono questa campagna elettorale hanno il suono di una verità che nessuno di noi vorrebbe sentire.









