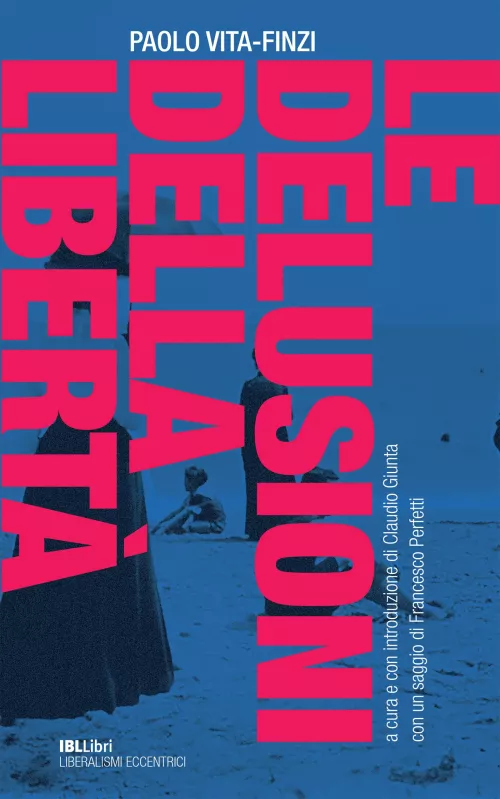Vita-Finzi e gli inconsci precursori del fascismo
Nel 1961, grazie all’interessamento di Giuseppe Prezzolini, Paolo Vita-Finzi pubblica per la casa editrice Vallecchi Le delusioni della libertà, ora riproposto da IBL come primo titolo di una collana dedicata ai «Liberalismi eccentrici».
Il libro contiene diversi profili – o forse meglio dei “ritratti critici” – di una generazione di intellettuali italiani e francesi attivi soprattutto tra fine Ottocento e fascismo – in gran parte apparsi negli anni ’50 sul settimanale «Il Mondo» di Mario Pannunzio.
La caratteristica comune, o ciò che Vita-Finzi ritiene costituisca il loro tratto comune, consiste nel fatto che, a suo giudizio, essi si presentavano come «inconsci precursori» del fascismo e, più in generale, dei regimi illiberali; o avevano subito, per un certo periodo, il «fascino» di ciò che poteva rappresentare il movimento fascista. In quella galleria di storie di vita entrano sia personalità che la critica storica e letteraria ha riconosciuto nella famiglia dei simpatizzanti (per esempio Prezzolini, Papini, Soffici, Sorel…), sia figure che tradizionalmente sono state collocate nel campo avverso (per esempio Benedetto Croce).
È interessante il laboratorio di costruzione di quei profili che Paolo Vita-Finzi propone, così come è interessante il criterio che adotta per dare corpo e fisionomia a quella galleria di figure. Ne riprendo qui alcuni.
Comincio da Ardengo Soffici [pp. 73-80]. Se il laboratorio che Vita-Finzi propone di considerare è soprattutto quello dal quindicinale “Lacerba” (1 gennaio 1913 – 22 maggio 1915) che dirige insieme a Giovanni Papini, l’inizio di quel percorso, Vita-Finzi lo individua in Lemmonio Boreo, racconto che Soffici pubblica nel 1911. Testo in cui il protagonista presenta tutte le ambiguità del cittadino arrabbiato in rivolta: da una parte il progenitore di Gabibbi e Iene, un cavaliere errante manganellatore e raddrizzatore di torti; dall’altra la prima forma organicamente costruita dello squadrista quale comincerà a girare per l’Italia a partire dal 1919.
Profilo, osserva Vita-Finzi, che richiama lo spirito del Don Chisciotte: errante per «raddrizzare il mondo» ma che, a differenza di quello, non ha la nostalgia di un tempo che non c’è più, ma la consapevolezza di avere la storia e il futuro dalla propria parte.
Nelle pagine dedicate a Soffici e sulla sua prefigurazione della centralità della violenza politica in Italia, Vita-Finzi rintraccia contemporaneamente un doppio registro: la funzione della dissacrazione della politica della «casta» (per Soffici definitivamente dimostrata nell’estate 1914 dallo smarrimento del governo italiano di fronte allo scoppio della guerra); la necessità di sostituirla attraverso l’azione delle avanguardie entrando in guerra senza esitazione (è l’editoriale che Soffici pubblica con il titolo Per la guerra in “Lacerba” del 20 settembre 1914).
Nel numero successivo del quindicinale Giovanni Papini dichiarerà il suo amore per la guerra e nelle sue parole ritroviamo gran parte della retorica che risuonerà soprattutto nel linguaggio squadrista dell’assalto alle Camere del Lavoro (e che Italo Balbo descriverà nel suo Diario 1922): “Finalmente è arrivato il giorno dell’ira dopo i lunghi crepuscoli della paura”.
Papini esordisce con queste parole per poi proseguire: “Finalmente stanno pagando la decima dell’anime per la ripulitura della terra. Siamo troppi. La guerra è un’operazione malthusiana. C’è un di troppo di qua e un di troppo di là che si premono. La guerra rimette in pari le partite. Fa il vuoto perché si respiri meglio. Lascia meno bocche intorno alla stessa tavola. E leva di torno un’infinità di uomini che vivevano perché erano nati; che mangiavano per vivere, che lavoravano per mangiare e maledicevano il lavoro senza il coraggio di rifiutar la vita.”
E alla fine chiude con un inno alla guerra, ma soprattutto con un grido al trionfo del maschio: “Amiamo la guerra ed assaporiamola da buongustai finché dura. La guerra è spaventosa e, appunto perché spaventosa e tremenda e terribile e distruggitrice, dobbiamo amarla con tutto il nostro cuore di maschi” (Giovanni Papini, Amiamo la guerra, in “Lacerba”, n. 21, 1 ottobre 1914).
Diversa la parabola di coloro che invece si trasformano e traghettano da sinistra a destra. La caratteristica fondamentale che li connota sono i processi di delusione. Per esempio Charles Péguy, oppure Daniel Halévy.
Charles Péguy [pp. 11-22] all’inizio, ovvero a metà anni ’90, è la figura principale e di fatto in gran parte ispiratore del movimento di opinione a favore di Alfred Dreyfus nel lungo percorso che ne accompagna la messa sotto accusa e poi il processo, la condanna, la carcerazione fino a tutto il percorso che lentamente – qui il protagonista sono soprattutto Émile Zola e il socialista Jean Jaurès – ne consente la scarcerazione poi la riabilitazione.
Collocazione politica che inizia a sgretolarsi non perché Péguy ora giudica Dreyfus colpevole e dunque non meritevole di difesa, ma perché «disgustato» del perbenismo democratico che ora auspica – come un coro senza inquietudini – la scarcerazione di Dreyfus. Una dimensione che non si fa domande sul potere e che soprattutto denigra la patria.

Così, venti anni dopo quell’impegno per la libertà e la giustizia, alla vigilia della guerra, Péguy si trova a condurre le sue battaglie politiche accanto a quelle figure che venti anni prima stavano dalla parte opposta alla sua. Il segno più evidente è l’accoglimento da parte sua del vocabolario che venti anni prima rifiutava o respingeva e che ora gli appare degno di difesa, minacciato dal conformismo di chi non vuol fare sacrifici, di chi chiede alla politica vantaggi e favori, ma non è disposto a riconoscere la necessità di dedicare parte di sé alla tenuta della comunità nazionale.
Un profilo simile ma più compiuto è rappresentato da Daniel Halévy [pp. 37-42] e dalla sua Histoire de quatre ans, 1997-2001, pubblicato in prima edizione nel 1903 e in italiano col titolo Il Castigo della Democrazia, storia di quattro anni 1997-2001 nel 1911.
Testo che in qualche modo va letto come una distopia, ma soprattutto come la storia di una delusione. Il profilo temporale e la causa della rabbia di Halévy è simile a quello di Péguy, ma a differenza di questi, Halévy denuncia il disgusto nei confronti del parlamentarismo e della democrazia in nome dei quali aveva scelto di stare dalla parte di Dreyfus, perché quello stesso meccanismo di corruzione che stava alla base dell’accusa di Dreyfus ora per Halévy è quello che muove la campagna per la laicità dello Stato (che poi produce la legge di separazione tra Stato e Chiese e il cui effetto immediato è, secondo l’art. 30 della legge, la proibizione dell'istruzione religiosa nelle scuole statali per studenti tra i sei e i tredici anni).
Una condizione rispetto alla quale Halévy non esita ad auspicare un regime energico, dittatoriale, guidato da un Capo. Qualcosa che si potrebbe interpretare come un auspicio di ciò che a partire dal 1922 inizia ad esser vero in Italia, o che prefigura quella Francia di Philippe Pétain, fondata su “Dio, Famiglia, Patria” – che, infatti, non lo troverà né insensibile, né indifferente.
Diversa fisionomia, ma non minore problematicità, Vita-Finzi costruisce per riflettere sulla parabola politica di Benedetto Croce. Così per esempio sono i tre interventi dedicati a Croce [pp. 111-142], laddove Vita-Finzi insiste sul fascino – o forse meglio sul «credito di fiducia» – che Croce prova nei confronti del fascismo soprattutto tra Biennio rosso e primo governo Mussolini (1919-1924), in funzione di contenimento del pericolo rosso.
Sono quelli gli anni in cui Croce «mette da un canto» (o forse sarebbe meglio dire «manda in soffitta») le sue preoccupazioni sulla libertà e si preoccupa soprattutto del mantenimento dell’ordine, salvo poi riprendere quelle preoccupazioni all’indomani del risultato delle elezioni dell’aprile 1924 (quelle che danno con premio di maggioranza la maggioranza assoluta alla lista che ottenga il 25% dei voti).
Sono le elezioni in cui la Lista Nazionale guidata dal PNF ottiene così i 2/3 dei seggi della Camera dei deputati, eleggendo in blocco tutti i suoi candidati. Risultato ottenuto in forza di violenze e intimidazioni che Giacomo Matteotti il 30 maggio 1924 denuncia in apertura della XXVII Legislatura, intervento che, come noto, gli costerà la vita.
La biografia culturale e politica di Benedetto Croce, sottolinea Vita-Finzi, va dunque profondamente rivista, anche oltre le sue stesse ammissioni; quella biografia non fu sempre linearmente costruita intorno all’affermazione del principio della libertà.
Quell’affermazione, o quel canone che è essenziale all’indomani dell’affermazione del sistema dittatoriale, e che ha il suo luogo manifesto nella primavera 1925 con il manifesto degli intellettuali antifascisti, in contrapposizione a quello – primo firmatario Giovanni Gentile – degli intellettuali fascisti non denuncia una fedeltà a una lunga continuità. Al contrario denuncia un passaggio che per certi aspetti non fu né unico né ultimo, che avvenne nei due sensi.
Per esempio Arturo Labriola, uno che in quel tempo denunciò l’impotenza dell’opposizione aventiniana di cui si sentiva parte ma che ebbe molti approdi prima vicino al fascismo e poi in opposizione, con molti percorsi di «andata e ritorno». Così come l’adesione al manifesto degli intellettuali fascisti non fu una scelta irreversibile. Per esempio Lionello Venturi: nel 1925 firmatario del manifesto promosso da Giovanni Gentile e poi tra i 12 docenti a dire no nel 1931 e dunque a opporsi in solitudine (in tutto furono 12 su 1250 i docenti universitari che dissero no, come ha ricostruito Giorgio Boatti). Un rifiuto che gli costerà l’esilio.
L’intento di Vita-Finzi si presenta come opposto a quello che sembra coniugare destra e anticultura, soprattutto quando si parla di intellettuali visti come disgregatori dell’identità nazionale, affascinati dal cosmopolitismo, al servizio di forze politiche estranee alla nazione e che vogliono la sua dissoluzione (un tema su cui di recente è tornato a scrivere lo storico Francesco Germinario con il suo Gente malfida, Ombre corte)
Il tema, per Vita-Finzi, è che a destra o in chi approda a destra prevale la progressiva delusione, fino al rifiuto di quella vocazione del pensiero liberale e democratico. Tema su cui spesso a destra e nella storiografia di destra si denuncia una stoltezza culturale degli storici o filosofi che con un tratto militante di sinistra indagano il fascismo e le destre individuando come loro tratti fondanti l’antintellettualità e l’anticultura; anzi, che il tratto fondante e connotativo le destre sia l’assenza di cultura così come fondamento di quella parte politica sia prevalentemente, se non esclusivamente, il culto dell’atto violento.
È su questo aspetto che insistono sia Francesco Perfetti, sia Claudio Giunta nei due saggi che accompagnano la nuova edizione di Le delusioni della libertà. Il primo riproponendo il confronto tra Norberto Bobbio e Augusto Del Noce appunto sul dato culturale del fascismo; il secondo insistendo sull’insofferenza delle procedure che rallentano il processo decisionale, la devozione a un ideale quasi messianico del popolo e la riduzione della questione politica a questione morale.
Non sono questioni fuori luogo. Ma vorrei sottolineare due dati su cui non mi sembra di aver trovato traccia né nelle considerazioni di Perfetti né nelle riflessioni di Giunta.
Prima questione. Rispetto agli anni ’70, ovvero al dibattito e al confronto Bobbio/Del Noce, non sarebbe fuori luogo ricordare la produzione storiografica di una storica decisamente di sinistra come Luisa Mangoni che proprio sulla rimozione di quella semplificazione ha lavorato a lungo, a partire dal suo L’interventismo della cultura (che Laterza pubblica nel 1974) e che apre una polemica con Bobbio, senza aspettare Augusto Del Noce (il suo Suicidio della rivoluzione è del 1978). Nello stesso senso si potrebbero ricordare le ricerche di quegli stessi anni di Mario Isnenghi su Renato Serra (la raccolta Scritti letterari, morali e politici di Renato Serra, che Isnenghi cura, è pubblicata da Einaudi nel 1974).
La seconda questione riguarda il fascino per il populismo che costituisce un aspetto culturale non marginale operante lungo tutto l’arco politico (non solo a sinistra o a destra, ma includendovi anche il centro). Su questo aspetto insistevano alcune recensioni all’uscita della prima edizione del libro, nel 1961, che credo sarebbe stato opportuno e utile considerare con attenzione e non solo nominare o proporre attraverso alcune lettere proposte in appendice al saggio di Giunta. Questo perché nella ricezione del 1961 del libro di Paolo Vita-Finzi ci sono aspetti, temi e sensibilità che sarebbe sbagliato non riprendere in mano oggi.
Intendo prima di tutto le considerazioni che propone nella sua recensione Delio Cantimori, dove il problema è la natura profonda della crisi di progetto dell’Italia unita già a partire dalla fine del XIX secolo. L’evento scatenante è la ricezione nell’opinione pubblica della sconfitta di Adua, che induce a sollecitare una nuova piattaforma ideologica e mitogenica dell’idea di nazione e di missione italiana o di «scopo di generazione», su cui già nel 1897 insiste un intellettuale come Mario Morasso e più in generale una rivista come “Il Marzocco” (1896-1932).
Poi la lunga recensione che Palmiro Togliatti dedica al libro di Vita-Finzi sulle pagine di “Rinascita” nel giugno 1961 (il testo è leggibile ora qui alle pp. 2260-2266), e in cui appunto si sofferma sulla crisi politica e culturale dell’inizio del ’900, già con D’Annunzio, ma soprattutto sul distacco tra cultura e vita reale, su un anticlericalismo che si trasforma in ideologia della superiorità e trascura le componenti essenziali di una sensibilità popolare (di una «pietà», avrebbe detto Don Giuseppe De Luca, a cui Togliatti guardava con attenzione da molto tempo).
Infine, le considerazioni appena accennate ma molto profonde di Nicola Chiaromonte. La recensione esce sul mensile “Tempo Presente” nell’agosto 1961 e s’intitola I precursori del fascismo: nel testo Chiaromonte non risparmia nessuno, né Croce, né gli intellettuali, né il senso comune dell’opinione pubblica.
L’effetto di questa scelta di lettura che non si confronta con quelle osservazioni, ma si limita a nominarle, fa sì che non emerga una storia, bensì una visione metafisica. L’effetto è una proposta interpretativa a un tempo senza storia e valida per sempre.
Per uscire da questo paradigma, al di là del percorso di irriverenza (per esempio il libro di Luca Mastrantonio, Intellettuali del piffero, Marsilio), che comunque non è mai un profilo fuori luogo ed è utile per non sacralizzare l’oggetto di indagine), non sarebbe stato inutile riprendere in mano e discutere poche pagine che Nadia Urbinati scrive nel 2015 sugli intellettuali (quel saggio è leggibile anche qui).
In quel testo, Urbinati fornisce un quadro concettuale del rapporto tra intellettuali e politica, dall’Unità d’Italia a oggi in relazione a funzioni, ruoli, aspirazioni. Quel dato rappresenta uno degli aspetti della crisi sia dell’intellettualità sia della politica alla data di oggi. È significativo il fatto che proprio su questo aspetto Giorgio Caravale opportunamente inviti a riflettere nel suo Senza intellettuali, Laterza, o che nel gennaio 2022 sia stato il trimestrale “il Mulino”, con un numero monografico dal titolo La vocazione intellettuale, a proporre il tema del profilo degli intellettuali nonché a porre l’urgenza del ritorno sulla scena pubblica di una nuova figura di pensatore non autoreferenziale.
Per questo la nuova edizione di Le delusioni della libertà, non per responsabilità di Paolo Vita-Finzi, mi sembra sia un’occasione mancata, perché eccessivamente autocompiaciuta, se non autoriferita. Da questo lato, l’effetto è l’esatto opposto del vizio che si propone di denunciare.