Rachael Cusk, il lavoro di una vita / Voci sulla maternità
Nel 1972, quando Adrienne Rich iniziò a scrivere Nato di donna, che sarebbe uscito nel ’76 (in Italia per Garzanti, tradotto da Maria Teresa Marenco), sulla maternità non era stato scritto quasi nulla; o meglio, sulla maternità dal punto di vista delle madri, e con le madri che dicono “io”, perché i libri sulle madri scritti dai figli esistevano già, così come i romanzi che in punta di piedi osavano gettare un’ombra sull’idillio materno (penso a La casa della gioia di Wharton, o a Il risveglio di Chopin). Rich sceglie di scrivere di maternità unendo la scrittura saggistica a quella autobiografica, la teoria all’esperienza: non avrei potuto fare altrimenti, dirà poi, perché il personale è politico. E soprattutto perché esiste una differenza tra il raccontare individualistico, fine a se stesso, e il raccontare per altri – altre, anzi. Per molti anni la nozione che la storia, la cultura, la società hanno cercato di instillare nelle donne è stato il senso dei propri limiti: Rich si rende conto, perciò, che la cosa più importante che una donna possa fare per un’altra donna è illuminare ed espandere la cognizione delle proprie possibilità.
La maternità, intesa sia come istituzione che come modo d’essere, ha una storia, porta con sé un’ideologia: è stata, a volte è ancora, una funzione sociale, prima che politica, è stata l’incudine su cui si è forgiata la disparità tra i sessi. Al contempo, il rafforzamento della maternità come istituzione è andato di pari passo con la crescente polarizzazione tra madri e non-madri, interiorizzata dalle donne stesse: essere o non essere, essere una madre, quindi meno importante dei propri figli, o essere una non-madre, quindi meno importante di una madre? Tentare di superare questa dicotomia ha voluto dire, per molte donne, insistere sul loro essere in primis “esseri umani”, e solo in un secondo momento, quasi accidentalmente, donne: hanno smesso di rivendicare i loro legami con altre donne, di rivendicare il proprio corpo di donna, per dipingersi come delle specie di entità disincarnate. Rich, quando scrive Nato di donna, ma anche Cusk, quando scrive Il lavoro di una vita (Einaudi, traduzione di Anna Nadotti), che con Rich dialoga e a Rich si ispira, supera questa frattura tra mente e corpo: ciò che colpisce, o quantomeno ciò che ha colpito me, è l’attenzione alla corporeità, al modo in cui i corpi cambiano, dialogano, si contengono ed entrano in relazione.
Cusk, come Rich, parla soprattutto di ambivalenza: l’ambivalenza intrinseca all’essere madre e al contempo figlia, sé e altra da sé, l’ambivalenza tra il passato e il presente, ma soprattutto l’ambivalenza verso i propri figli: l’amore materno, questo idillio che ha ispirato generazioni di artisti, non è sempre amore. A volte è rabbia, a volte è frustrazione, a volte è proprio odio. Rich lo aveva detto, quasi trent’anni prima, ma inserendosi in un periodo diverso – quello delle battaglie per l’aborto, ad esempio– e soprattutto in un movimento politico – il femminismo degli anni Sessanta e Settanta. Cusk dice le stesse cose, ma senza lo scudo del periodo, né del movimento: da qui, la valanga di attacchi – soprattutto da donne, peraltro, - che la travolgono dopo la pubblicazione. Cusk, come aveva fatto Rich, sembra aver detto l’indicibile: infrange un segreto, rompe il patto di silenzio che garantiva la continuità della specie. Cusk parla delle difficoltà, dei pianti delle madri e di quelli dei figli, parla del complicato arruolamento nel ruolo dell’ortodossia genitoriale, smette di chiedersi cos’è una donna se non è una madre, e inizia a chiedersi cos’è una donna se è una madre.
Si risponde che essere madre significa soprattutto esserci: è la sola cosa che le viene richiesta, che naturalmente vuol dire tutte le cose, perché esserci costantemente per un altro significa non esserci mai, o quasi mai, per sé. Cusk scrive della sua esperienza e nel farlo cerca di colmare la solitudine psichica delle madri. E tuttavia c’è un altro tipo di solitudine psichica, che è quello delle non-madri, e che è solitudine linguistica prima che spirituale, psichica, sociale. Come si chiama una non-madre, senza ricorrere al negativo? Cos’è ciò che non è? Se lo chiede Sheila Heti, in Maternità (Sellerio, traduzione di Martina Testa), un libro che lei usa come una specie di profilattico esistenziale: impiega sette anni a scriverlo, i sette anni in cui si interroga se essere madre o meno, e quando finisce il libro ormai è troppo tardi per essere madre. Il dubbio è sciolto, perché non sussiste più: la sua età fertile è finita perché lei l’ha fatta finire, come una Sherazade che racconta per far sì che il tempo passi, invece che per passare il tempo. La narratrice di Maternità è tendenzialmente inquisitoria, sempre dubbiosa: ricorre spesso all’I Ching, un antico sistema cinese di divinazione basato su tre monete.
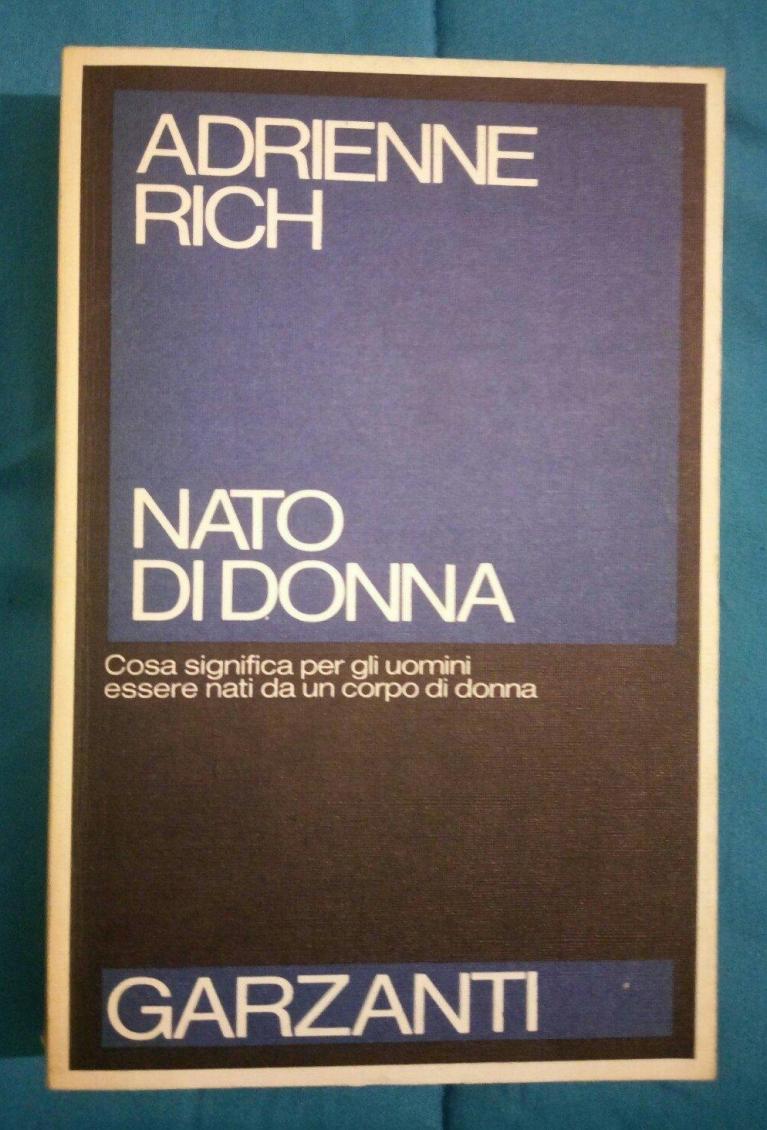
La narratrice pone una domanda – a cui si può rispondere solo sì o no, – poi lancia le tre monete: due o tre teste significano sì, due o tre croci, no. Cerca risposte, soprattutto cerca la risposta – se avrà un bambino oppure no, che è «il più grande segreto che nasconde a se stessa». Intanto riflette, su di sé e su come la società vede, guarda, etichetta le donne come lei, che decidono di non avere figli: il non essere madre richiede sempre una specie di coming-out, in assenza del quale ci si aspetta che la donna abbia dei figli, che desideri averne, che stia aspettando il momento per. In sostanza, che la sua vita sia in stand-by, nell’attesa dell’evento che renderà quella vita e quella donna degne di essere chiamate tali. Se questa aspettativa viene delusa, ecco che subito ne subentra un’altra: se sei una donna, e nonostante questo non vuoi dei figli, avrai almeno un qualche progetto, una grande impresa, una carriera irrinunciabile a cui dedicarti. No? Il mondo sembra dividersi tra madri e non-madri, come in una guerra civile, e Heti supera questa divisione, perché la sua narratrice non sa cosa, chi vuole essere: non ne ha idea, è piena di dubbi, soprattutto perché è una donna, e dunque attraversa le varie fasi del ciclo mestruale, che, da un certo punto in poi, danno il nome ai capitoli di Maternità: così, durante Sanguinare e Follicolare, sembra sempre più convinta che di figli non vuole sentir parlare, ma poi arriva Ovulazione, e allora forse sì, forse li vuole, dei figli.
Heti riporta l’ambivalenza, come Rich e Cusk, ma la estende anche alle non-madri: supera la divisione tra donna-madre e donna-non-madre, scrive un libro che alla fine è come un figlio: «mia cugina ha sei figli. E io ho sei libri. Forse non c’è tutta questa differenza fra noi, solo una leggera differenza nelle cose in cui crediamo – nelle parti di noi che ci sentiamo chiamate a espandere».
«Tutto questo» – e qui la parola passa a Nettel e alla sua Figlia Unica (La Nuova Frontiera, traduzione di Federica Niola) – «per dirti quanto è sempre stata permeabile la maternità». Nettel scrive da un paese, il Messico, in cui si contano in media dieci femminicidi al giorno, e in cui la legge sull’aborto è a dir poco restrittiva. Eppure, o forse proprio per questo, Nettel parla di donne, di madri, e di come l’esserci di cui parla Cusk possa essere rivolto anche a qualcuno che non sia un figlio, o a qualcosa che non sia una persona: Laura, la narratrice della Figlia unica per anni ha cercato di convincere le sue amiche a non avere figli per non limitare la propria libertà. A un tratto, però, la sua esistenza comincia a essere costellata di madri e di figli, umani e animali: Alina, la sua migliore amica, inizialmente sua complice nello schieramento delle non-madri, inizia un trattamento per riuscire a rimanere incinta; sul suo pianerottolo arrivano due nuovi vicini, Doris e Nicolas, madre e figlio; e infine, sul suo balcone, a un certo punto arrivano a nidificare due piccioni, che covano con devozione il loro uovo.
Nel frattempo, Laura sta scrivendo la sua tesi. Presto, però, questa costellazione materna inizia a incrinarsi: Alina scopre che la figlia che porta in grembo è affetta da microlissencefalia, una malformazione genetica che ne determinerà la morte immediatamente dopo la nascita; i suoi vicini hanno un rapporto difficile, Doris è depressa e fatica a prendersi cura del figlio Nicolas, è sopraffatta, gli urla spesso, e il bambino le urla di rimando, le risponde male, non si sopportano più; e persino i due piccioni danno alla luce uno strano uccello, diverso da loro, di cui però continuano a prendersi cura. Laura continua a scrivere la tesi. Ma al contempo rimane vicina ad Alina, nelle difficili settimane dopo la diagnosi, e persino in quelle, ancor più difficili, dopo la nascita, perché la figlia di Alina in realtà non muore: vive, e richiede una quantità di cure e di attenzioni inimmaginabili e inimmaginate. Poi Laura inizia a prendersi cura di Nicolas: lo ospita a casa, lo accompagna a scuola, lo porta al parco. E continua a scrivere la sua tesi. «Tutto questo per dirti quanto è sempre stata permeabile la maternità», appunto. Nettel ci fa capire che la cura ha varie forme, e che la maternità è solo una di queste. Si può essere madri – se proprio madri dobbiamo chiamarci – anche prendendosi cura dei figli di altri, o delle altre madri, o della propria madre, o delle tesi di dottorato, perché l’amare col cuore non esclude l’amare con la testa, e viceversa. Lo sanno, d’istinto, i piccioni sul balcone, che si prendono cura di un uovo che in realtà non è loro: è di un cuculo, anzi di una cucula, che quel figlio proprio non voleva crescerlo – egoista, alcuni, alcune, etichetterebbero la cucula, come hanno etichettato Cusk, – e così ha lasciato che altri se ne prendessero cura.
In questi ultimi anni si sono susseguiti molti libri sulla maternità: sul desiderio di essere madri, l’ambivalenza, la difficoltà di essere madri, l’odio e la gioia e il rimpianto per avere avuto figli o non averne avuti o essersi prese cura di altre persone o cose come fossero figli. E a me sembra che quando questi libri vengono scritti per l’Altro, l’Altra, e non per sé, allora assolvono a una funzione sociale, politica, collettiva. Rafforzano i legami, rafforzano il senso di comunità. Cosa vogliamo l’una dall’altra / dopo aver raccontato le nostre storie /forse vogliamo /essere guarite forse vogliamo / quiete di muschio adagiata sulle nostre cicatrici / forse vogliamo / l’onnipotente impavida sorella / che farà scomparire il dolore / mutare il passato (Audre Lorde).
Leggi anche
Marilna Renda, Resoconto









