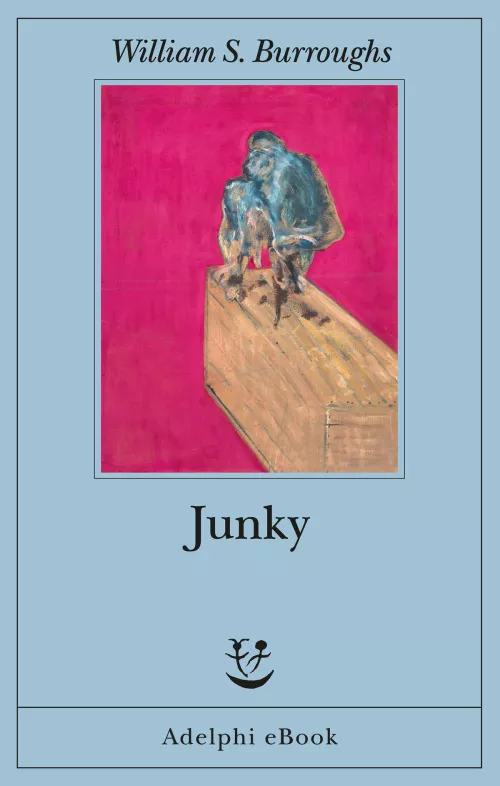W.S. Burroughs: confessioni di un tossicodipendente irredento
Per chi è stato giovane negli anni '70 William Burroughs era una figura leggendaria. La beat generation – di cui parlò per prima Fernanda Pivano in un articolo su Aut aut del 1959 – era la scoperta dell'America, per chi la poteva sognare solo attraverso i film, la musica e le pagine dei libri, nello stesso modo in cui generazioni precedenti l'avevano immaginata attraverso Herman Melville, Sinclair Lewis, Sherwood Anderson tradotti da Cesare Pavese. "Che gioia, nel silenzio della notte, che felicità tuffarsi voracemente in un Burroughs come a vent'anni" scriveva nel 1987 Pier Vittorio Tondelli. Chi tornava da New York raccontava delle poetry in performance, nelle cantine del Village, dove si potevano ascoltare dal vivo Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti; Jack Kerouac se n'era andato nel 1969, tenendo acceso il mito, alimentandolo, come sempre fa chi muore troppo presto. Che trip, avremmo detto allora, immergersi oggi nella riedizione di Junky – Confessioni di un tossicodipendente irredento (Adelphi, a cura di Oliver Harris, traduzione di Andrew Tanzi), uscito in America nel 1953 grazie a Allen Ginsberg, improvvisatosi agente letterario di Burroughs e a cui si deve la pubblicazione di questo suo primo libro; poi riproposto in edizione integrale, nel 1977, con una introduzione dello stesso Ginsberg e infine nel 2003 da Oliver Harris.
In Italia uscì nel 1962 da Rizzoli, con una introduzione di Fernanda Pivano. Cosa resta di tutta quella passione che abbiamo provato da giovani per questi dropout che in Junky sembrano gli hobo fotografati da Lee Jeffries (1971), visibili in questi giorni nella mostra allestita al Museo Diocesano a Milano? Hipster, spacciatori, homeless, drogati, ubriachi girano a vuoto nel reticolo di street e di avenue di New York, che somigliano alle corone circolari concentriche dei gironi nella Divina Commedia: è Ginsberg che la cita a proposito di Junky, nell'intuizione che la vita ipnotica raccontata da Burroughs alluda all'immensa voragine dell'inferno dantesco. Lou Reed aveva letto Burroughs quando, nel 1967, scrisse Heroine: "Perché quando il sangue prende a scorrere / davvero non m'importa più / Oh, quando l'eroina è nel mio sangue / e il sangue nella mia testa / e allora grazie Dio di star bene come nella morte". "Se Dio ha creato qualcosa di meglio se lo è tenuto per sé" risponde il protagonista di Junky a un amico che gli chiedeva se la dose di eroina che si era appena fatto gli era piaciuta.
Burroughs sostiene, in una delle appendici che corredano questa edizione, che di droga non si muore perché è quando "si smette di crescere" che "si inizia a morire" e "un tossico non smette mai di crescere" (l'elenco dei morti invece è lungo e Burroughs, che scompare nel 1997 a ottantatré anni, si vede sopravvivere a molti artisti, scrittori, musicisti, tutti più giovani di lui, vittime delle droghe e dell'Aids). Junky è la storia della dipendenza di Burroughs dalla morfina, dall'eroina, dalla cocaina, dall'oppio, dall'alcol, dal metadone, dal peyote, e da altre miscele strane che si inietta e beve; un'autofiction che lo vede rapinatore, spacciatore, marito e padre casuale, omosessuale, combattuto tra lo smettere e il ricadere. Ma, come avverte Ginsberg, è improprio chiamarla autobiografia, perché Junky tratta di un solo aspetto della vita dell'autore, "anche se sono presenti molti dettagli personali legati al tema principale", "e non può essere presa come descrizione dell'uomo nel suo complesso".
Burroughs sembra più che altro impegnato a smarcarsi dal conformismo borghese della sua famiglia d'origine, ripiegato su se stesso, come lo erano i suoi compagni della beat generation con le loro rivoluzioni incruente, le ingenue utopie che facevano presa sulle generazioni dei giovani europei cresciuti col mito dell'America, e dei movimenti di controcultura che mostravano le contraddizioni di quel sogno, tra guerra e pacifismo, rivoluzione sessuale e diritti delle donne, sfida aperta all'ordine costituito e all'autorità con l'assunzione provocatoriamente pubblica di sostanze stupefacenti. In Junky Burroughs si abbandona a quello che lui chiama "fattualismo", una sorta di realismo documentario che è, nello stesso tempo, denuncia sociale e introspezione intima: un post-positivismo contro il dogma delle teorie assolute e certe, sempre confutabili dall'esperienza.
Mentre scrive è affascinato dalla teoria dell'orgone di Wilhelm Reich (1897-1957) di cui legge La biopatia del cancro: secondo questo studio è la "vita carica", la presunta energia vitale e sessuale di cui sarebbe pervaso l'universo a far ottenere risultati clinici sorprendenti perfino nella cura dei tumori; vede il film Cocaina di William Castle con Shelley Winters (1949), che esce quattro anni prima della pubblicazione di Junky, con quella frase che lo scandalizza: "I tossicodipendenti si strappano di dosso i vestiti rivelando corpi scarni e muoiono mentre urlano". Allo psichiatra che gli pone la domanda ottusa: "Perché sente di aver bisogno dei narcotici?" risponde "Perché mi serve per alzarmi dal letto al mattino, per radermi e fare colazione".
I dottori vedono soprattutto la questione morale: "Quest'uomo avrebbe dovuto pensare alle conseguenze prima di incominciare a far uso di narcotici" senza considerare quella fisica: "Quest'uomo è in crisi di astinenza!". L'humor di Burroughs si scatena poi in una pagina dove dialoga con una delle "personalità integre" che capita ogni tanto di incontrare in un bar: "Lo sai, vero, che i narcotici sono legati a doppio filo con il comunismo?". "Se hai bisogno mi trovi qui" disse quando mi alzai per andarmene". In questo libro-cancro, spaventosamente ripetitivo, Burroughs affonda masochisticamente nelle categorie del drogato, del ladro, del "maledetto" ma anche dell'individuo libero e lucido, dell'intellettuale che ha letto Cocteau e Baudelaire e si ingegna a somigliare a Genet. Junky è un libro colmo di verità sul linguaggio e le scelte morali, totalmente immune da qualsiasi forma di autodifesa psicologica, riscattato da un'autonomia estetica rivoluzionaria per gli anni in cui è stato scritto.
Dice Harris nella sua introduzione: "Se cercate testi sulla tossicodipendenza, ormai avete solo l'imbarazzo della scelta. Ci sono storie sociali, polemiche sulla sanità pubblica nonché critiche di stampo politico sulla lotta agli stupefacenti; studi culturali e analisi etiche; perizie sulla legislazione in materia, trattati sulla psicologia del tossico, prontuari farmacologici e terapeutici; memorie personali, romanzetti spazzatura e classici letterari; il tossico è un'icona moderna e l'eroina ormai può vantare una storia, una mitologia e una chimica tutte sue".
Questa nuova edizione Adelphi fornisce anche un motivo per sorridere sulla moda del politically correct, che censura nelle opere letterarie termini che potrebbero offendere alcune categorie di persone: qui sarebbe impossibile cancellare le parole "drogato", "tossico", "finocchio", "ubriaco" che ricorrono quasi in ogni pagina, senza depotenziare la carica eversiva del romanzo, che resiste ancora oggi, nella modernità di uno stile che anticipa il new journalism e trasfigura il gergo del mondo dei drogati in una prova letteraria di spessore, allegorica e profonda.