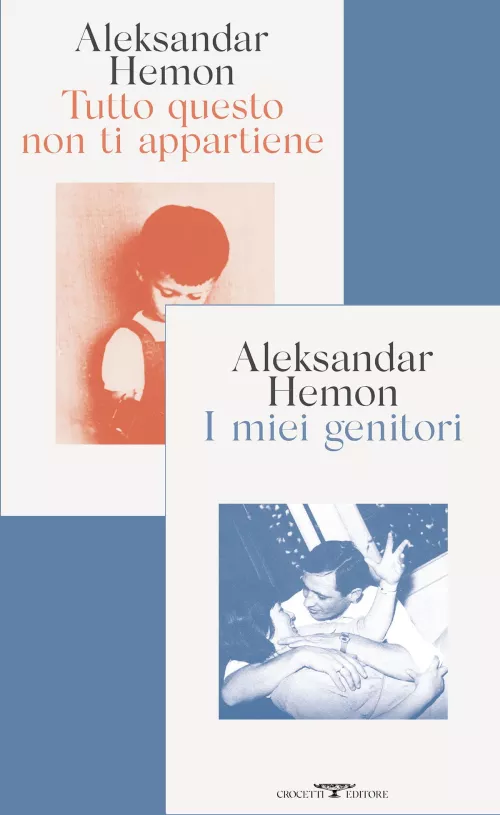Aleksandar Hemon: ricordare è rielaborare
“Scrivo narrativa perché non posso farne a meno”. Aleksandar Hemon crede davvero che il raccontare storie lo abbia salvato dal ritrovarsi inchiodato al ruolo eterno di “nowhere man”. Un uomo di nessun luogo. Uno sradicato dalla propria terra, incapace di costruire un’identità nuova che possa riconoscere e tenere conto, al tempo stesso, di quella vecchia.
Fin dagli esordi letterari con Spie di Dio (Einaudi, 2000) e Nowhere man (Einaudi, 2004), lo scrittore di Sarajevo, che vive a Chicago, non ha mai smesso di rimodellare in forma di romanzo il suo essere stato sbalzato fuori, all’improvviso, dalla natia città multietnica. Aggredita dalle milizie serbo-bosniache nel più lungo e feroce assedio bellico del Ventesimo secolo. Durato poco meno di quattro anni: dal 5 aprile 1992 al 29 febbraio del 1996.
Aveva 26 anni, Aleksandr Hemon, quando salì a bordo di un aereo: era il 24 gennaio 1992. Il suo viaggio di studio negli Stati Uniti sarebbe dovuto durare non più di qualche mese. Di lì a poco, lo raggiunse a Chicago un messaggio dei genitori. Diceva: “Non tornare a Sarajevo. Hanno già chiuso l’aeroporto”. L’attacco frontale delle truppe serbe voleva impedire alla Bosnia-Erzegovina di attuare l’annunciata scissione dall’ormai agonizzante Jugoslavia. Per la città era iniziato un calvario infinito, che avrebbe lasciato dietro a sé dodicimila morti e oltre cinquantamila feriti. Per la stragrande maggioranza civili.
Il 25 agosto del 1992, una serie di granate sparate dai serbo-bosniaci fece divampare il rogo nella Vijećnica, la Biblioteca nazionale di Bosnia-Erzegovina. Il 90 per cento dei 155mila volumi rari e manoscritti finì in cenere. A nulla valsero i tentativi della bibliotecaria Aida Buturović di provare a mettere in salvo alcuni libri: perse la vita a 32 anni.
Da allora, Hemon ha compiuto un percorso letterario di valore assoluto. Si è convinto a scrivere i suoi libri, i racconti pubblicati su prestigiose riviste come “The New Yorker”, “Granta”, “Esquire”, direttamente nella lingua del Paese che lo stava ospitando: gli Stati Uniti. Ha superato insomma, appena tre anni dopo il suo arrivo a Chicago, l’abisso che separava le parole imparate quand’era bambino da quelle prese a prestito nel nuovo mondo.
Subito, affermati autori come Colum McCann, Jonathan Safran Foer, Cathleen Schine, si sono accorti dei suoi libri. Del fatto che era sbarcato in America un autentico fuoriclasse della letteratura.
La conferma del valore di Hemon è arrivata nel 2008. Quando lo scrittore di Sarajevo ha terminato “The Lazarus project”, tradotto in italiano da Maurizia Balmelli e pubblicato da Einaudi due anni più tardi con il titolo Il progetto Lazarus. Romanzo entrato tra i finalisti al National Book Award e premiato a Firenze nel 2011 con il Von Rezzori. Un viaggio letterario nella memoria perduta, che ricostruisce la breve vita e la morte violenta del diciannovenne ebreo Lazarus Averbuch. Uno dei tanti, anonimi immigrati in America. Sopravvissuto ai pogrom contro gli ebrei dell’Europa orientale, ma ammazzato a rivoltellate sulla porta di casa del capo della polizia di Chicago. Soltanto perché “aveva la fisionomia straniera”. E rischiava di rivelarsi un anarchico sanguinario, un italiano testacalda. Come Mario Buda, che anni dopo avrebbe seminato il terrore a New York imbottendo di esplosivo, e migliaia di chiodi, un carro tirato da un cavallo. Conquistandosi il tenebroso primato di inventore dell’autobomba.
Nella storia di Lazarus, Hemon rivedeva il destino di tutti i “nowhere man”. E per realizzare il progetto del suo libro era riuscito ad assicurarsi un finanziamento da una fondazione americana. Disposta a pagare il suo viaggio in Europa alla ricerca delle radici di Averbuch. Solo quando l’intera vicenda gli era sembrata ben definita, aveva deciso di entrare lui stesso in gioco. Celandosi dietro il personaggio dell’aspirante scrittore Vladimir Brik. Uno sradicato da Sarajevo che, nel libro, confessa: “Penso in inglese, ma penso anche in bosniaco; e spesso non penso affatto”. E se deve definire la propria identità ammette: “Non sono ebreo, nemmeno musulmano, serbo o croato. Sono complicato”.
Parole, modi di dire legati a ricordi precisi. E, poi, riversati nell’incessante interrogarsi per mettere a fuoco il rovello che segue Aleksandar Hemon fin dal 1992: chi sono io, veramente? Perché c’è un momento preciso in cui il mondo “di prima”, quello che Predrag Matvejevic chiamava “mondo ex”, è diventato irrimediabilmente prigioniero della memoria. Un pallido riflesso difficile da ancorare al mondo “di adesso”. Come lo scrittore aveva già fatto in Il libro delle mie vite (tradotto da Maurizia Balmelli per Einaudi nel 2013). E come fa di nuovo nel doppio romanzo autobiografico I miei genitori e Tutto questo non ti appartiene. Tradotti da Gianni Pannofino e raccolti in un unico volume pubblicato da Crocetti Editore (pagg. 400, euro 20) nella bella collana Mediterranea diretta da Federica Manzon.
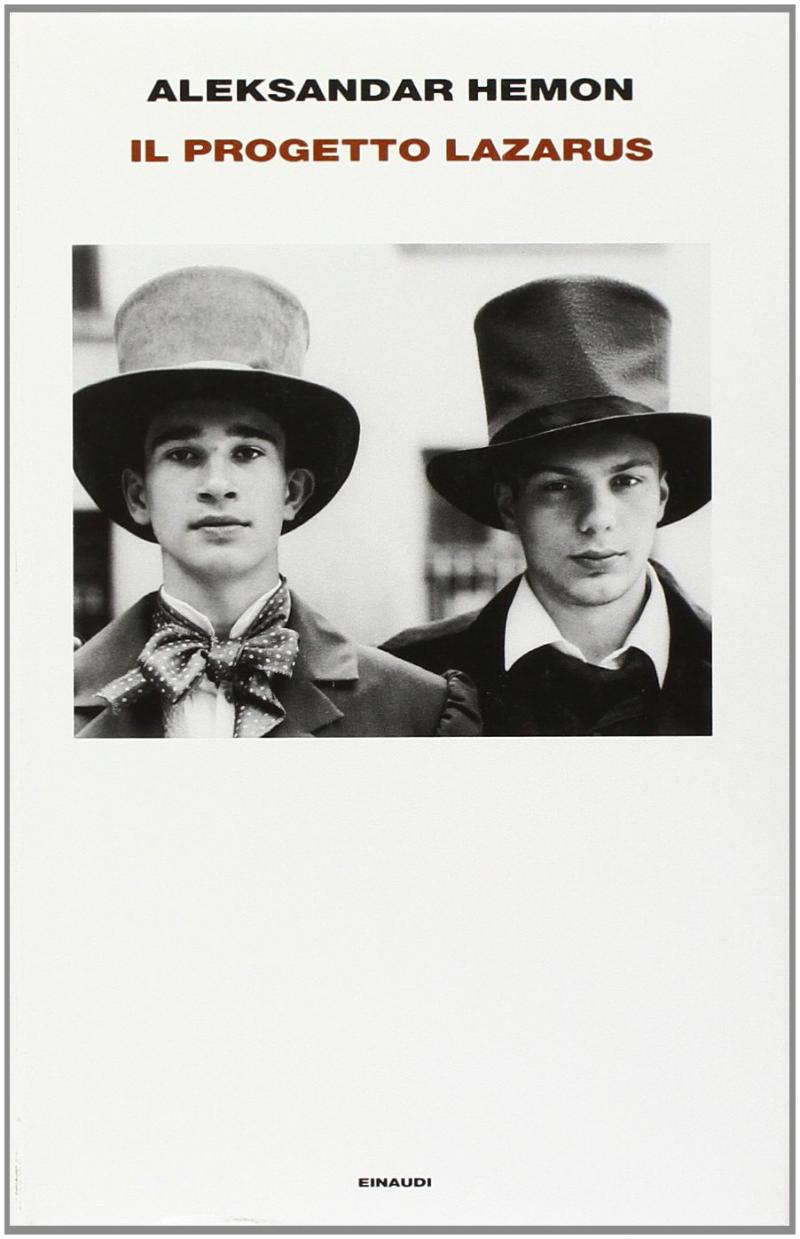
Hemon, che adesso insegna scrittura creativa all’Università di Princeton e ha collaborato alla sceneggiatura del nuovo capitolo della saga cinematografica “Matrix”, non ha mai fatto mistero di non amare il sentimento della nostalgia: “Il presente mi tiene troppo occupato”, è solito ripetere. Eppure, il rimpianto del passato gli appare, senza dubbio, come la soluzione narrativa più affascinante. “La considero una forma di utopia retroattiva, un metodo psicologico con il quale molte persone affrontano i traumi costruendosi un passato ideale, del tutto privo di dolore e sofferenza”.
Senza mai proporsi come viatico consolatorio, in I miei genitori la nostalgia diventa macchina narrativa. Assume la forza di un potente generatore di storie, che si concatenano ad altre storie. E tessono la trama di un ritratto generazionale enorme, capace di andare a ripescare le radici della famiglia paterna in Galizia, l’attuale Ucraina occidentale.
Nelle vite di mamma e papà, Hemon ritrova il sogno di una Jugoslavia in cui ognuno aveva il proprio ruolo. Anche se, poi, gli stessi uomini e donne pronti a credere nel modello politico e sociale di Tito, dopo avere perduto tutto, la casa, gli amici, la propria terra, le illusioni legate a un socialismo diverso da quello sovietico, hanno dovuto ammettere che si trattava di un gigantesco abbaglio.
“Sono stata fregata da tutti, dice mia madre. O anche: sono sempre stata una vittima”, è il commento di Hemon in I miei genitori.
Narrare, annota lo scrittore, “non è tanto riferire; anzi, è l’opposto: consiste nel re-immaginare eventi accaduti in un diverso ambito della realtà vissuta o nel passato”. Così, nel racconto di Hemon, la ricerca del tempo perduto dei suoi genitori diventa, pagina dopo pagina, il tempo ritrovato di due personaggi che abitano le pagine del libro. Con una forza e una libertà che solo la letteratura può concedere loro. Anche perché nel testo inglese originale, e poi in quello tradotto in italiano, molte parole hanno la loro interfaccia nella lingua della terra perduta. Di quella Bosnia-Erzegovina dove il serbo e il croato formavano un unico impasto linguistico bifronte. Arricchito da espressioni di derivazione araba, visto che una parte della popolazione è di fede musulmana.
La nostalgia non prende forma soltanto nel racconto del primo incontro dei suoi genitori. Nella loro storia d’amore, nelle feste che li vedevano cantare e ballare insieme, poi nella nascita dei figli. Mette radici anche nei ricordi che ripropongono il coraggio di costruire, con infinita pazienza e tanti sacrifici, una vita dignitosa in un Paese diventato leader mondiale del blocco dei Non Allineati: né con gli Usa né con l’Urss. E che aveva preso forma, dopo il bagno di sangue della Seconda guerra mondiale, su basi indubbiamente autoritarie. Disposto a mettere in atto una feroce repressione di chi non si piegava ai dettami del Partito. Basterebbe ricordare, a questo proposito, l’infernale gulag dell’isola di Goli Otok, dove venivano condannati ai lavori forzati soprattutto i comunisti che credevano più al verbo di Stalin e del Pcus che a Tito.
Eppure, quello era anche il tempo della giovinezza dei genitori di Hemon. Mesi, anni, trascorsi a credere che la Jugoslavia potesse diventare un’alternativa luminosa all’oscura partita a scacchi della Guerra fredda. Soprattutto perché era un Paese socialista governato basandosi sulla dottrina della fratellanza e dell’unità. E cercava di creare un‘identità civile che andasse oltre l’appartenenza etnica come elemento identificativo primario.
Alla fine, la mancanza di una classe politica capace di sostituire Tito, e gli stessi errori dell’indiscutibile leader balcanico, prima ancora dei tamburi di una guerra basata proprio sulla divisione etnica e le rivendicazioni nazionaliste dei vari Stati, hanno costretto molte persone ad aprire gli occhi. A sconfessare il sogno, per ricostruire in un’altra parte del mondo il proprio centro di gravità. Scrive Hemon: “La casa, il fienile, il giardino sul retro sono i luoghi in cui i miei genitori non sono profughi. Il tempo non lo si recupera, ma lo spazio sì, e così hanno fatto”.
Essere profughi, per i genitori di Hemon, significa aver saputo ricostruire in Canada le coordinate del proprio mondo. Per il padre, occuparsi delle api come faceva a Sarajevo. Tenersi costantemente impegnato in mille lavoretti in casa. Cantare le canzoni della tradizione musicale ucraina, della sua Galizia, per non dimenticare mai l’origine della propria famiglia. Per la madre, replicare quello schema della tradizione contadina che la Jugoslavia, “socialista e sedicente moderna”, non ha mai saputo o voluto archiviare. “Quando le donne lavoravano in casa – scrive Hemon – cucinavano, badavano ai bambini, mentre gli uomini, aiutati dalle donne e dai figli, sgobbavano nei campi, occupandosi del bestiame, dei raccolti, di distillare e bere alcol”.
E, allora, anche il cibo diventa uno strumento per rivendicare la propria identità, per ritrovare il tempo perduto. “Quello che mangiano, se in Bosnia era tipico, parte rilevante dell’esperienza condivisa, in Canada li fa sembrare diversi, esotici. La loro filosofia alimentare non è più ciò che li collega al loro ambiente, bensì un fattore che li distingue. Si preparano il loro cibo, ma finiscono inevitabilmente per provare il gusto dell’esilio”.
Se il padre appare agli occhi di Hemon “un personaggio delle sue storie”, e la madre “è nella mia testa come codice etico, come sistema linguistico e come perpetua fonte di affetto”, è impossibile non completare un ritratto così intimo senza riservare a se stesso pagine di straordinaria intensità. Venate non tanto dal desiderio di costruire un piedistallo per l’uomo Aleksandar Hemon, o per lo scrittore. Ma distillate con felicità e malinconia per raccontare l’evoluzione di quello che rischiava di diventare uno dei tanti “nowhere man”. Dal momento che “se io ricordo, non solo so di aver vissuto, ma anche di essere vivo. La morte si verifica quando non si è in grado di ricordare il momento presente”.
Così, rovesciando il libro, comincia un altro viaggio. E lo scrittore può ripercorrere i propri passi perduti in Tutto questo non ti appartiene. Dove la voce narrante va a recuperare nello scorrere del tempo l’infanzia e i ricordi di famiglia, l’adolescenza, la giovinezza tra musica rock, intense amicizie, primi amori scordati in fretta e diventati poi indimenticabili. Giorni, insomma, in cui la guerra non aveva ancora cancellato l’attesa del domani. Perché “quando eravamo ragazzini, il futuro era sempre in arrivo e le sue correnti vibravano in anticipo dentro quello che sapevamo o che ci interessava sapere”.
Hemon sa modellare i ricordi senza mai essere stucchevole, piagnucoloso, prevedibile o retorico. Anzi, strappa risate a pagine aperte quando racconta il desiderio di dare vita a una rock band che avesse l’energia dei Clash e il carisma dei Pink Floyd. Ma che poi, una volta reperiti gli strumenti e un posto dove suonare, imbracciate le chitarre made in Germania Est, si era trovata faccia a faccia con la drammatica constatazione che non c’era una sola sequenza di note dentro la testa degli aspiranti divi da palcoscenico. “Non ci venne in mente nessuna musica da scrivere. Niente da suonare, niente da dire, privi persino dei mezzi per dirlo, armati soltanto dal desiderio di creare qualcosa: nessun sentiero, nessuno che cammini, nessuna camminata”.
Ma, in fondo, che vergogna c’è a confessare che “io volevo essere come Jerry Lewis, l’uomo che non è mai diventato adulto. Volevo cercare dei modi di essere che non comportassero vergogna, solo un corpo che si voleva bene, intoccabile”? Ci ha pensato la guerra, poi, a cancellare quelle illusioni di libertà e di perfetta normalità. A seminare diffidenza, odio, rancore e un senso infinito di spaesamento. A rendere i ricordi una zattera, seppur fragile, a cui aggrapparsi per non lasciare che il tempo scappi via senza farsi mai raggiungere.
È stato Vladimir Nabokov, autore tra l’altro dello splendido Parla, ricordo (tradotto nel 2010 da Anna Raffetto per Adelphi) dedicato alla sua fanciullezza nella “Russia leggendaria”, a scrivere che “il dettaglio è sempre benvenuto”. Hemon, da quando ha iniziato il suo percorso letterario, non si stanca di recuperare dalla memoria nuovi frammenti, schegge di vita, particolari che credeva di avere dimenticato. E che, invece, riaffiorano nel fluire della scrittura, per evitargli di trovarsi impantanato nei “racconti di ricordi che forse un tempo erano ricordi di racconti”.