Binswanger: il posto nel mondo
Una mia analizzante mi ripete come un mantra, di seduta in seduta, che non sa qual è il suo posto nel mondo. Un’esperienza comune che ha a che fare con l’orientamento della vita, con l’appartenenza e con il tempo, perché è sempre nella prospettiva biografica, dall’angolo talvolta ottuso della nostra vicenda personale, che questa domanda si pone e si fa stringente: si tratta dunque di una domanda di senso che si organizza nel tempo e nello spazio.
La scorsa volta mi ha raccontato di come rifacendo spazio nella sua fittissima libreria, si fosse imbattuta in due testi, una rivista e un libro, dai quali ha estratto due frasi, una da ciascuno di essi, nelle quali per qualche ora ha dimorato, si è sentita a casa. Ma poi l’aveva assalita una malinconia, per una dimora che ormai non poteva abitare più perché, sentiva, apparteneva ad un tempo animato da figure e scenari, pubblici e privati, che non hanno più luogo e che sembrano evaporati, scomparsi. Di qui il ritorno allo spaesamento, alla domanda, qual è il mio posto nel mondo, nella vita?
Alla dimensione del tempo come irriducibilmente legata alla percezione e alla coscienza che ne abbiamo, filosofia, psicologia, e scienze sociali in generale hanno dedicato molta attenzione rilevandone l’irriducibile portata esistenziale; allo spazio, specie nell’ambito psicologico, è toccata una sorte diversa, quella di godere di minor interesse. Eppure la dimensione spaziale, nell’organizzazione del senso e nelle sue falle, si rivela assolutamente decisiva, secondo Ludwig Binswanger, per orientarsi nella psicopatologia e dunque, come ogni volta, per illuminare l’umana condizione che le psicopatologie spesso, semplicemente, ingigantiscono.
La casa editrice Quodlibet ha da poco dato alle stampe, per la collana Clinica ed esistenza, il saggio del fondatore della psicologia esistenzialista, appunto Binswanger, intitolato Il problema dello spazio in psicopatologia (pp. 270, euro 24) con una breve, ma preziosa, prefazione di Eugenio Borgna e un’accuratissima introduzione del curatore Aurelio Molaro, lunga quasi quanto il testo al quale introduce. Fatto non raro per Binswanger che incontrai per la prima volta, studente universitario, con il libro Sogno e esistenza, (SE, 1993) composto da un’interminabile e acutissima prefazione di Michel Foucault, (70 pagine) lunga esattamente il doppio del testo che commentava. Segno, in entrambi i casi, non solo della densità delle riflessioni di Binswanger ma anche della ricchezza di riferimenti impliciti e meritevoli di amplificazioni della sua scrittura, che viene qui ricondotta anche all’orizzonte di senso delineato da altri suoi contributi alla psicoanalisi esistenziale che, spiega, “non si accontenta di prevedere per il paziente un ritorno alla norma fisiologica, ma si concentra parimenti sulle capacità del malato di trovare una nuova forma di esistenza” (Binswanger, Daseinanalyse e psicoterapia, 1958, p. 34).
Non entrerò nello specifico dei rilievi psicopatologici di questa indagine, benché i casi clinici ai quali si accenna siano particolarmente interessanti, mi limiterò a sottolineare come occorra distinguere diverse concezioni di spazio per poter apprendere a muoversi in esso, ad abitare la domanda di senso che ci anima e talvolta, ci smarrisce, ci disorienta, soffocando il nostro spazio vitale, che allora si appiattisce, si restringe, si fa asfittico, inospitale, desertico, vuoto. La prima questione da sottolineare, quella dalla quale prendere le mosse e alla quale restare ancorati è esistenzialmente legata al riconoscimento che “l’esserci stesso è spaziale”, che l’esistenza s’inscrive in un rapporto originario con lo spazio (nella sua intrinseca correlazione con la temporalità) da cui non può essere dissociata neanche sul piano del pensiero (Molaro, p. 45), perché “un soggetto senza mondo è un’astrazione artificiale priva di realtà” (Binswanger).

È uno dei principali insegnamenti dell’esistenzialismo: non c’è soggetto che non sia in situazione, il che, come osservò Hannah Arendt, riporta il pensiero dal puro pensabile alla realtà, operazione che coinvolge dunque anche lo spazio nel quale ciascuno di noi si muove e che non è certo quello cartesiano della matematica – semmai, sempre più consapevolmente, quello della fisica subatomica – ma non è neanche, semplicemente, uno “spazio orientato” nel quale posizione, direzione e movimento assumono senso a partire dall’insuperabile punto di vista del soggetto (è la lezione nietzschiana del prospettivismo). Se ci si vuole orientare nel mondo, se si vuole provare a dare un senso al nostro transito in esso, non basta cercare una direzione, occorre piuttosto abbracciare un’altra concezione dello spazio che Binswanger chiama “timico” e che considera incomparabilmente più ricco e completo” di quello orientato perché, a differenza di quest’ultimo, risulta sgravato dall’asservimento alle finalità pratiche e agli scopi determinati, favorendo così “una sorta di relazione originaria tra Io e mondo nei termini di un reciproco scambio emotivo-situazionale”. Non c’è dunque solo uno spazio vuoto e pragmatico nel quale siamo situati, ma uno spazio simbolico e emotivamente connotato nel quale, più propriamente, viviamo esperienze di senso. In questo spazio ciò che chiamiamo “stretta al cuore” consiste realmente nella restrizione del cielo e del mondo e viceversa. Il restringersi del mondo, il suo silenziarsi, il suo rabbuiarsi, risuonano con il nostro fissare il vuoto, oppure il nostro vagare senza senso in un’agitazione sterile che serve a nascondersi da noi stessi, quasi che così potessimo evitare di incontrare la vita. Perdita di mondo e apatia del cuore sono dunque inseparabili facce della stessa medaglia che schizofrenia e depressione maggiore, in particolare, esasperano direi plasticamente, evidenziando tanto il rischio di una loro scissione totale, nel primo caso, quanto quello di un inabissamento del primo nel secondo, nell’altro caso. Naturalmente il discorso vale anche per la gioia che espande il nostro mondo e al contempo dilata i confini del nostro io, per la felicità che sperimentiamo come esperienza di riempimento, e per l’amore come opportunità per la trascendenza della propria centratura egoica in favore di un vissuto spaziale unificato, nel quale l’esserci non è un “essere-insieme” che ambisce a realizzare “l’essere-se-stessi”, ma è davvero aperto al mondo e all’esistenza che si rivelano sconfinati, inesauribili ma “si manifestano e si rivelano continuamente in quanto incontro”. Allora lo spazio si fa abitabile, si fa persino “patria”, luogo nel quale l’esserci “vive l’esperienza dell’esser acceduto al luogo che massimamente gli è proprio, di aver ritrovato il dove della propria origine”, che è appunto relazione, perché è da essa e in essa che nasciamo a noi stessi.
Lo spazio timico, connotato emotivamente, è dunque soprattutto lo spazio che ci apre l’amore, quell’eros che in Platone fa tutt’uno con la filosofia, ossia con quel desiderio di sapere che, come spiegano le ultime pagine del Simposio, è desiderio di essere, è ciò che solo ci apre alla vita e ce la rende abitabile. Una lezione che fatichiamo ad imparare e che trova una splendida espressione in queste considerazioni dell’esistenzialista Karl Jaspers:
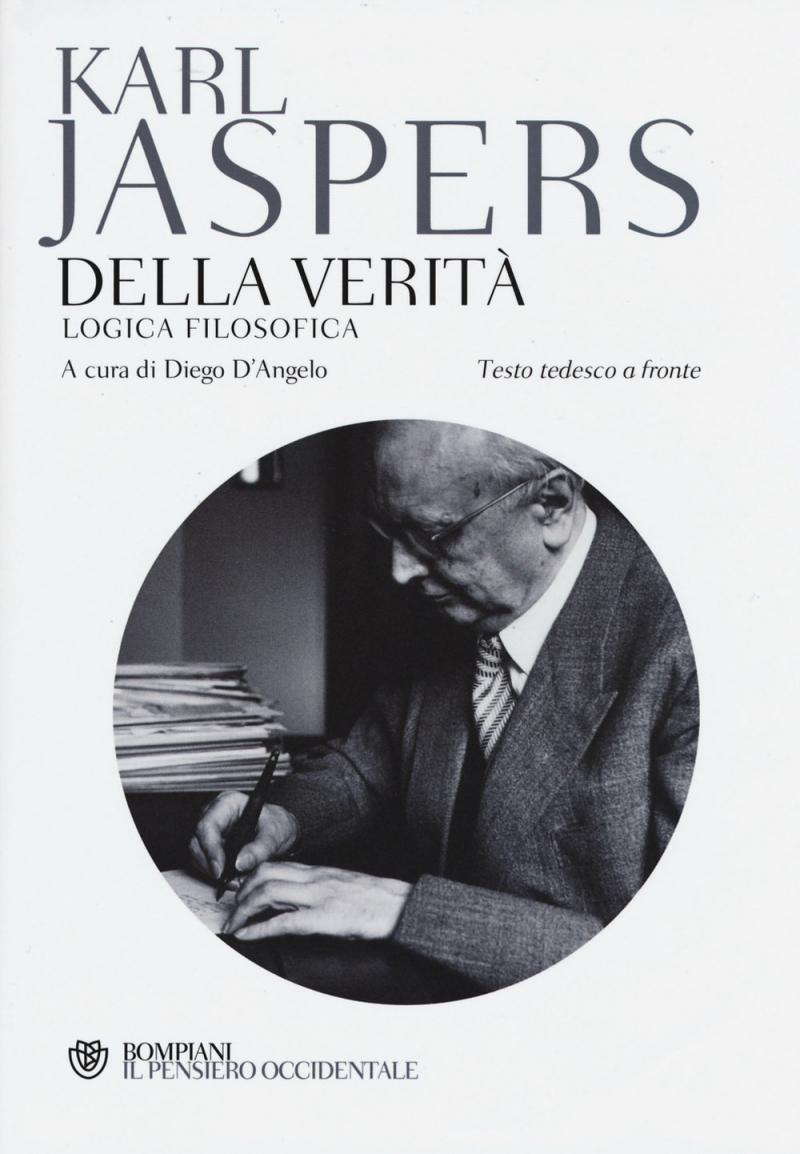
“Se nulla mi viene incontro, se non amo, se attraverso il mio amore non mi si schiude ciò che è, e se io qui non divento me stesso, se per me ciò che è profondo rimane senza voce, allora finisco per essere nient’altro che un esserci di cui si può disporre come si fa con un materiale” (K. Jaspers, 1948; tr. it. Della verità. Logica filosofica, Bompiani, Milano, 2015, p. 354).
Se non troviamo il nostro posto nel mondo è perché non apriamo il nostro cuore, non ascoltiamo le sue ragioni che, come spiegava Pascal, la ragione non comprende. Allora il mondo per noi si fa arido e inospitale; ma nel profondo sentiamo che la colpa è nostra, che siamo stati noi a tradire la vita allorché non le siamo andati incontro con amore. Non c’è tuttavia ragione di colpevolizzarci: un tale ritiro dal mondo e dalla forza vitale per eccellenza è quasi sempre – se non sempre – un meccanismo di difesa eretto per non soccombere al dolore che ci ha procurato una ferita d’amore, una delusione, un fallimento ambientale, origine di ogni psicopatologia non congenita – ossia della stragrande maggioranza dei casi. Ferita tanto più grave quanto più è stato proprio chi avrebbe dovuto prendersi cura di noi a procurarcela o, quanto meno, perché non ha saputo prendersene cura.
Inizieremo a trovare il nostro posto del mondo quando proveremo a prendercene cura noi, magari in grazia di un altro che ci accompagni nel cammino, condividendo con noi uno spazio esistenziale che diventa così, come direbbe Winnicott, “sufficientemente buono” e, dunque, abitabile.









