
Angoscia
“L’angoscia è il primo riflesso della possibilità, uno sguardo e anche un terribile incantesimo”, scriveva Kiekegaard, nel XIX secolo. Una condizione che sempre più persone sperimentano di fronte a quella che chiamava anche “la vertigine del possibile”, l’esperienza straniante di disorientamento e di instabilità sperimentata per lo più nell’immobilità. È l’insostenibile leggerezza dell’essere splendidamente indagata da Milan Kundera nel suo più celebre romanzo: l’inquietante presa di coscienza della totale assenza di necessità in tutto ciò che è e che potrebbe benissimo essere altrimenti, ci fa sentire terribilmente esposti al caso, alle infinite variabili che possono far saltare i nostri progetti, i nostri intenti, le nostre decisioni, le nostre promesse. Ma che cosa esattamente ci angoscia? Secondo la filosofia l'angoscia è angoscia del nulla, non solo perché a differenza dell'ansia e della paura è priva di un oggetto specifico, ma perché ad angosciarci è proprio la consapevolezza che al cuore dell’essere c’è il nulla, un “ni-ente che nientifica” e che, spiega Heidegger, svelando come tutto sia precario, inconsistente e incerto, paralizza (M. Heidegger, Che cos’è la metafisica?).
È questo il suo paradossale incantesimo: il rivelarsi un “impulso inibito di fuga”. La felice definizione è del filosofo Ermann Schimtz che costituisce una delle tante voci chiamate a raccolta nella “polifonica” indagine di Stefano Micali sulla Fenomenologia dell’angoscia (Quodlibet, 380 pp, 26 euro) uno studio che, partendo inevitabilmente da Kierkegaard, Heidegger e Sartre, affianca contributi meno noti e, in parte, più recenti, quali quelli di Tillich, Goldenstein, Blumemberg, Derrida, passando per interessanti e fecondi confronti con la psicoanalisi freudiana (che distingue un’angoscia reale, fondata, e una nevrotica) e con quella lacaniana (con particolare riferimento al Seminario X di Lacan) comparando l'angoscia, ma solo per distinguerla, ai fenomeni quali il trauma e l’attacco di panico, per confrontarsi con il modo in cui emerge in letteratura, specie quella di Proust e di Kafka e nella produzione pittorica di Dürer, Goya e Giorgione.
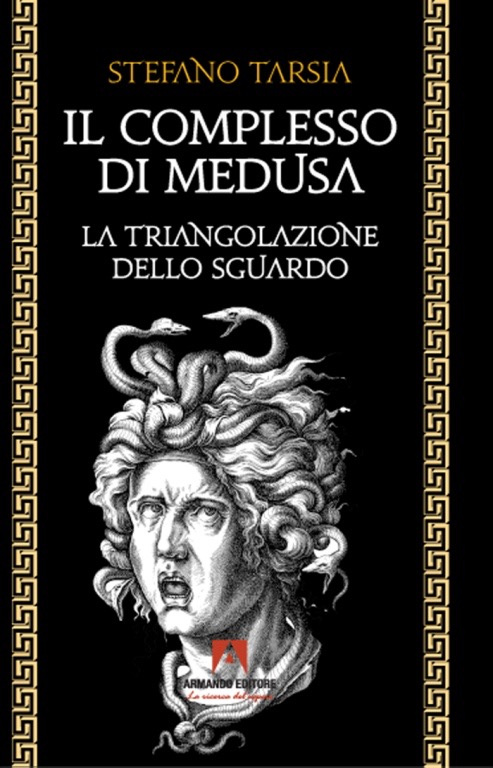
Possiamo in effetti paragonare l'effetto paralizzante dell'angoscia allo sguardo pietrificante e mortifero di Medusa – sul quale tornerò in chiusura per condividere con il lettore le mie personali considerazioni. Ma Micali osserva acutamente come l’angoscia “non solo paralizza, ma ci spinge a compiere in modo convulso degli atti che hanno una interessante specificità: vanno nella direzione diametralmente opposta alla nostra volontà, preparando la nostra futura paralisi”, secondo quella che con Derrida definisce “una logica autoimmune”: “spinti dalla volontà di evitare il peggio, compiamo azioni che crediamo capaci di salvaguardarci dalla futura irruzione del negativo, ed invece esse finiscono con il minare le nostra difese tanto da porre le basi per la nostra futura impotenza e arrendevolezza rispetto alle incombenti difficoltà” (pp. 311-312). Sulla scia di questa osservazione l’autore si spinge, con Kierkegaard, a chiedersi: “quanto e quando diveniamo responsabili della nostra angoscia? Secondo quali modalità si è responsabili della propria angoscia? Come diamo un contributo positivo al nostro angosciarci? In quale forma siamo o saremmo imputabili e quindi colpevoli di essere stati (troppo) angosciati?” (p. 305). Pur non condividendo il riferimento alla colpa, ritengo interessante chiedersi in che modo cooperiamo alla riuscita di questo incantesimo. Secondo Kierkegaard “colui che mediante l’angoscia, diventa colpevole [di angosciarsi], è di certo innocente; infatti non era lui ma una coscienza straniera che lo prese; (…) egli è colpevole perché si lascia cadere nell’angoscia”. E qui Micali riprende la tesi di Schelling che paragona l’angoscia a un "irresistibile canto delle sirene” che ci ammalia e ci seduce (pp. 309-310) anche se vorremmo evitarlo – proprio come lo sguardo di Medusa. Se questo fenomeno è inevitabile, lo sforzo che dovremmo compiere non è tanto quello di legarci all’albero della nave o di provare a tapparci le orecchie, ma, per dirlo ancora con Kierkegaard, quello “di non prestare la nostra forza” a ciò che, senza di essa, si rivelerebbe “un niente impotente”.
Secondo Micali il nostro contributo al potere dell'angoscia va individuato nel nostro sterile tentativo di non fare i conti con essa: “non dobbiamo evitarla ma piuttosto accoglierla. (…) evitare il comportamento di evitamento, quindi aiuta a liberarci dal potere di attrazione dell’angoscia”. Ma come riuscirci? Secondo L'autore occorrerebbero una serie di accorgimenti tattici di tipo cognitivo volti ad aggiustare “la distorsione prospettica” nella quale ci getta l’angoscia, specie con le sue proiezioni su futuri catastrofici; in particolare imparare a stare sul presente e a sottoporlo a un buon esame di realtà dovrebbe riuscire a smascherare i fantasmi che si agitano nell’angoscia e “minarne performativamente le basi del suo credito”; per non ripartire ogni volta da zero sarebbe inoltre utile tenere una sorta di diario di bordo grazie al quale “ri-flettere, ri-vedere, ri-elaborare le proprie agitazioni” (p. 347). Mi permetto di suggerire un’altra possibile via che declinando diversamente l'invito a riflettere mi permette di ritornare allo sguardo di Medusa e al modo in cui Perseo ha scelto di affrontarlo. Egli non si salva dal suo sguardo evitandolo, ma osservandolo riflesso nello specchio/scudo. Lo sguardo è infatti per eccellenza il luogo del riconoscimento, in esso si organizzano tutti i bisogni relazionali, si formano le nostre più intime possibilità d’essere; il timore di essere sopraffatti dallo sguardo dell’altro è pari a quello di non essere visti, o di scoprirsi enormemente diversi da come credevamo di essere. A spaventare ogni Perseo alle prese con la Medusa-angoscia è allora il riconoscimento di una somiglianza con ciò che ci vuole, e che si vorrebbe, annichilire. Ri-guardare in questo caso non è guardare meglio, imparare a ritirare le proiezioni che si autoavverano, ridimensionare ciò che ci spaventa, ma cercare di scorgere che cosa del mostro che abbiamo di fronte ci riguarda; per farlo non serve tanto un buon esame di realtà ma la capacità di guardare in profondità, di rivolgere l'attenzione all’intimità sconosciuta con se stessi che può rivelarsi solo in grazia di un altro che ci faccia da specchio. Il dramma di Medusa è quello di non poter vedere, di non potersi mai rispecchiare nello sguardo dell’altro che cosifica. Perseo si sottrae a questo incantesimo quando evita a sua volta di reificare Medusa, quando cioè non si occupa dell’angoscia in sé, come se fosse una potenza straniera che gli si contrappone (tesi costantemente sostenuta nel libro), ma quando si preoccupa di quanto essa porta in luce in se stesso, del modo in cui è possibile rispecchiarsi in essa. Medusa va guardata ma indirettamente, per ciò che simboleggia, per come risuona in noi, per quanto ci lega ad essa. Ma per sostenere il suo sguardo serve un intermediario, un terzo, e questo terzo è lo scudo, simbolo delle nostre difese e luogo privilegiato dell’indagine dell’inconscio e dell’accesso alle nostre più intime paure e fragilità.
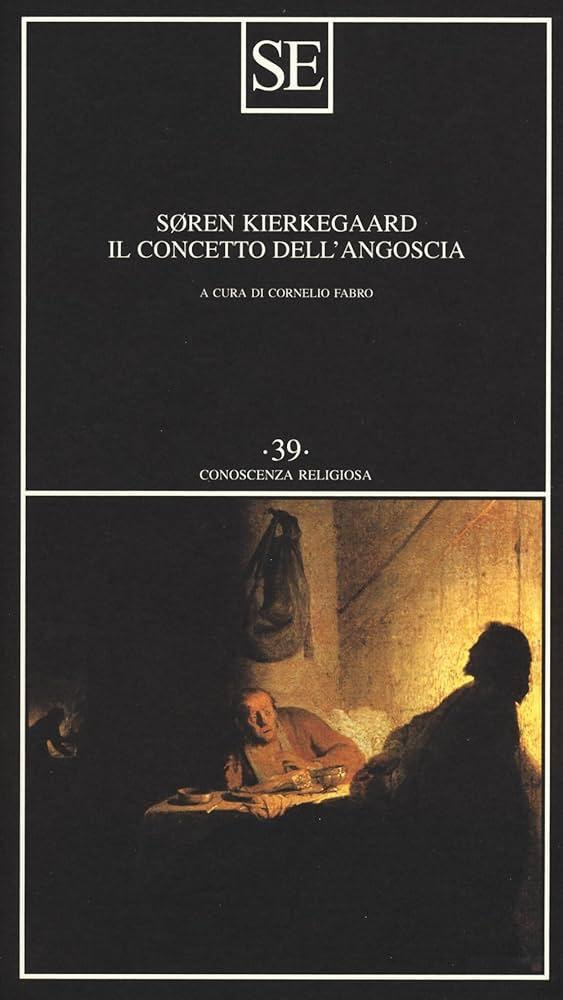
Secondo Nietzsche l’intera storia della filosofia occidentale si potrebbe riassumere nel tentativo di difendersi dal divenire cercando di imprimergli il carattere dell’essere. L’angoscia, svelando il ni-ente al fondo dell’essere, fa saltare questo tentativo e costringe a fare i conti con ciò che è. Ma ciò che è, è appunto ciò che diviene. A pietrificare è l’idea di non poter controllare il corso delle cose, di non poter avere alcuna garanzia non solo su ciò che sarà e che saremo (Sartre, L'essere e il nulla) ma anche su ciò che è e che siamo. Non è l’angoscia ad essere straniera, siamo noi, come insegna Camus in Lo straniero ed è anzi proprio grazie all'angoscia, che per questo Heidegger considera la tonalità emotiva dell'autenticità (Essere e tempo), che potemmo imparare a conoscerci e, per dirlo questa volta con Kierkegaard, “imparare la cosa più alta” (p. 307). Ma questo richiede non tanto un più corretto punto di vista, quanto un diverso modo di guardare che ampli la coscienza, metta in relazione i fenomeni, simbolizzi. Questa nuova visione fa emergere ciò che non si vede, ciò che era rimasto celato, che non volevamo vedere ma che, adeguatamente mediato, può essere accolto e, auspicabilmente, integrato. Ma tutto ciò, ci spiega il mito di Medusa e Perseo, può avvenire solo in una dinamica relazionale – indagata in tutta la sua vasta complessità da Stefano Tarsia nel suo Il complesso di Medusa. La triangolazione dello sguardo, Armando Editore, 2021 – del tutto assente nelle indagini di Kierkegaard e di Heidegger adialetticamente schiacciate sul soggetto e sulla sua capacità di oggettivare ciò su cui posa lo sguardo.
Nel bel libro di Micali c’è un’interessante considerazione di Kafka, una sorta di confessione fatta all’amico Max Brod in occasione di un viaggio che si apprestava a compiere il 4 luglio 1922:
“In tutta onestà, ho una tremenda angoscia per il viaggio, naturalmente non proprio per questo viaggio e non soltanto del viaggiare in genere, bensì di ogni mutamento; quanto più grande il mutamento, tanto maggiore l’angoscia, ma ciò è soltanto relativo se mi limitassi a cambiamenti minimi (la vita però non lo consente). (…) l’angoscia per la morte non è che l’ultimo o il penultimo motivo. È in parte anche angoscia di dirigere l’attenzione degli dei su di me” (citato a pp. 316-317).
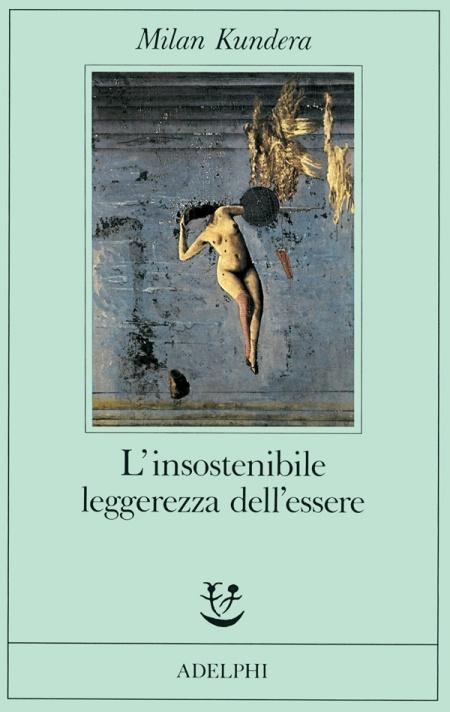
L’angoscia per il cambiamento, per la consapevolezza che non è possibile avere nessuna garanzia che le cose resteranno come sono, che noi stessi resteremo come siamo, è la preoccupazione di muoverci nell’incertezza di ciò che è e di ciò che siamo; un’angoscia paragonata alla morte ma, ritengo, la morte simbolica delle nostre idealizzazioni e, con esse, dei nostri deliri di onnipotenza e di impotenza. L’angoscia è in questo senso la malattia di chi non ha imparato a fare i conti con il limite – vero rimosso del nostro tempo – di cui la morte è simbolo estremo. All’esaltato mito dell’autodeterminazione della propria vita, in cui “impossibile is nothing”, l’angoscia oppone la sperimentazione della libertà come fatica di essere stessi, espressione di un senso di inadeguatezza che sfocia spesso in depressione (Ehremberger) e che alcune statistiche mettono in relazione all'elevato tasso di suicidi nei paesi in cui si sperimentano i più ampi margini di libertà.
Ma torniamo alla conclusione della lettera di Kafka e all’angoscia di dirigere l’attenzione degli dei su di sé. È un riferimento alla colpa di essersi posti al centro del mondo, all’hybris umana contro la quale si scaglierebbero le ire degli dei? La colpa sarebbe il carattere narcisistico di questo sentire, sostiene Stefano Micali (p. 317), che però propongo di leggere come incapacità di riconoscere le relazioni che c’intessono e che, adeguatamente comprese, ci permetterebbero di riconoscere che in ogni autoreferenzialità, non visto, c’è sempre l’altro. Gli dei, sosteneva in un celebre brano Jung, non sono scomparsi, sono diventati malattie, sintomi (C. G. Jung, La dinamica dell’inconscio). La colpa, ma io preferirei dire l’errore, non è attirare la loro attenzione su di noi ma non saperli ascoltare, non instaurare un dialogo con loro, reificarli o negarli anziché considerarli, simbolicamente, parti di noi.









