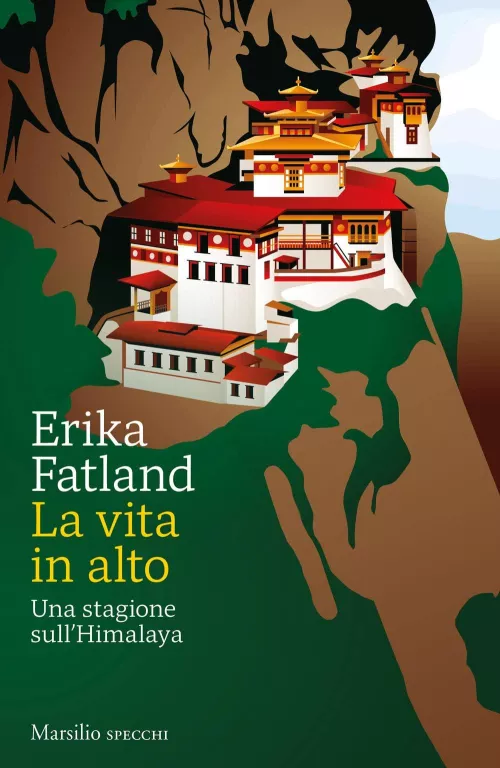Erika Fatland / Una stagione sull’Himalaya
“Dove iniziano e dove finiscono una montagna, una catena montuosa, un viaggio?
Guardando le montagne dell’Asia su una carta topografica muta, la superficie terrestre appare solcata da brusche ondulazioni e corrugamenti che ricordano dei motivi geometrici o dei frattali. Ma non se ne vede l’inizio né la fine, nessuna demarcazione netta”.
All’inizio – e alla fine, e durante – il suo viaggio attraverso l’Himalaya, la scrittrice e antropologa norvegese Erika Fatland si pone questa domanda.
Interrogando una cartina scopre una catena montuosa in realtà collegata ad altri sistemi, quello del Pamir che a sua volta sfocia negli Altaj, e anche del Karakorum, dell’Hindu Kush. Paiono non esserci inizi né fini, ma rocce accavallate l’una sull’altra a formare montagne che sfumano fino a diventare altre montagne, come quei disegni da cui non si alza mai la matita e solamente a tratti la si passa più lieve per poi calcare all’apice di una nuova forma.
Viaggiando scopre come infinite culture, lingue e credenze si mescolino e sovrappongano, nel tempo e nello spazio, nell’apparente uniformità di una popolazione o di un solo individuo, e così si contraddicano e resistano e coesistano prendendosi gioco di ogni “demarcazione netta”.
Fra loro, nomi identità leggi confini e burocrazie passano come ferite.
L’autrice racconta l’itinerario svolto fra luglio e settembre 2018 e fra aprile e luglio 2019 in un imponente reportage dal titolo La vita in alto. Una stagione sull’Himalaya, edito recentemente da Marsilio Editori. L’obiettivo è (anche) il campo base dell’Everest, ma il cammino è lungo, fra gli abitanti di questo luogo densissimo di vita, storia e conflitti, dove molte culture hanno potuto rifugiarsi indisturbate per secoli e dove tutt’ora si combattono dure lotte di frontiera.
Il viaggio di Erika Fatland comincia prima del viaggio, prima dell’Himalaya, nella provincia cinese dello Xinjiang e in particolare a Kashgar. Kashgar è una città in cui prevaleva l’etnia uiguguro, il cui centro storico è stato demolito dai cinesi nel 2009 e dove si impiantano famiglie di etnia Hàn perché “educhino” e “normalizzino” la popolazione musulmana locale, regione in cui è considerato estremismo digiunare durante il Ramadan, dare nomi islamici ai figli e anche non guardare la televisione di stato. Qui, mentre aspetta i documenti che sembrano non arrivare mai per entrare in Pakistan, Erika scopre i mille confini interni imposti dalla Cina: per esempio la “vera” e distrutta città vecchia dove stranieri e Hàn non possono entrare, mentre gli uiguru sì; e la nuova e scenografica città vecchia al cui ingresso i documenti vengono controllati agli autoctoni uiguru, e non agli stranieri e agli Hàn.
Alla fine del viaggio ci sarà di nuovo la Cina, con i suoi pervasivi divieti; i consigli sui migliori punti panoramici per i selfie; l’impossibilità di deragliare da qualsiasi percorso prestabilito; di visitare qualsiasi cosa, persino delle grotte, senza un permesso ufficialmente accordato; e i tristissimi prefabbricati in cui i nomadi tibetani vengono costretti a vivere perché lo stato possa adibire le loro terre all’industria mineraria. Pensiero, etnie e religioni schiacciate, e leggende di matrimoni fra imperatori cinesi principesse uiguru o tibetane per giustificare “storicamente” e romanticamente annessioni di territori per niente romantiche e storicamente molto discutibili.
Fra una Cina (uiguro) e l’altra (tibetana), ci sono mesi fra Pakistan, India, Buthan e Nepal.
Si incontrano islam, buddhismo, induismo e credenze sincretiche con sciamani in jeans maglietta e turbante perfettamente consapevoli che non ci sia nulla di male se una donna con il ciclo dorme in casa e non alla mercé di serpenti e intemperie, ma convinti che, purtroppo, il dio non ne sia altrettanto cosciente. Ci si imbatte in folle di dei e di dee; in dee bambine che un attimo prima giocano al cellulare e un attimo dopo sentono invaderle l’autorevole potenza della divinità; in re e principesse senza regno e in maestri tantrici come Padmasambhava, che in vita riuscì a meditare per tutto l’Himalaya.

Si ascoltano storie di sovrani celesti del Tibet che per otto generazioni si sono calati dal Cielo con una corda e allo stesso modo in Cielo risalivano, finché quella corda non venne recisa da uno stalliere infuriato ed ecco che dinastie ben più secolari si avvicendarono sulla Terra.
Ci sono territori come lo Swat, o il Kashmir, palleggiati fra Afghanistan e Pakistan o fra Pakistan e India, con tutto il sangue, la povertà e le sofferenze che queste contese possono comportare. Ci sono valichi che vengono aperti, strade che vengono costruite, in parte semplificando vite difficilissime, in parte schiacciando dei mondi:
“Dei numerosi regni di montagna che una volta si trovavano nell’Himalaya – e che sotto molti aspetti erano l’Himalaya – oggi ne rimane soltanto uno. Tutti gli altri, nel tumultuoso corso di queste ultime centinaia d’anni, sono stati fagocitati dai paesi vicini, più grandi e potenti. (…) Gli abitanti di quei piccoli regni non hanno più un sovrano, ma in compenso hanno avuto strade, energia idroelettrica e un sistema scolastico centralizzato. Nel corso di questo processo qualcosa è andato irrimediabilmente perduto, e non si tratta solo di qualche sovrano locale: a uno a uno sono stati cancellati dalla cartina tanti piccoli mondi isolati, con i loro fiumi e le loro montagne sacre. Forse era una conseguenza inevitabile. Sull’Himalaya si fronteggiano due potenze nucleari (…)”.
Il paese che si è “salvato” è il Buthan: un paese speciale, dove la modernizzazione è avvenuta in maniera consapevole e controllata; piani urbanistici severissimi impediscono scempi di ogni sorta; il 60% del territorio deve per legge essere ricoperto da foreste, e invece ne è ricoperto il 70%; l’energia è soprattutto idroelettrica e la felicità interna lorda conta più del Pil e della crescita economica. Per forza di cose questa felicità “è qualcosa di completamente diverso dalla vostra idea occidentale di felicità” ed è divisa in “quattro pilastri principali: sviluppo socio-economico equo e sostenibile, buona amministrazione, tutela dell’ambiente e infine promozione e difesa della cultura”.
Altrove, fra quelle cime candide, apparentemente eterne e intoccabili, ci sono ghiacciai che si ritirano, fiumi ora fin troppo pieni ma che presto potrebbero essere secchi e un cambiamento oltre che culturale anche climatico alle porte.
Erika Fatland racconta quello che vede e ascolta – soprattutto ascolta – le voci e le storie delle persone che incontra, lasciandole parlare, lasciando che il mondo in cui vivono sia plasmato dalle loro parole.
Ascoltando quelle voci, si scopre per esempio che in Nepal, nel distretto buddista di Humla, si pratica la poliandria per non dividere la proprietà agricola: una donna sposa uno o più fratelli in modo da non dover dividere le terre, e se ci sono problemi di gelosia “semplicemente ci si fa i conti”. E con naturalezza si viene a sapere anche che i Mosuo in Tibet hanno una società matrilineare, è la nonna a comandare e l’unica ad avere una stanza tutta per sé; nella casa della sposa restano anche gli zii, i figli, e gran parte della famiglia di origine mentre i mariti vivono per conto loro, fuori: “l’uomo si reca a casa della moglie di notte e se ne va il mattino dopo” e per divorziare basta che la donna “lasci la finestra chiusa”.
Non viene voglia, o almeno non è venuta voglia a me – e quando mi è venuta quasi sempre l’ho tenuta a bada – di accendere il computer e guardare con i “miei occhi”, o piuttosto con quelli di Google, foto del Monastero di Taktsang in Buthan, del villaggio di Passu in Pakistan, o delle coltivazioni di tè in Darjeeling. Sembrerebbe di inquinare sia i miei occhi, che possono ora immaginare qualcosa che non hanno mai visto, sia quei luoghi stessi, che immortalati in una sfilza di fotografie si farebbero d’un tratto meno speciali o meno veri.
Se vorrò davvero vederli, penso leggendo queste pagine, ci dovrò andare con le mie gambe, o semplicemente non li vedrò affatto.
Soprattutto non cerco fotografie del monte Meru – chiamato anche casa di Shiva, o Kailash, anima del Tibet, o Centro del mondo – da cui sgorgano le sorgenti di quattro fiumi sacri. È un monte talmente sacro che nessuno l’ha mai scalato: si disturberebbero gli dei.
Spero che sia davvero così, che quegli dei non siano davvero mai stati disturbati.
E riflettendo su un’altra domanda che si pone Fatland lungo il libro e lungo il tragitto, “Perché viaggiamo?”, penso che ci sia qualcosa di molto bello nello scoprire quanto possa essere lontano e sconosciuto il “centro del mondo”. Il centro del mondo, se non dappertutto, è quanto meno sparso in innumerevoli punti del pianeta. Ridimensionarsi, in un certo senso delocalizzarsi, è un buon motivo per viaggiare.
“Si chinò verso di me e mi scrutò con attenzione.
«È americana?» chiese a Savitri, che le spigò che venivo dall’Europa. Kokila annuì, lo sguardo vacuo. Evidentemente quel nome non le diceva nulla.”