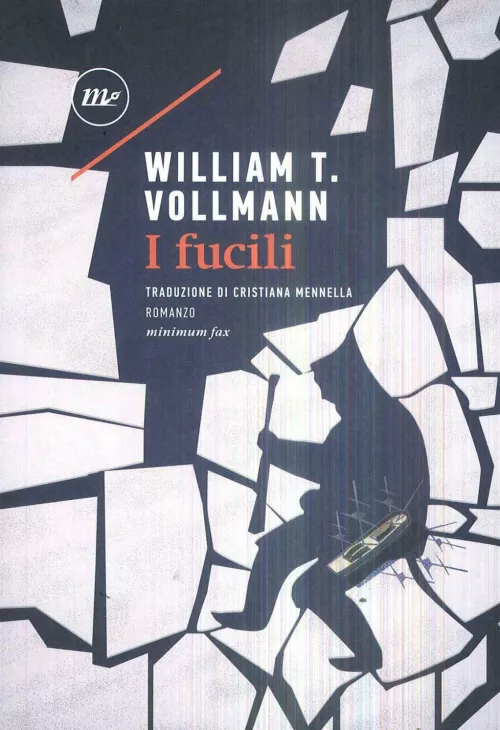Sette sogni / William T. Vollmann, I fucili
È difficile, per chi studia e ama il lavoro di William T. Vollmann, non essere felice di questa sua rinnovata fortuna nel nostro Paese. La storia editoriale di Vollmann in Italia, come ho già avuto modo di notare, è stata piuttosto accidentata, e la decisione di Minimum Fax, nella persona di Luca Briasco, di ripubblicare quattro suoi romanzi e di fare uscire l’inedito I fucili (The Rifles; 1994) è lodevole e coraggiosa, e maggior merito le dà l’ottima traduzione di Cristina Mennella. Certo, un pessimista potrebbe anche dire che, se Vollmann non è diventato patrimonio di tutti i lettori di narrativa contemporanea quando è uscito un capolavoro del ventunesimo secolo come Europe Central (Mondadori 2010) allora è difficile che questo ritorno di fiamma arruoli più di qualche esoterico cultista del massimalismo letterario, com’è a giorni alterni il sottoscritto e come sembrano essere un po’ tutti i suoi recensori: ma occorre sforzarsi di vedere il bicchiere mezzo pieno.
Prendiamoci qualche istante per fare una domanda volgare, ma non superflua: di cosa parla I fucili? Tanto per cambiare, è difficile a dirsi. Di ghiaccio e di gelo, principalmente; delle vaste solitudini artiche. Della colonizzazione delle Americhe. Dell’annientamento degli inuit e della loro rilocazione forzata. Della spedizione di Sir John Franklin, che nel 1845 lasciò Londra al comando della Erebus e della Terror e dei loro centoventotto uomini di equipaggio alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest – tutti morti di fame, freddo e malattia tra il 1847 e il 1848, incagliati nel ghiaccio vicino all’isola di Re Guglielmo. Ma, nel presente, I fucili parla anche delle avventure artiche del capitan Sottozero, che poi sarebbe Vollmann, ma anche una reincarnazione del capitano Franklin, e del suo amore per la giovane inuit Reepah, alcolizzata e infelice, che nel corso dell’opera si riconfigura come l’incarnazione della divinità dell’abbondanza del popolo inuit. La varietà solo apparentemente caotica di questi argomenti risponde allo scopo de I fucili, che è uno dei Sette Sogni di Vollmann (una serie di sette romanzi dedicati agli scontri tra coloni e nativi americani, di cui I fucili rappresenta il sesto volume ma solo il terzo in ordine di pubblicazione): “Il mio obiettivo [...] era di creare una «storia simbolica», ovverosia un racconto di origini e metamorfosi che spesso è falso, se rapportato ai fatti reali così come noi li conosciamo, ma la cui inesattezza disvela un più profondo senso della verità” (p. 451).
I fucili non è forse il miglior romanzo di Vollmann: benché suggestivo, c’è l’impressione che non solo non arrivi davvero a un punto fermo, ma che nemmeno sappia sempre in che direzione dirigersi, e che, come in fondo accade in molti libri dell’autore, si proceda per accumulo e apposizione. Certo, sono considerazioni che sembrano quanto mai appropriate per un libro che parla di una spedizione perduta e del delirio di inazione a cui sono costretti gli inuit dopo i trasferimenti forzati. Allo stesso tempo, I fucili è un romanzo grandemente rappresentativo dello stile di Vollmann e della sua grandezza come scrittore: un libro che abbraccia mitologia, esperienza personale, ricerca storica e studi etnografici in una prosa insieme lirica e sardonica.
Soprattutto, è un libro che condensa le preoccupazioni ricorrenti di Vollmann, che non abbandonano nessun volume della sua opera: il peso del colonialismo nella distruzione delle tradizioni e degli ecosistemi locali, e l’ambivalenza del rapporto dominante-dominato. In tutte le sezioni ambientate al presente, Vollmann insiste sui trasferimenti forzati subiti dal popolo inuit, sul loro insediamento obbligatorio in villaggi prefabbricati e isolati, sulla frammentazione delle loro famiglie, sugli abusi economici e sessuali, sull’alcolismo che imperversa nelle comunità stabilizzate.
A dispetto del titolo, i fucili non rappresentano nel romanzo uno strumento per infliggere violenza ad altri uomini, bensì un’innovazione tecnologica che rivoluziona i millenari metodi di caccia degli inuit, portando al rapido collasso dei delicati equilibri ecosistemici dell’Artico, e alla quasi completa sparizione di specie autoctone. I vasti branchi di caribù, di foche, di leoni marini, il grande numero di balene che aveva rappresentato per secoli la fonte di sostentamento del popolo inuit – una fonte da gestire con attenzione, di cui prendersi cura, e accessibile solo grazie alla lunga esperienza non del singolo cacciatore, ma di un popolo intero, viene annientata dagli strumenti troppo efficienti importati dai coloni. Come scrive l’etologo Farley Mowat in People of the Deer, straordinario libro sul popolo Ihalmiut e tra i preferiti di Vollmann: “Il fucile a ripetizione ha rubato la scena. Una stirpe di uomini che avevano dedicato secoli della loro storia all’uccisione del cervo con armi che risultavano efficaci solo se usate con grande maestria, si ritrovò in mano un’arma che poteva uccidere senza limitazioni né particolare maestria...” (ne I fucili, p. 161). Ma non si tratta solo di uno strumento messo a disposizione degli inuit – si tratta dell’imposizione di una mentalità dell’abbondanza e dello spreco in un ecosistema che non è in grado di supportarla (e d’altra parte, come ci dimostrano i presenti cambiamenti climatici, nessun ecosistema ne è davvero in grado). La cura e la parsimonia che hanno caratterizzato per millenni il rapporto degli inuit col proprio ambiente sono sostituite dall’abuso dell’ambiente stesso e delle sue risorse: e nel romanzo abbondano le scene in cui inuit più o meno giovani sparano e uccidono ad animali che non sono poi in grado di portare a riva o a casa, o di cui non sono in grado di sfruttare tutte le parti, riducendosi a doverle lasciare marcire tra le nevi.
Questa dicotomia è racchiusa nelle due citazioni che aprono il romanzo. All’affermazione dell’inuit Barnabas Piryuaq che il suo popolo aveva come regola “di non uccidere mai un animale che non avremmo usato per cibo o vestiario”, Vollmann oppone il ricordo dei viaggi artici dell’esploratore Jan Welzl: “Ecco, a quelle alte latitudini trovavamo una tale quantità di foche e trichechi che semplicemente non sapevamo cosa farcene. Ce n’erano a migliaia; camminavamo in mezzo a loro e li colpivamo in testa e ridevamo di gusto davanti all’abbondanza che Dio aveva creato”. La preoccupazione di Vollmann, tuttavia, non è moralistica e separata dalla realtà, ma coglie la problematicità di ogni aspetto della questione indigena: le campagne di Greenpeace contro la vendita di pelli di foca sono giuste sulla carta, ma si traducono nella perdita di una delle ultime fonti di guadagno degli inuit, e nell’ulteriore impoverimento di una comunità già al limite (p. 390).
Ma I fucili non è solo un testo sul presente: è anche un romanzo storico su una delle avventure più tragiche e discusse dell’Ottocento. Il viaggio di Franklin è disastroso e lugubre, perso nelle tenebre e nella solitudine dei lunghissimi inverni artici – le navi, incagliate nel ghiaccio, si spostano con esso, ma, d’altra parte, “anche una tomba segue il moto rotatorio della terra, e ciò non sembra conferire al suo inquilino neppure un briciolo di forza motrice” (p. 280). Allo stesso tempo, la sovrapposizione dei due piani temporali rende chiaro come il viaggio di Franklin non abbia conseguenze nefaste solo per i suoi partecipanti, ma anche per le popolazioni “scoperte” in loco, come si legge in questo passaggio, in cui Vollmann, come fa spesso, unisce e alterna il tempo presente, quello della Storia e quello del mito:
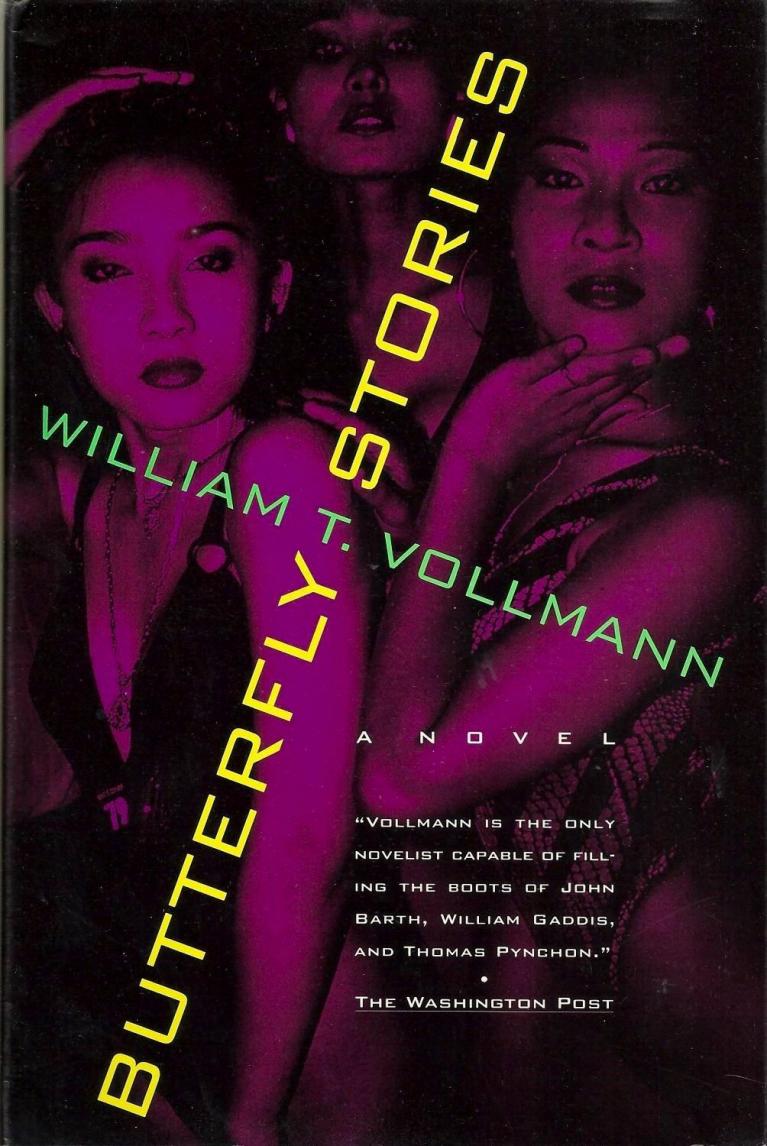
Quei due uomini non erano tanto diversi. Entrambi avevano il fucile. Ma il secondo, l’uomo bianco, sedeva davanti al ghiaccio scricchiolante, in attesa. Non sapeva come vivere in quel paese. Non gli restavano più forze per vivere.
***
La sua inedia era stranissima perché aveva proiettili per il fucile e c’era cioccolata nella scialuppa dove gli altri uomini giacevano senza vita e poco lontano c’era una lattina di carne in scatola, ancora da aprire. SEDNA [la dea della fertilità] mandava foche in abbondanza dagli abissi, che salivano fino al ghiaccio; erano pronte per essere uccise, ma il fucile non lo aiutò.
***
In seguito toccò all’Inuk morire di fame, perché non c’erano animali. Il fucile aiutò poco anche lui. (pp. 38-39)
Certi di agire nel giusto, e a dispetto dei fallimenti precedenti (già in passato Franklin aveva guidato una spedizione risoltasi in un’ecatombe, e con forti sospetti di cannibalismo), gli organizzatori della spedizione danno prova di un entusiasmo genuinamente gaio e coloniale nello stendere davanti ai loro occhi le mappe dei territori che si apprestano a conquistare: “Le carte nautiche e topografiche vennero dispiegate su un tavolo e tutti i presenti sentirono i loro cuori battere trepidanti davanti all’azzurro, il giallo e il bianco, e i nomi li irretivano e li facevano spasimare come per una donna (lady Franklin era a casa): il promontorio del Grande Orso! La penisola Meta Incognita, lo stretto Ghiacciato, lo stretto del Ghiacciaio! Ecco la vecchia Punta Turnagain! ...ah, ed eccolo lì, Fort Confidence da dove partimmo quando eravamo giovani. L’isola d’Inverno, capo Ghiacciato!” (p. 129). Le mappe e i disegni che costellano I fucili, al contrario, non sono gli strumenti scientifici di dominio e controllo della spedizione di Franklin, ma schizzi fatti da Vollmann stesso, spesso in presa diretta, e, nel caso delle mappe, corredati da indicazioni topografiche in inuktitut. Vollmann, a differenza di Franklin e dei suoi uomini, si mette in gioco in prima persona, ripercorre i passi della loro spedizione rischiando di morire assiderato, diventa amico degli indigeni, li intervista, si mette nei loro panni, e soprattutto studia, come dimostrano le centinaia di riferimenti bibliografici che puntellano il romanzo. Allo stesso tempo, se Vollmann/capitan Sottozero sostiene di essere l’incarnazione di quello stesso Franklin che descrive come “inconcludente ma con metodo” (p. 71), è perché conosce bene i limiti di questo sforzo conoscitivo.
La disavventura artica di Vollmann, con le lunghe pagine di descrizioni della sua incapacità di utilizzare gli strumenti necessari a sopravvivere al Polo, è la parodia di un viaggio iniziatico (tema richiamato nelle diverse epigrafi da Mircea Eliade) e segnala la sua definitiva incapacità di capire gli indigeni, ma anche il suo volerci provare, il suo mettersi a loro disposizione. Così come in Butterfly Stories gli incontri con le prostitute thailandesi e cambogiane di cui il protagonista si dice innamorato passano attraverso interpreti che non conoscono l’inglese o per lemmi stravolti e rovesciati, senza che l’uomo si preoccupi mai di imparare la lingua locale, ne I fucili la posizione di capitan Sottozero verso Reepah è ambivalente e limitata; Sottozero è incapace di un abbandono completo, di un ingresso definitivo nel mondo artico, ma lo può solo costeggiare da turista, per quanto impegnato.
Questa incapacità indica due cose: la coscienza di Vollmann di non potere tralasciare e trascendere l’oppressione che il suo popolo ha esercitato su un altro; e l’insufficienza delle fonti documentarie (a loro volta prodotto ideologicamente informato) nell’aiutarlo a conoscere. Una simile diffidenza verso il lavoro del ricercatore è segnalata a tratti nel testo, con ascessi sulfurei e grotteschi:
Quanto a me, come è tipico della vita, conobbi un signore a una serata letteraria e avevamo alzato il gomito tutti e due, e lui iniziò a parlare della spedizione Franklin, lasciandomi intendere che a casa aveva tutte le immagini dei cadaveri congelati, col volto simile al lichene nero che ho visto una volta a Iqaluit, screziato di verde come un dorso di rana; aveva qualche aggancio con i tecnici della scientifica; mi diede il suo numero – ma quando lo chiamai un mese dopo fu molto formale e gelido perché era il numero dell’agenzia pubblicitaria dove lavorava e aveva soltanto la videocassetta di un programma televisivo. (p. 142)
Per Vollmann conoscere attraverso lo studio è importante, ma non basta: d’altra parte, se bastasse, forse la spedizione di Franklin non si sarebbe incagliata, e capitan Sottozero non avrebbe rischiato di morire assiderato. Quello che occorre fare è incontrare e capire in prima persona l’irriducibile complessità dei fenomeni e degli esseri umani che si analizzano, senza avere la presunzione di poterli esaurire – tanto più in un paesaggio ambiguo come quello artico. Vollmann, nelle prime pagine de I fucili, descrive il proprio tentativo di trovare la fonte di un fiume artico, solo per scoprire “che il fiume che avevi costeggiato non aveva un’unica sorgente, che quei laghi erano permafrost sciolto; tutta l’isola era permafrost; stare sull’isola era stare in un mondo di fiumi provenienti da ogni dove” (p. 21). I fiumi provengono da ogni dove, e mapparli è impossibile, ma non lo è parlarne, e portare testimonianza di quello che si è visto e di quello, soprattutto, che si è sognato: in questo sforzo inarrestabile sta la grandezza di Vollmann come scrittore.
William T. Vollmann, The Rifles (New York: Viking Press, 1994), trad. it. I fucili (Roma: Minimum Fax, 2018).