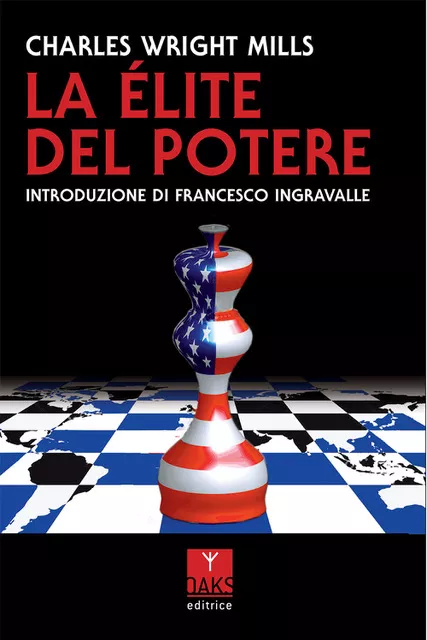Dal ragioniere in Lambretta a TikTok
“I signori della guerra, i grandi uomini d’affari, i dirigenti politici tendono a marciare insieme, per formare l’élite che detiene il potere”. E poi: “Affondata nella sua routine la gente non trascende la propria vita […] e non riesce a farsi un’idea della struttura della società in cui vive e della propria funzione in seno ad essa. La società è una struttura composta da tante piccole cerchie […] e ognuno è intrappolato nei confini della propria cerchia e tagliato fuori dagli altri gruppi. È per gente compresa in ambienti così ristretti che i grandi mezzi di informazione possono creare uno pseudomondo, attorno all’individuo e nell’intimo dell’individuo. […] E chi appartiene alla massa non può uscire dal proprio ambiente se non con la spontaneità organizzata del ragioniere in Lambretta”.
E ancora: la sua vita, invece di fondarsi su ragione e riflessione, su conoscenza e consapevolezza “si svolge aderendo a un inconscio monologo, che riecheggia schemi ricevuti dall’esterno”; perde la sua indipendenza e “si lascia portare, rispetta le abitudini, il suo comportamento è una mescolanza gratuita di criteri confusi e di prospettive acritiche mutuate da persone che non conosce. […] Perde la sua indipendenza e, cosa più importante, ne perde il desiderio; perde il desiderio di vivere “con opinioni proprie e con un proprio modo di vivere” – anche se crede di essere libero e indipendente, ma sempre secondo la spontaneità organizzata dal sistema per lui.
Quanto citato qui sopra è una perfetta descrizione della società di oggi, con le cerchie/bolle di omologati del conformismo digitale; in una società di massa digitale/digitalizzata ma che sempre di massa (e di massa di masse) è; con i mezzi di informazione/social media che creano uno pseudomondo per tanti monologhi inconsci di chi ama lasciarsi portare da TikTok o da ChatGPT o da un algoritmo predittivo o dai criteri confusi e dalle prospettive acritiche dei populismi, sovranismi, tecno-fascismi, perdendo ogni capacità di indipendenza (di uscita dalla minorità, direbbe Kant), e soprattutto perdendone il desiderio, semmai rincorrendo compulsivamente i desideri creati/organizzati per lui dal capitalismo. Vero, ma in realtà era la descrizione della società di massa organizzata dal potere delle élite degli anni ’50 del secolo scorso. I virgolettati sono infatti presi da un libro famoso uscito nel 1956 del sociologo americano Charles Wright Mills (1916-1962) – uno dei massimi sociologi del ‘900, tradotto da Feltrinelli nel 1959 e oggi finalmente e opportunamente ristampato: La élite del potere, Oaks Editrice (pag. 412, € 28.00), Introduzione di Francesco Ingravalle. Così permettendoci di confrontare nuovamente oggi con ieri e scoprire che oggi (ma più di ieri) siamo sempre una società di massa e che sempre il potere è nelle mani delle élite – come a dire che vi sono delle costanti della modernità che si ripetono e semmai si aggravano nell’ipermodernità di oggi. Un saggio, questo di Mills, come non se ne scrivono (quasi) più, travolti come siamo da specialismi e semplificazionismi mainstream e commerciali. Un libro critico, con Mills che cercava di richiamare anche gli intellettuali americani a un dovere di responsabilità e soprattutto di riflessione critica sulla società e sul potere – e oggi abbiamo un disperato bisogno di libri come questo, capace di analizzare la società nella sua complessità e nella sua evoluzione (o involuzione) storica. Un saggio di lucidissima critica della aberrante (di allora come di oggi) società americana e delle sue strutture di potere diventate poi la normalità politica e sociale (antropologica?) dell’intero occidente.
Un classico da riscoprire. Scritto da un Autore conosciuto anche per Colletti bianchi e per L’immaginazione sociologica. Una immaginazione (che lo portò anche a prevedere una democrazia oligarchica – apparentemente una contraddizione in termini, eppure e purtroppo realissima oggi) capace di far riflettere gli uomini su se stessi come soggetti liberi e non vincolati da quella molteplicità di influenze sociali che condizionano inconsapevolmente ogni atto e pensiero della vita quotidiana – ma una immaginazione necessaria anche a una sociologia già allora sempre meno critica, sempre più parcellizzata, sempre più funzionale alla legittimazione del potere. Con Mills che scriveva anche – con una chiarezza che oggi ci manca quanto più la tecnologia si fa pervasiva e totalizzante – che “la scienza non è un Secondo Avvento tecnologico! Il fatto che alle sue tecniche e alla sua razionalità venga riconosciuto un posto preminente in una società, non significa che in quella società gli uomini vivano secondo ragione e senza miti, né inganni, né superstizioni. L’istruzione universale può portare all’imbecillità tecnologica [come oggi] e al provincialismo nazionalistico [come oggi], anziché all’intelligenza informata e indipendente [come oggi]. Organizzazioni sociali razionali [come vorrebbe essere oggi il capitalismo digitale con la automatizzazione della vita e del pensiero] non equivalgono, ipso facto, a mezzi di accrescimento della libertà individuale o della società. Spesso, invece sono mezzi di tirannia, di coercizione, di eliminazione [come oggi con l’intelligenza artificiale] di ogni probabilità di poter ragionare, di poter agire come uomo libero”.
E dunque, chi governa il mondo? Chi ci governa? E come? E per garantire e tutelare quali reali interessi? – e la crisi climatica mai risolta se non negata/rimossa ci dice quali potentissimi interessi e quale potentissima élite impone le sue scelte sul mondo. E cosa si nasconde dietro a Trump & Musk e all’anarco-capitalismo con la motosega come feticcio, cosa si nasconde dietro a Macron, Putin e Meloni e a una Europa che si fa bellicista e sempre più ottusamente neoliberale e industrialista – anche dell’industria delle armi e della guerra? Domande antiche e modernissime allo stesso tempo. Ma prima di tornare a Mills facciamo un passo indietro per ricordare che di élite avevano scritto in precedenza Gaetano Mosca (“in tutte le società esistono due classi di persone, quella dei governanti e quella dei governati” – tesi criticata da Mills perché meramente tautologica); Wilfredo Pareto; Roberto Michels e Thorstein Veblen; ed Edward L. Bernays, nipote di Freud, padre (con Walter Lippmann) delle public relations e teorizzatore della necessità delle élite e della propaganda per il governo anche delle società democratiche, personaggio sconosciuto ai più ma dal potere enorme e che scriveva, nel 1929: politici, industriali, finanzieri, pubblicitari, mass media “sono loro che tirano le fila, controllano l’opinione pubblica, sfruttano le forze sociali esistenti, inventano altri modi per organizzare il mondo e guidarlo”. Ma ricordiamo – ancora prima ma restando nella modernità – Saint-Simon che nell’800 invocava la tecnocrazia dell’élite industriale e finanziaria per governare la società moderna e industriale; mentre Marx scriveva di classi dominanti e classi dominate e di lotta di classe per rovesciare la prima.
A loro confronto, il mondo delle élite del potere descritto da Mills è decisamente peggio, Mills magistralmente descrivendo il nesso sociale, psicologico, funzionale, di potere tra élite politica, militare ed economica, che condividono una comune visione del mondo fondata su una metafisica militare; sull’identità di classe dell’élite stessa; sull’interscambiabilità (detta altrimenti teoria e prassi delle porte girevoli) delle élite; sulla cooptazione e la socializzazione all’élite mediante l’immedesimazione in essa (e nella sua way of life) di chiunque voglia arrampicarsi socialmente. Senza rendersi conto il demos – come scriveva Luciano Gallino citato da Ingravalle – che “se il sistema democratico cade in mano a una élite politica, economica, militare che lo controlla in ogni sua parte, cessa di essere democratico” – che è poi la condizione in cui ci troviamo ancora di più oggi rispetto al tempo di Mills. E l’élite del potere e/o il potere delle élite è diventata appunto la normalità sistemica di quelle che incredibilmente e ipocritamente continuiamo a chiamare democrazie – perché l’élite del potere o il potere delle élite è cosa tutta diversa e soprattutto contraria rispetto alla democrazia rappresentativa e al concetto stesso di demo-crazia.
Ma cos’è dunque l’élite del potere secondo Mills? Essa “è composta da uomini che si trovano in posizioni tali da poter trascendere l’ambiente dell’uomo comune; le loro decisioni – come le loro non decisioni – hanno conseguenze più vaste. […] Stanno a capo delle alte gerarchie e delle organizzazioni della società moderna; dirigono i grandi gruppi economici; muovono la macchina dello stato […]; comandano le forze militari. […] Ma l’élite non è costituita unicamente da condottieri solitari. Consulenti, consiglieri, portavoce, esperti dell’opinione pubblica formano uno stato maggiore che spesso guida il loro stesso pensiero, le loro decisioni più importanti. E subito sotto l’élite dominante stanno i politici di professione che esercitano il potere a livello medio, nel Congresso e nei gruppi di pressione […]” – cioè nelle lobbies.
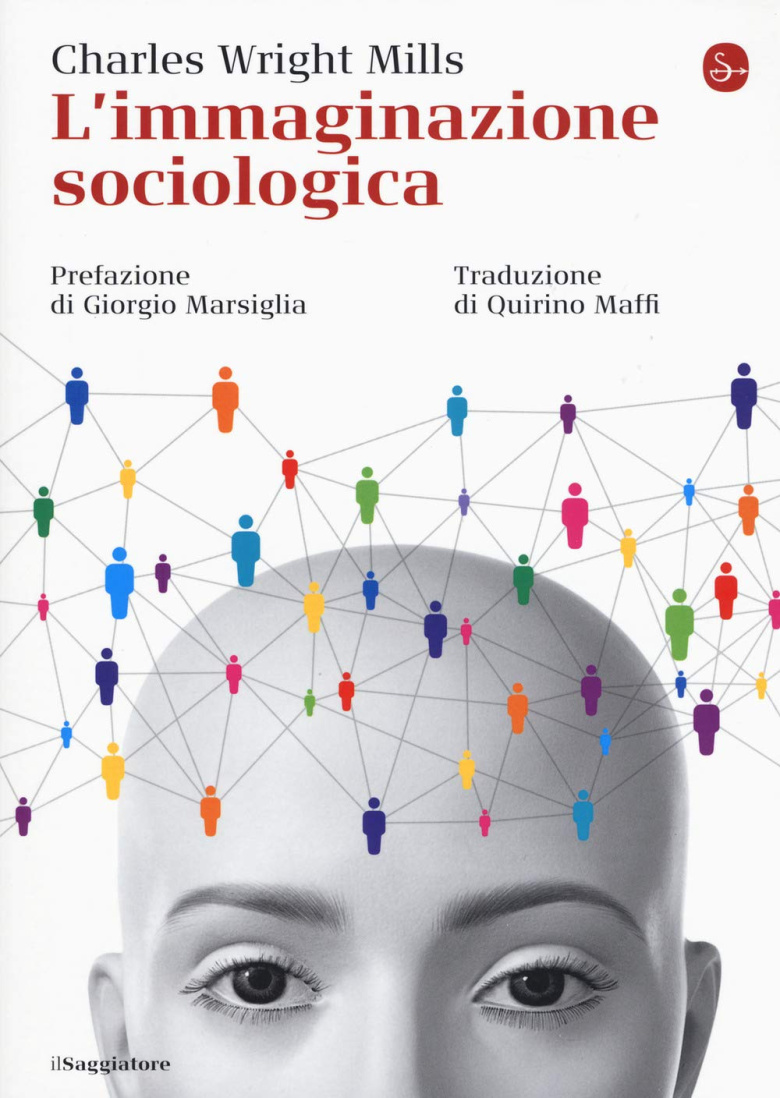
E se l’élite americana, ricorda Mills cercandone appunto la genealogia, “entrò nella storia moderna come una borghesia priva di avversari”, questa élite non poté poi “contenere l’impulso storico del commercio e dell’industria a subordinare a sé l’élite del capitalismo. Né in alcun paese del mondo si poté arginare quello americano, quando la violenza dell’industrialismo divenne un fattore storico decisivo” – e oggi abbiamo la violenza dell’industrialismo digitale e dell’intelligenza artificiale e delle relative élite (o meglio: oligarchie), che si impongono sul mondo a loro piacimento, sempre prescindendo o sempre aggirando/negando la demo-crazia. E “mai prima d’oggi gli strumenti del potere sono stati così sterminati. È questo che rende tanto precaria la nostra situazione” – allora e ancora di più oggi. E se tutti viviamo nella storia, pochi hanno il potere di farla – noi tutti avendo da tempo rinunciato a farla, la storia, come invece chiedevano illuminismo e marxismo, delegando sempre più il potere alle macchine e agli imprenditori.
Mills, come detto, analizza una molteplicità di elementi e basterebbe elencare alcuni titoli dei capitoli del libro: Le alte sfere; La società provinciale; I quattrocento metropolitani; Il mondo delle celebrità (comprendente “ogni gamma di persone, dal dozzinale al disgustoso”); I ricchissimi (che “potenziando la proprietà privata e impadronendosi degli strumenti per proteggerla si sono piazzati e barricati nelle più alte sfere dei grandi gruppi”, gruppi che “assomigliano più a stati nello stato che a organismi privati”); I grandi dirigenti; I ‘signori della guerra’; La società di massa (e la differenza tra pubblico e massa e con la “forza malefica dei grandi mezzi di comunicazione”) – che potrebbero essere i titoli di un nuovo saggio sull’élite/oligarchia di oggi.
E così Mills – scegliamo alcuni spunti del libro, impossibile ricordali tutti – analizza i Social Register (che elencavano le persone socialmente elette); l’evoluzione della famiglia; le scuole private con “il compito di selezionare e preparare i nuovi membri del ceto superiore”; il mondo delle celebrità/star system, tipico “di una società che della concorrenza si è fatta un feticcio”, con “i cronisti dei giornali più diffusi e della televisione che si sono uniti per creare un’aura di fascino raramente uguagliata dalla maestà delle antiche corti, almeno da un punto di vista quantitativo”, ma utile “a distrarre l’attenzione del pubblico o a impressionare le masse”; le young girl (“tra le persone che gli americani onorano, nessuna è onnipresente come la young girl: ovunque si volga lo sguardo si incontra questa figura caramellosa, ora giovanissima, ora un po’ meno: vende birra, libri, sigarette, indumenti; ogni sera compare sugli schermi della tv, ogni settimana è ritratta sulle pagine delle riviste e non manca sugli schermi cinematografici”); e poi e ancora il progresso tecnologico che solo apparentemente decentralizza (come ancora abbiamo creduto ingenuamente negli anni ’90), mentre sempre centralizza perché “la tv a circuito chiuso e il calcolatore elettronico permettono di controllare una enorme schiera di unità produttive, decentralizzate quanto si vuole […]”, ma sempre centralizzate quanto a organizzazione, comando e sorveglianza.
E ancora: in America, “di tutti i valori possibili, uno ed uno soltanto è veramente sovrano, universale e incrollabile, una sola meta è accettata da ogni uomo, il denaro”. Un’America dove “la sola politica di ‘pace’ seriamente accettata è quella del fucile spianato”, perché “la guerra o la preparazione della guerra sono sentiti come condizione normale […] e l’economia ha assunto tutti gli aspetti di un’economia di guerra permanente”. Un paese che “ha sostituito l’intelligenza con la banalità”, con George Washington che nel 1783 “si riposava leggendo Voltaire e Locke, mentre Eisenhower legge storie di cowboy e romanzi gialli”.
E accanto e dopo Mills? Per la parte di analisi del fenomeno élite e dintorni – in vari modi e con diverse letture – si potrebbero richiamare (ma è un elenco necessariamente parziale) la Scuola di Francoforte; La ribellione delle élite di Lasch; Luciano Gallino (da L’impresa irresponsabile a Il colpo di stato di banche e governi); e poi Foer (I nuovi poteri forti, quelli della tecnologia); e Crouch (Il potere dei giganti, cioè delle grandi imprese e Postdemocrazia); e Noam Chomsky (nella democrazia capitalista – “un’evidente contraddizione in termini” – “tutti devono sottostare e subordinare i loro interessi alla preponderante necessità di servire quelli dei proprietari e di coloro che appartengono alla classe dirigente [altro nome per élite). Eppure, per quanto il tema sia stato appunto affrontato, approfondito e anche denunciato, nessuno si ribella (direbbe Marx) e moltissimi votano anzi per gli oligarchi e per negare ancora di più la demo-crazia.
Di più: noi tutti non vedendo che l’élite/oligarchia del potere è oggi anche e soprattutto nella tecnologia e nelle macchine in sé (i.a. compresa), esse governando e governamentalizzando il mondo e la nostra vita, sempre a prescindere da noi. Forse perché la spontaneità organizzata da TikTok, OnlyFans, Netflix o dall’intelligenza artificiale è molto più eccitante della Lambretta.