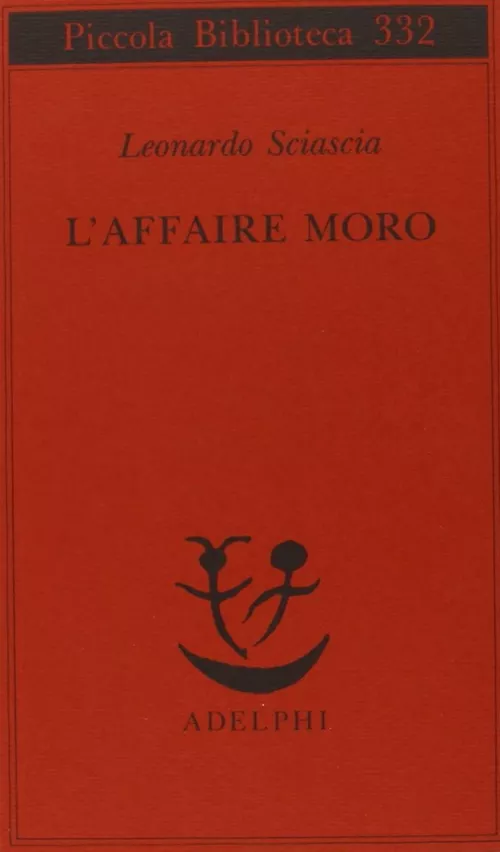Speciale
Sciascia Trenta / L’affaire Moro
Sono trascorsi 30 anni da quel giorno di novembre in cui Leonardo Sciascia ci ha lasciati, trent'anni in cui il paese, che lui ha così bene descritto, è profondamente cambiato, eppure nel profondo è sempre lo stesso: conformismo, mafie, divisione tra Nord e Sud, arroganza del potere, l'eterno fascismo italiano. Possibile? Per ricordare Sciascia abbiamo pensato di farlo raccontare da uno dei suoi amici, il fotografo Ferdinando Scianna, con le sue immagini e le sue parole, e di rivisitare i suoi libri con l'aiuto dei collaboratori di doppiozero, libri che continuano a essere letti, che tuttavia ancora molti non conoscono, libri che raccontano il nostro paese e la sua storia. Una scoperta per chi non li ha ancora letti e una riscoperta e un suggerimento a rileggerli per chi lo ha già fatto. La letteratura come fonte di conoscenza del mondo intorno a noi e di noi stessi. De te fabula narratur.
Non è facile rileggere oggi L’affaire Moro di Sciascia, il più cupo, il più terribile (e forse il più bello) dei suoi libri, quello che ad ogni rilettura ci fa toccare un nervo scoperto della nostra storia, in cui ritroviamo intatto il peso dell’aria che abbiamo respirato nella nostra infanzia. Lo abbiamo letto e riletto per cercare di capire quello che a suo tempo, in quegli indimenticabili giorni racchiusi tra il 16 marzo e il 9 maggio 1978, non eravamo riusciti a decifrare con lucidità, tuttavia pur di fronte all’acuta e intransigente intelligenza del racconto di Sciascia ci pare che rimanga intatto il grumo irrisolto che avevamo percepito ascoltando il telegiornale e i discorsi degli adulti. Il libretto in cui lo scrittore propone il resoconto e il suo giudizio di quel che è accaduto nella fatidica primavera del ’78 non sembra oggi importante soltanto per l’analisi politica del caso Moro in sé (ci sembra oltretutto di concordare con le posizioni meno radicali e appassionate di altri scrittori), ma per il metodo e le questioni che solleva e che riguardano altri nodi cruciali quali, in primo luogo, il ruolo degli intellettuali e la funzione della letteratura di fronte alle urgenze della realtà.
Non si può comprendere fino in fondo il rovello nascosto fra le pagine dell’Affaire che inquieta Sciascia sul valore e la funzione della scrittura letteraria di fronte alla politica, e in particolare di fronte allo scenario devastato di quegli anni Settanta, senza retrocedere indietro di almeno un anno, e senza dare uno sguardo alla polemica sul Coraggio e viltà degli intellettuali (questo il titolo del libro, curato da Domenico Porzio per Mondadori nel novembre del 1977, che raccoglie gli articoli apparsi sui quotidiani dai primi di maggio dello stesso anno). Nella primavera del ’77 la querelle su intellettuali e terrorismo aveva animato le pagine dei giornali a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Montale nel corso di un’intervista (apparsa sul “Corriere della Sera” il 5 maggio) a proposito della diserzione dei giudici popolari nei processi contro le Brigate Rosse, motivata da una paura che il poeta afferma di condividere (alla domanda «Se fosse stato estratto il suo nome, avrebbe accettato di fare il giudice popolare?», Montale risponde: «Credo di no. Sono un uomo come gli altri e avrei avuto paura come gli altri»). Contro Montale intervengono molti intellettuali e scrittori (Arbasino, Bobbio, Calvino, Ginzburg, Sanguineti, Testori, soltanto per citare alcuni nomi), Sciascia è uno dei pochi a sostenere invece il diritto alla diserzione. Il 12 maggio sulle pagine del “Corriere” spiega le ragioni della sua posizione, che sono di due ordini: «di principio» («non mi sento di giudicare, per qualsiasi delitto abbiano commesso, i miei simili – pur riconoscendo la necessità che siano giudicati»), e per così dire contingenti, legate cioè al giudizio politico espresso sul momento presente: «Vengo alle motivazioni […] per cui non vorrei entrare in una giuria – e specialmente una giuria chiamata a giudicare quelli che si usano dire delitti contro le istituzioni, contro lo Stato.
Così come non capisco che cosa polizia e magistratura difendano – e l’ho già scritto altrove – ancor meno capirei che io, proprio io, fossi chiamato a fare da cariatide a questo crollo o disfacimento di cui in nessun modo mi sento responsabile. Salvare la democrazia, difendere la libertà, non cedere, non arrendersi – e così via, coi titoli che vediamo ad ogni avvenimento tragico accendersi sui giornali – sono soltanto parole. C’è una classe di potere che non muta e che non muterà se non suicidandosi».
Questa posizione attira su di lui attacchi e rimproveri a cui risponde, di volta in volta, precisando il suo giudizio, rivendicando in ogni momento il diritto alla critica e all’esercizio della libertà di pensiero, e assumendo quella postura corsara che pochi anni prima era stata di Pasolini, solo contro tutti nella querelle sull’aborto o sulla “nuova gioventù”. Già questo primo elemento che emerge con chiarezza nella primavera del ’77 basterebbe a spiegare il senso dell’incipit dell’Affaire, in cui – in quella che giustamente è stata definita «una delle più belle pagine della letteratura italiana degli ultimi trent’anni» (Belpoliti, L’Affaire Moro: anatomia di un testo, 2002) – Sciascia si rivolge a Pasolini, rimandando al controverso e famoso articolo corsaro sulla scomparsa delle lucciole, alle sue intuizioni su Moro, al “processo al Palazzo” avviato dall’autore di Petrolio e da lui ripreso anche in quelle pagine (dopo Il contesto e Todo modo). Ma nella polemica del ’77 c’è di più, ci sono cioè ragioni ben più profonde che accomunano Sciascia e Pasolini (anche ad altri scrittori e scrittrici che si schierano su posizioni opposte).
Se nel primo articolo Sciascia cita i titoli dei giornali divenuti slogan e li demolisce affermando che «sono soltanto parole», così in quelli successivi per ognuno dei lemmi-chiave della polemica («coraggio» e «viltà», in primo luogo) si impegna a ritracciare il significato originario, costruendo la difesa della sua posizione con la sola arma del dizionario («in questo articolo farò qualche volta uso del dizionario»), affermando che «la scienza della parola resta ormai la più attendibile» (Del disfattismo, della carne e di altre cose, «La Stampa», 9 giugno 1977), applicando con pazienza la sua intelligenza ad analizzare e decostruire le argomentazioni di chi lo accusa ora di «disfattismo» ora di «nicodemismo». Come Natalia Ginzburg, che sta però sul fronte opposto al suo pur rivendicando anche lei quale ruolo primario degli intellettuali il compito di «non travisare e non tradire la verità delle parole» (Intellettuali, tutti a casa per parlare di coraggio, “Corriere delle Sera, 24 giugno 1977), anche Sciascia ritiene che il mandato dell’“uomo di lettere” sia quello di vigilare sul senso e sul significato delle parole, smarrito nella bolla mediatica della comunicazione giornalistica. E fra quelle parole anche l’etichetta di intellettuale gli sta stretta: «Ho passato il pomeriggio del sabato nella lettura del Saggio sui rapporti tra intellettuali e potenti di D’Alambert: aureo libretto che Einaudi pubblica con assoluta tempestività. Infastidito come sempre, dalla parola “intellettuali”, mentalmente ripristinavo nel titolo e nel testo originale “gens de lettres”. Voltaire, Diderot, D’Alambert si dicevano “uomini di lettere”.
Perché chiamarli “intellettuali”?» (Se dissenti, io ti spingo a sinistra, “La Stampa”, 19 giugno 1977). È forse proprio il richiamo alla materialità della parola a fargli preferire il termine letterato, che a sua volta rimanda proprio attraverso il vocabolario alla letteratura, alla suprema forma di conoscenza che lo scrittore celebra fra le righe dell’Affaire, che fra le altre cose contiene la più complessa ed enigmatica espressione della teoria della letteratura formulata da Sciascia (si veda a tal proposito Belpoliti, L’Affaire Moro: anatomia di un testo, 2002).
Benché, infatti, il testo si offra nella sua forma come un pamphlet d’invettiva politica, in cui lo scrittore propone la sua personale interpretazione del j’accuse alla classe politica del suo tempo, la profonda stratificazione intertestuale su cui si fonda tutta la sua argomentazione mostra la complessità generale del testo che agisce a tutti i livelli. In altri termini la letteratura è al tempo stesso filtro per l’interpretazione dei fatti, mezzo e forma del loro racconto, oggetto della riflessione sciasciana. Proviamo a grattare alcuni strati del palinsesto che costituisce l’Affaire.

Il rimando a Pasolini serve a Sciascia per delineare la condizione di contrappasso dantesco in cui si trova Moro nei mesi della prigionia: «il meno implicato di tutti» è definito negli Scritti corsari, eppure, «per una enigmatica correlazione» è anche riconosciuto come autore «di un linguaggio completamente nuovo» (Il vuoto del potere in Italia, “Corriere della Sera”, 1 febbraio 1975), vuoto, che sfiora il non senso e che è finalizzato soltanto alla conquista del consenso. Per Sciascia la tragedia di Moro è tutta interna a questo linguaggio di sua invenzione attraverso cui dovrà provare a comunicare dalla prigione del popolo («ha dovuto tentare di dire col linguaggio del nondire»). I «sintomi» linguistici di cui parla ossessivamente Pasolini in tutta la sua scrittura saggistica culminano dunque nel dramma fatto di parole del caso Moro, che si configura in primo luogo come un’attenta lettura filologica delle lettere inviate dal Presidente della DC nei mesi della sua prigionia. E anche in questo caso «la scienza della parola risulta la più attendibile» per destreggiarsi in mezzo al fuoco incrociato dei messaggi di Moro, delle BR, dei politici e del sistema mediatico che mette in scena questo teatro della menzogna. Anche in questo caso, Sciascia brandisce l’arma del dizionario («sto scrivendo queste pagine sull’affaire Moro in un mareggiare di ritagli di giornali e col dizionario del Tommaseo solido in mezzo come un frangiflutti») e passa in rassegna le parole-avvenimenti, che dalla mistificatoria definizione del protagonista come «grande statista» («uno di questi piccoli avvenimenti è nell’affaire Moro l’espressione “il grande statista” che ad un certo punto sostituisce il nome di Moro») giungono fino alla «spaventosa parola» “potere”, citata da Moro in una delle ultime lettere in cui dichiara di non volere al suo funerale «”gli uomini del potere”», fino a quel gerundio presente nel comunicato delle BR che dichiara la sentenza di morte dell’imputato e a cui resta appesa nel finale della tragedia la vita di Moro («”Concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato»).
Ma la letteratura fornisce a Sciascia numerose lenti di ingrandimento per mettere a fuoco i dettagli del caso. Se gli Scritti corsari di Pasolini permettono di leggere le «enigmatiche correlazioni» fra l’invenzione del linguaggio di Moro e la sua condanna a comunicare con il «linguaggio del nondire», suggerendo dunque la prospettiva filologica, il Pierre Menard di Borges lascia emergere la dimensione metanarrativa dell’Affaire. Secondo Sciascia infatti la vicenda di Moro è già un romanzo che lui può soltanto riscrivere proprio come il personaggio borghesiano ricopia il Chisciotte, accorgendosi entrambi poi che, pur adoperandosi nella trascrizione fedele dell’originale, qualcosa muta e si trasforma. Il caso Moro è già opera letteraria perché sembra «generato da certa letteratura » (dagli scritti di Pasolini e dello stesso Sciascia), perché dunque è solo la letteratura che può svelare il senso della tragedia del personaggio Moro, della sua solitudine, incisa nel suo volto (come rivela la lettura sciasciana delle sue fotografie e della sua storia) ben prima del rapimento. Tutto L’affaire è dunque un complicato palinsesto da decifrare, tradurre, rileggere e riscrivere con la scienza e l’arte della parola.
La reminiscenza di Poe, per citare ancora qualche altro importante filtro letterario, invita l’autore ad adottare come paradigma della sua detection quello dell’immedesimazione, sia nella parte di Moro che in quella dei suoi carcerieri, per scoprire che forse è proprio «quella invisibilità dell’evidenza di cui Dupin discorre nel racconto La lettera rubata» a permettere di decrittare i messaggi contenuti nelle lettere del prigioniero. È in virtù di questa immedesimazione che lo scrittore commenta e interpreta parole e omissioni del prigioniero e dei suoi carcerieri, trasformando il pamphlet in tragedia, la «tragedia di un uomo» come intuì chiaramente Calvino (Moro ovvero una tragedia del potere, “L’Ora”, 4 novembre 1978).
La filosofia pirandelliana (ecco un altro rimando letterario che agisce potentemente per comprendere «la tragedia del potere») consente a Sciascia di riconoscere la parabola sacrificale del protagonista: «Moro comincia, pirandellianamente, a sciogliersi dalla forma, poiché tragicamente è entrato nella vita. Da personaggio a “uomo solo”, da “uomo solo” a creatura: i passaggi che Pirandello assegna all’unica possibile salvezza». Ma la stratificazione delle citazioni è molto più ampia e complessa di quanto si possa immaginare da questi esempi. Del resto, Sciascia è perfettamente consapevole che nel ri-scrivere il romanzo della realtà e nel glossare e correggere il racconto mistificato della macchina mediatica che tende a delegittimare Moro, affermando che le lettere sono state scritte da lui in una condizione di coercizione e sono dunque il risultato, a loro volta, di una falsificazione delle sue posizioni politiche, ricorre a quella che potremmo considerare un’ermeneutica letteraria.
Sciascia, cioè, colma i vuoti («e ci si può fermare su questa ipotesi e immaginare (immaginare, immaginare!)» e qualche pagina dopo «E c’è da immaginare (ancora da immaginare) che scatti da questo momento di decisione […]»), “traduce” il dire e il nondire di Moro e di tutti i personaggi della tragedia e se è cosciente di mescolare storia e invenzione («E può darsi che si stia, qui, facendo un romanzo») è in virtù del suo essere un intellettuale, un uomo di lettere, che – come afferma Pasolini nel suo Romanzo delle stragi – «cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero» (Che cos’è questo golpe? Io so, “Corriere della Sera”, 14 novembre 1974).
Un alto tasso di «arbitrarietà», di «follia» e di «mistero», però, continuano a permanere fino alla conclusione dell’Affaire, che Sciascia chiude, lasciando aperta la domanda di verità e di giustizia fino all’ultima riga con una citazione delle Ficciones di Borges, e con un invito che risuona fino a noi, a quel «“lettore inquieto”» che capisce dal dettaglio di una frase insensata che la soluzione del romanzo poliziesco è sbagliata e «“rivede i capitoli sospetti e scopre un’altra soluzione, la vera”».