Dialettica e storia di un'idea filosofica / La questione della bellezza
Ha ancora senso parlare di bellezza in quanto idea filosofica? O il ‘secolo breve’ e ora quello appena iniziato hanno dato a questa nobile invenzione dello spirito una definitiva sepoltura ritenendola un esercizio della memoria nostalgica più che una chiave di lettura del contemporaneo?
Si sarebbe inclini a pensare che la stessa questione della bellezza, ossia l’interrogarsi sul suo fondamento, se essa sia cioè espressione di una realtà o verità che trascende il perimetro dell’umano oppure un mero fenomeno soggetto alla decadenza, rappresenti un problema che appartiene a una stagione ormai passata della ricerca filosofica. E in particolare dell’estetica: il bello, già a partire dal circolo romantico di Jena, ha cessato di essere la categoria centrale dell’arte e, al più tardi con le avanguardie del Novecento, con la svolta modernista e l’avvento della musica dodecafonica, chi parla di bellezza e della sua rappresentazione appare più un Don Chisciotte che un esegeta del suo tempo.
Eppure il discorso pubblico, l’opinio communis, giornali e media assegnano alla bellezza una centralità evidente: di bellezza non si è mai parlato tanto come da quando entertainment e cosmetica, social network e beauty farm hanno colonizzato l’immaginario di milioni di persone e fatto crescere esponenzialmente i profitti dell’industria che di questa ipnosi di massa è la prima beneficiaria.
A riportare ai suoi termini storici la questione della bellezza, ripercorrendone i momenti di svolta a partire dall’antichità greca, da Platone alla genesi del Moderno e alla sua estesa teorizzazione nell’età di Kant e Hegel fino al Novecento di Adorno ci pensa un libro breve ma di sorprendente lucidità diagnostica uscito recentemente da Einaudi, di cui è autore il filosofo Gianluca Garelli (La questione della bellezza. Dialettica e storia di un’idea filosofica, 178 pp., 22 €).
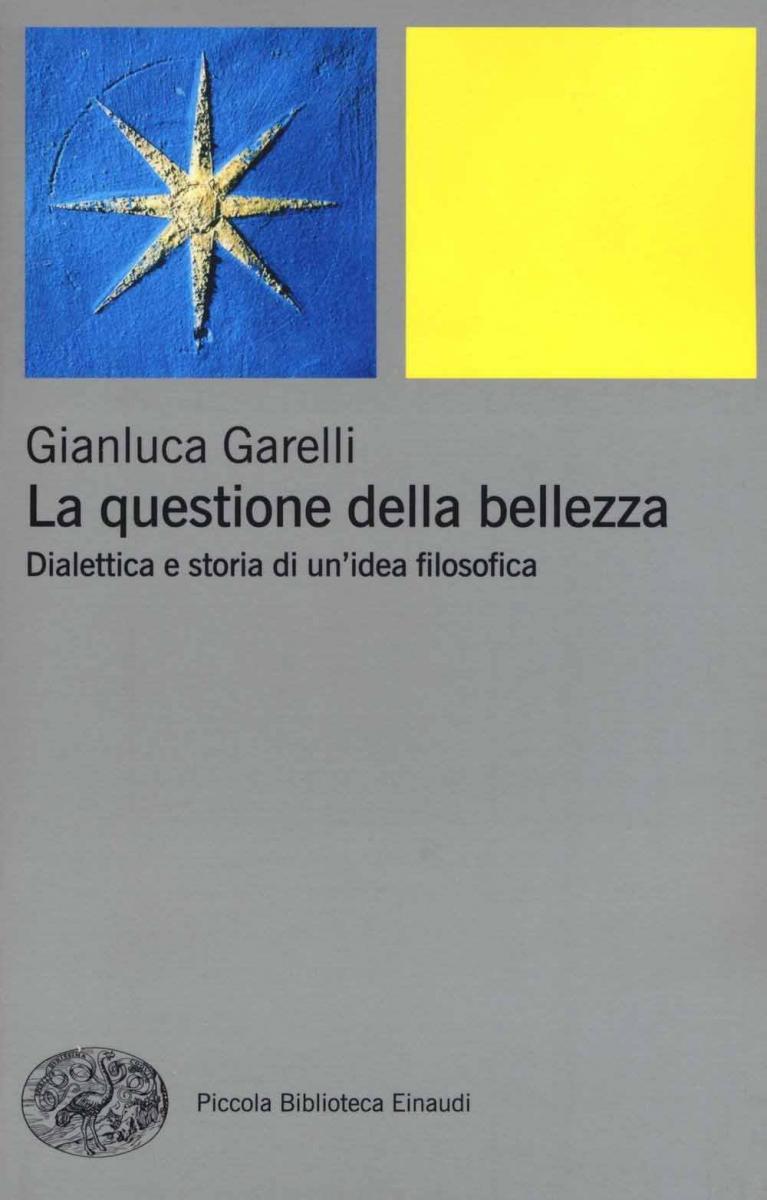
La questione della bellezza. Dialettica e storia di un'idea filosofica, G. Garelli.
Ciò che colpisce di questa mappatura del bello è la visione della sua natura anfibia: l’essere la bellezza un’idea filosofica e insieme un fenomeno della fruizione collettiva inserito quindi in un circuito della comunicazione dove i giudizi del singolo non si devono giustificare dinanzi al ‘tribunale della ragione’ ma nell’arena caotica delle opinioni e nella Babele delle preferenze.
Garelli dimostra chiaramente come la questione della bellezza sia fin dalla sua origine un terreno in cui verità e passione, logos e aistesis sono inestricabilmente intrecciati e solo il confronto dei punti di vista e la relativizzazione dei giudizi possono rendere giustizia a questa strana e affascinate caratteristica dell’esistente che si chiama bellezza.
Nella ricostruzione di quest’idea non c’è fortunatamente nel libro di Garelli alcuna tentazione sistematizzante o vagamente manualistica: il passato è osservato implicitamente dalla sponda del contemporaneo e il contemporaneo con la consapevolezza del tragitto storico che ha condotto ad esso. Questo toglie alla trattazione l’aspetto asettico e impersonale del manuale e le conferisce, per lo meno a tratti, la vertigine del saggio ivi compresa la sua inevitabile parzialità.
La stessa parzialità emotivamente engagé che si legge nei versi di Saffo: “Uno dice che un esercito di fanti, altri di cavalieri, altri di navi, è la cosa più bella sulla terra nera, io ciò che si ama”. La bellezza è per Saffo l’oggetto del desiderio. Per il Platone del Simposio è invece la scala amoris che dal desiderio si eleva progressivamente verso la contemplazione disinteressata del “bello che è presente nelle anime rispetto al bello che è presente nel corpo” e giunge infine a vedere “la bellezza delle conoscenze”.
La bellezza, il kalón, nell’Ippia maggiore si espone tuttavia a un’ulteriore fondamentale contraddizione: da un lato esso è accordo armonico fra le parti che lo costituiscono ma dall’altro – e questo è il rimprovero di Ippia a Socrate – l’acribia con cui il maestro scompone in frammenti l’insieme produce una singolare eterogenesi dei fini: volendo vedere la perfezione dell’insieme finisce per frantumare il tutto: “Socrate – esclama Ippia – tu non guardi le cose nella loro interezza” e il risultato che ne deriva sono “Lacerti… scampoli di discorso divisi in piccoli pezzi” (p. 53).
 Ph Murray Fredericks.
Ph Murray Fredericks.
Lo strano destino della bellezza è che la sua identità non è mai granitica certezza ma condizione perennemente dialettica: l’armonia è correlata alla disarmonia, la compiutezza alla dispersione, la totalità al frammento. Questo fondamento aporetico trova la sua ricomposizione soltanto in una metafisica come quella di Plotino o nel grande romanzo storico della trasformazione del mondo che è la Fenomenologia dello spirito di Hegel. “Donde irradiò la bellezza della tanto contesa Elena e di tante altre donne comparabili ad Afrodite?” – si chiede Plotino nelle Enneadi – e conclude: “Non si tratta in ogni caso di un’idea che dal creatore scese nella creatura…?”
Ma con la fine della metafisica e il definitivo ‘disincantamento del mondo’ anche la bellezza perde il suo tetto trascendentale e si rifugia nel dettaglio e nel frammento disperso. Se un Dio ancora esiste, non abita più nella perfezione apollinea della forma ma tra gli straccivendoli di Parigi cari a Baudelaire o nelle briciole che un’annoiata Madame Bovary allontana dalla sua tavola con un gesto stanco della mano. Se “il buon Dio vive nel dettaglio” come affermerà Aby Warburg, nella tarda Modernità la luminosa perfezione dell’artefatto artistico non meno della pretesa della critica di porre il mondo in prospettiva si rivelano necessariamente una menzogna.
L’esito estremo che il rovesciamento del paradigma della bellezza subisce nel Novecento ha tuttavia una serie di antefatti, su cui il libro di Garelli non si sofferma e che si collocano nella stessa Goethezeit nella quale si svolge la vicenda hegeliana, questa sì abbondantemente e ottimamente analizzata dall’autore. A fine Settecento il giovane Friedrich Schlegel, impegnato a tracciare la fisionomia estetica dell’Antico e del Moderno, dirà di Amleto: “Il suo animo mi sembra come un corpo lacerato in direzioni contrapposte sul banco della tortura, va in pezzi e soccombe nel traboccare di energie intellettuali eccessive e inutilizzabili (…)"
La frantumazione dell’eroe moderno è il contrario della compostezza classica, la sua vicenda mette a nudo un mondo che non solo ha perso il senso del divino ma che stenta a trovare un significato nella vita. Il bello dunque, come dirà Adorno nei Minima moralia, è qualcosa di cui è bene diffidare: è una falsa promessa di felicità, fondamentalmente anacronistica e fatalmente ideologica da quando la sostanza etica del mondo si è trasformata nella legge del profitto.
Il libro si conclude con l’efficace contrapposizione del monito socratico: “le cose belle sono difficili” all’esclamazione sgomenta di Rilke nella prima delle Elegie duinesi: “(…) poiché del terribile il bello non è che il principio”.
In definitiva la bellezza è bene che rimanga una soglia estrema, inarrivabile, oltrepassarla potrebbe essere assai rischioso.
Questo testo è già uscito sul Manifesto del 26/06/2016.









