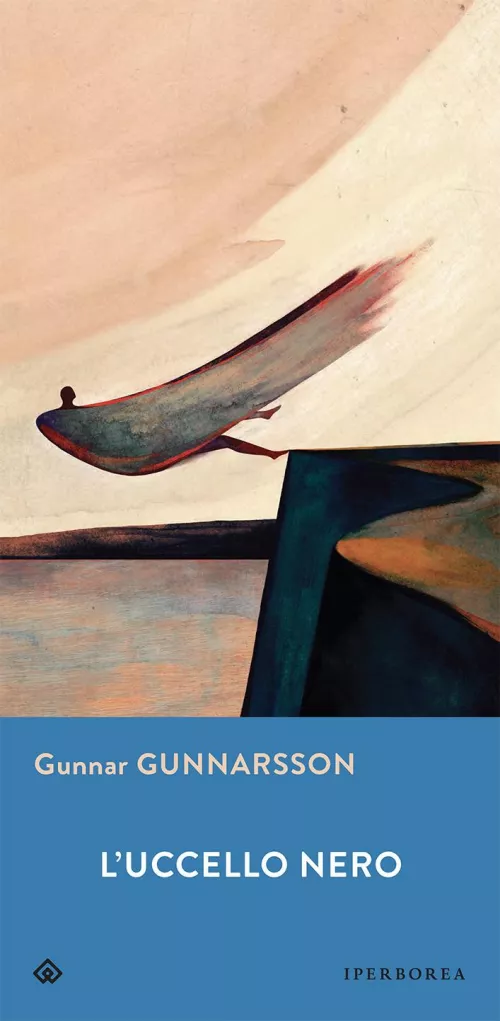Delitti in Islanda / Gunnar Gunnarsson, L'uccello nero
Siamo nel diciannovesimo secolo, più precisamente nel 1802. Nel villaggio islandese di Syvendeaa in una fattoria isolata vivono due coppie: l’energico e forte Bjarni con la cagionevole e lamentosa Guðrun, il rozzo ed insignificante Jón con la bella e fascinosa Steinunn. Dopo la misteriosa morte di Jón si diffondono le voci di una relazione tra Bjarni e Steinunn, e quando Guðrun sarà trovata morta i due sospetti adulteri diventeranno i principali indiziati di entrambe le scomparse.
A narrare la storia, coinvolto anche come testimone nel processo a carico dei due presunti amanti-assassini, è il giovane cappellano di quella sperduta parrocchia, Eiúlvur. Questi ricorda quei fatti alcuni anni dopo, nel 1817, quando divenuto parroco sta scrivendo un’omelia e cerca di superare lo strazio per la morte del figlio di 15 anni, annegato in mare e nato proprio in quel 1802. Riflette su quella storia ormai lontana che aveva coinvolto la piccola comunità e nella quale egli stesso aveva avuto una parte non marginale quale giovane sacerdote. Avverte quasi un’ombra che lo ha accompagnato in questi anni e questa tragica morte si configura per lui come un dubbio sul suo operato di allora.
Questo romanzo viene presentato come un antesignano dell’acclamato noir nordico, che anche nella lontana Islanda ha validi esponenti come il prolifico Arnaldur Indridasson (La ragazza del ponte, Guanda 2020 tra gli ultimi), Ragnar Jonasson (Notturno islandese, Marsilio, 2021), Viktor Ingolfsson (L’enigma di Flatey, Iperborea, 2012), Vilborg Sigurðardóttir (Il tempo della vendetta, Mondadori, 2019). In effetti le pagine del libro si colorano di giallo e presentano le componenti del paradigma classico, il morto e la sua storia (qui sono due), l’inchiesta e il suo sviluppo per scoprire il colpevole. L’autore infatti dissemina indizi, eventuali moventi, le possibili alternative. Non solo: costruisce un arcaico “legal drama”, cioè un processo che si svolge in una cascina con il giudice e la giuria, l’accusatore e il difensore, con gli imputati che giurano, impostato senza alcuna presunzione d’innocenza ma con quella opposta di colpevolezza, da superare con convincenti prove a difesa. Al di sopra di tutto, l’auspicata prova regina, la confessione. Con la collaborazione, costante ed insinuante, dei rappresentanti della chiesa di qualunque grado, da relatori sulle condizioni dei cadaveri esposti nella chiesa a funzionari durante il processo come scrivani. Per giungere a spalleggiare la giustizia come agevolatori di confessioni.
Ma quel colore giallo in realtà è tenue e rappresenta la cornice della narrazione. Il romanzo si configura infatti come riflessione sui grandi temi del diritto in rapporto con l’uomo, inserendosi a pieno titolo nel moderno movimento che coniuga il Diritto alla Letteratura.
Il vero protagonista è Bjarni, l’amante accusato, che acquista coscienza di sé e dignità oltrepassando il valore della legge. Gli interrogatori davanti al tribunale fanno emergere un dato cruciale, la drammatica inevitabilità degli eventi, rappresentato anche dalla spregiudicatezza del giudice: “Sono quasi giunto alla conclusione che le fantasie e i sospetti cresciuti intorno a questo crimine sono più orribili del crimine stesso. Solo una cosa può cancellare i pensieri cupi e gli incubi che hanno risvegliato. Quei due devono morire! Direi quasi: che abbiano ucciso o no!».
Il giovane cappellano narratore vive un tormentato conflitto interiore, combattuto tra la necessità di dare conforto spirituale agli accusati suoi parrocchiani e la ricerca di una verità che soddisfi la giustizia terrena. Proprio nel confronto dialettico tra questi e il giudice rappresentante della legge si rivela la chiave del romanzo. Cosa è bene e cosa male, fino a che punto la giustizia umana ha diritto di agire e sanzionare chi ha sbagliato? Come può convivere la carità con la fredda durezza della giustizia che non giunge alla profondità dell’anima? Queste sono alcune delle domande che fanno da sfondo al duello morale imperniato sul conflitto tra la consapevolezza del significato della vita con i suoi limiti e la legge con i suoi dettami. È una riflessione che indaga su libertà, giustizia, colpa, pentimento ed espiazione, sui desideri di giustizia, di pietà e di verità, sull’obbedienza alla legge, alla moralità e a Dio. E si arriva a un senso profondo che coinvolge tutti, vittime e carnefici «Ognuno di noi prima o poi, che lo voglia o no, si trasforma in torturatore e assassino. Tutti inchiodiamo alla croce il figlio di Dio! In noi stessi o nel nostro prossimo».
Il tormento del cappellano si radica nella volontà di sconfiggere i pregiudizi a favore della verità, che sia tale sul piano della giustizia, sia essa umana e divina. La fedeltà a questo suo compito lo strazierà (“La verità! Non era anch’essa uno degli avvoltoi neri, rauchi e voraci dell’esistenza? La sua legge non era la stessa che domina sul resto della vita? Procreare e distruggersi…” e lo farà definire da Bjarni “amico terribile”. E la verità, che Eiúlvur intravede dopo un colloquio con Steinunn, trascende gli ambiti del processo: è quella universale dell’impossibilità di sottrarsi al male per quanto compiuto da altri, e di dichiararsi estranei a ogni delitto che avviene nel mondo.

L’uomo, sembra segnalare l’autore, è destinato alla colpa, propria o altrui, alla quale può opporre solo la misericordia: “La lasciai rabbrividendo. C’era nelle sue parole come un presagio funesto. Qualcosa che mi riguardava… Il suo destino – il corso che aveva avuto e che avrebbe avuto in futuro – mi riguardava. Era intrecciato con il mio! Forse i destini di tutti gli uomini erano intrecciati? Ed era cieco chi non lo vedeva? Ottuso chi non lo sentiva? Sì, era così! A un tratto lo capivo. Ed ero lì, in mezzo al buio minaccioso e infinito, in mezzo al sangue e all’orrore, al martellio assordante di cuori traviati…”.
L’uccello nero, già apparso in Italia nel 1936, era stato scritto nel 1929 acquisendo una certa notorietà grazie a Hemingway che aveva dichiarato di considerarlo una delle sue letture favorite, tanto da esservisi ispirato per Il vecchio e il mare. L’autore, Gunnar Gunnarsson, vissuto dal 1889 al1975 e plurinominato al Nobel, è uno dei grandi nomi della letteratura islandese. Ha avuto gran successo con le prime opere perché facevano trasparire un che di esotico, una terra remota e magica, quasi la contemplazione di un luogo mitizzato. Ad esempio Storia della famiglia di Borg del 1912 (tradotto da Sansoni nel 1943) denuncia il desiderio di tornare a un mondo naturale destinato a scomparire per la modernizzazione. Sono intervenuti poi romanzi della crisi, quando quel quadretto d’idillio pastorale s’incrina e subentra la perdita della speranza, l’apparire dei turbamenti del male. Nel 1920 esce Salige er de enfoldige (Beati sono i semplici, in inglese Seven Days’ Darkness,McMIllan, 1930), ricordato da chi ne auspica una prossima traduzione italiana (Zironi, “Di peccati veniali, mortali e di una piccola indulgenza.
Beati sono i semplici”, Insula europea, maggio 2020). In Islanda l’influenza spagnola si propaga dal 1918, quasi in contemporanea con l’eruzione del vulcano Katla, e il romanzo coinvolge un io narrante, Jón Oddsson, che rammenta le vicende dell’amico Grímur Ellidagrímur, medico impegnato a contrastare la pandemia. Lo scritto si fonda sul progressivo smarrimento del dottore nei confronti di un nemico implacabile ed anche di un altro virus che si insinua nella sua vita matrimoniale, il corteggiamento della moglie da parte di un’antica fiamma. Grímur è sempre più sospettoso, geloso di un possibile tradimento anche perché cresciuto nelle certezze del progresso, nella convinzione che l’uomo plasmi i propri destini: “… viviamo e creiamo, silenziosi e indipendenti, come ciò che già siamo… come se fossimo i signori della creazione”. Esperienza ignota è l’incontrollabile propagarsi della malattia che mette in discussione chi siamo, il nostro ruolo nel mondo, cui si unisce l’insicurezza, il senso di sconfitta, il sentirsi inadeguati rispetto agli eventi. Intanto Grímur prodiga cure a persone stremate, ma è sconfitto, crolla, si rende conto di perdere la ragione e si fa rinchiudere in manicomio, forse per sempre.
Nel 1925 esce Navi nel cielo (tradotto da Bompiani nel 1943) in cui finiscono gli anni della pittura di un’Islanda armoniosa per affrontare la lotta del presente, nella melanconia dei tempi perduti. Nel 1929 esce il nostro L’uccello nero, certamente non festoso ma anch’esso inquieto e tormentato, ed infine nel 1936 Il pastore di Islanda (Iperborea 2016) che decreta il sopravvento di una natura ostile e matrigna. In quegli anni Gunnarson trova spazio editoriale nella confinante Germania, che lo trascina nel gorgo nazista aderendo alla Lega Nordica con cui Hitler vagheggia di rinsaldare la matrice identitaria germanica e pagana nordica. Allo scoppio della guerra ritorna nei suoi paesi, ma la colpevole cedevolezza lo condanna all’oblio, e i suoi stessi conterranei sono imbarazzati e non parlano di quel periodo.
L’evoluzione narrativa di Gunnarsson merita attenzione perché l’Islanda, oggi celebrata nelle cartoline turistiche, è stato un paese povero, popolato nelle campagne da stamberghe di torba in cui gli abitanti dormivano accalcati accanto agli animali. Non a caso Leopardi inserì, quale interlocutore della natura matrigna, un islandese nelle Operette morali (“Dialogo della natura e di un islandese”), perché rappresentava una popolazione da secoli eroicamente presente in un luogo in cui la natura è nemica dell’uomo, o anche solo gli è indifferente.
Forse Leopardi, di certo non viaggiatore, fu impressionato da “La storia di Jenni o il saggio e l’ateo” di Voltaire in cui si racconta di quel popolo che vive lassù, in un paese eccentrico, tra freddi e fuochi vulcanici, in condizioni quasi estreme, nella convulsione di forze fisiche. L’uccello nero contribuisce ad incrinare gli stereotipi mostrando un’Islanda autorevole ed autoritaria. Nello sfondo il paesaggio islandese è scabro, l’ambiente privo di distrazioni e di ripari, i personaggi sono intrappolati nella fissità delle loro convinzioni e dei loro destini. I grandi spazi, assieme ai ritmi lenti e uguali della natura, in qualche modo incarnano agli occhi di Eiúlvur il significato di colpa e responsabilità, nucleo dei suoi struggimenti. “A vedere le mucche che avanzavano nel gelo e nella neve mi si strinse il cuore, e quelle pecore che si trascinavano avanti avevano qualcosa di precario e malinconico, come se insieme a loro si allontanassero per sempre, da Bjarni e da Syvendeaa, gli ultimi resti di quello che era stato una casa e una speranza. E io, che le guardavo passare, non avevo forse una parte decisiva in quanto stava accadendo? E quel che era peggio: potevo assolvermi dal senso di colpa per gli eventi oscuri e misteriosi per cui ora le bestie di Bjarni mi passavano davanti in una direzione, mentre lui, privo della sua libertà, veniva portato via”. Comprimari alla storia sono quei pezzetti di terra con una manciata di case dove i prezzi si calcolano in pelli di foca, dove in tavola si servono uova di sterna, dove le notizie dal mondo arrivano scolorite, dove la vita è immutabile. Un piccolo mondo fuori dal tempo, quasi "preumano" come notava il viaggiatore Manganelli, in quanto l'individuo si trova in un ambiente "scostante, dalle forme discontinue ed estreme" (L’isola pianeta, Adelphi, 2006). Un paese però che non si sfinisce nel malinconico sguardo all'indietro, ma si corazza per affrontare le sfide contingenti. Non è un caso se la cultura islandese in questi anni affascina come letteratura (alla Fiera di Francoforte del 2011 fu ospite protagonista) e come cinema (il Torino Film Festival del 2011 ha assegnato il primo premio a una sua pellicola).