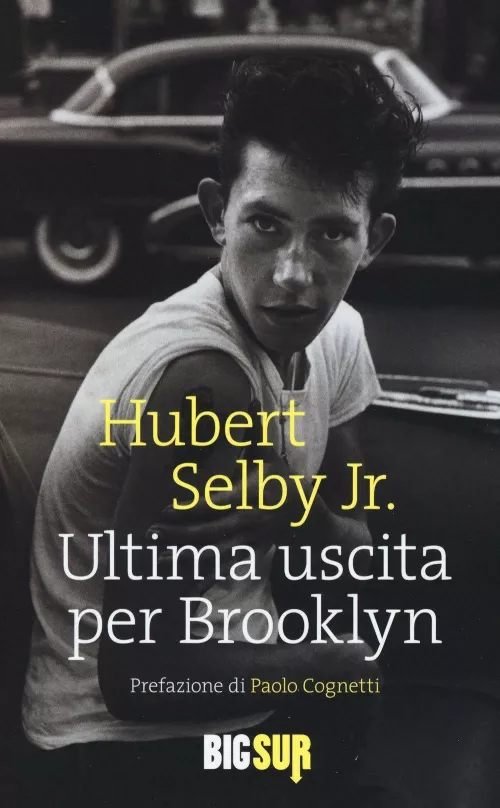Due libri di Hubert Selby Jr. / Il Grande Dolore Americano
Il Grande Sogno Americano, dice Hubert Selby Jr. in un’intervista, consiste nel cercare di evitare il dolore. Ecco perché ti uccide.
I suoi romanzi e la sua vita, invece, il dolore lo attraversano continuamente, ruvidamente, spasmodicamente.
Selby nacque a New York nel ’28, giusto alla vigilia della prima grossa frattura di quel Sogno. Crebbe non lontano dal Ponte di Verrazzano, lasciando una scuola dopo l’altra fino a entrare nella marina con suo padre, a quindici anni. Navigò per alcuni anni finché nel ’47 gli venne diagnosticata la tubercolosi e fu rimandato in America. Tre anni a entrare e uscire dagli ospedali, operato più volte ai polmoni, imbottito di eroina per placare la sofferenza, senza la forza di trovare un lavoro, con l’organismo strapazzato da medicinali. A lungo, poi, restò a casa, spesso confinato a letto, occupato soltanto a crescere una figlia mentre la moglie lavorava ai grandi magazzini.
Sempre ebbe a che fare con la malattia, mai poté essere completamente padrone del suo corpo, o poté avere sotto controllo il proprio futuro, il proprio american dream.
Il mondo intorno a lui, intanto, era quello della Brooklyn post bellica: sopra una middle class vincente, sotto gli altri. Era la Brooklyn di risse senza senso, per trovare un senso, della violenza, degli stupri senza coscienza, un quartiere o città nella città fatta di notti più che di giorni, sporca, violenta, piena di vagabondi e delinquenti, case popolari, abbruttimento, folle di impiegati, fiumi di alcool, treni per Manhattan. È una città di sottosuolo in cui il sogno americano rimbomba dall’alto, lontano, come un monito, schiacciando col tallone chi è già schiacciato dall’esistenza, non troppo diversamente da come oggi l’esempio delle vite stabili e riuscite dei baby boomers schiaccia le generazioni del precariato: prima, o per qualcun altro, il sogno era conquistabile, ora non lo è più, eppure si è costretti ad aspirare a quel tipo di “riuscita”, a quel tipo di sogno ormai anacronistico. In questo magma di sconfitti fioriva una letteratura di ribellione, che scartava dal sogno o ne faceva la radiografia, lo mostrava nudo e brutto e in ginocchio, o se ne partiva verso la west coast a cercare on the road le proprie verità. Erano gli anni dei beat, dell’urlo di Ginsberg, dei vagabondi del Dharma, di una scrittura senza punteggiatura, jazzistica, diretta, urlata.
È in quest’atmosfera che Selby Jr. impara a scrivere scrivendo, quando decide di far fruttare quel lungo tempo passato fra le mura di casa attraverso la letteratura, leggendola e facendola. Qualcosa scatta a ventotto anni quando, durante quella che definisce una “esperienza spirituale”, si rende conto per la prima volta di essere mortale – per quanto già infinite volte i medici gli avessero promesso solo pochi mesi davanti. Capisce che un giorno morirà davvero, che deve fare qualcosa, dare un senso al tempo lungo o breve che gli resta. Decide di diventare scrittore. È un’ossessione, si obbliga a stare ore davanti alla macchina da scrivere ogni giorno e a imparare. Lui che a scuola quasi non c’era andato si prende la libertà della trasgressione, della volgarità, di pagine scritte completamente in maiuscolo, di spelling inventati, di pagine e pagine sbrodolate di dialoghi in cui non è mai specificato chi parla.
Ebbro di questa ossessione, e del mondo duro in cui è immerso, porta nella scrittura il suo linguaggio ruvido, le zone popolari di Brooklyn della fine degli anni ’40, le prostitute, i ladri, i tossici. Ne fa prima un racconto, Tralala, che esce su Black Mountain Review e subisce un processo per oscenità. Nel ’64 lo unisce ad alcuni altri, li lega insieme a modo suo, e ne fa un romanzo, pubblicato negli Stati Uniti da Grove Press, casa editrice «trasgressiva» per eccellenza, che aveva in catalogo Henry Miller, Samuel Becket e William Burroughs.
Ultima uscita per Brooklyn sembra una Spoon River prosaica e brutale. Intorno al “bar del Greco” vorticano personaggi schiacciati da una disperazione a cui non saprebbero dare nome, vinti dallo squallore, ma a tratti ancora colpiti da raggi sporadici di poesia.
C’è Alex, che fuma e sorride dal suo sgabello guardando i clienti avvicendarsi nel suo bar, lasciar scorrere fiumi di birra nel proprio sangue e litri di vita nei canali di scolo. C’è Georgette, la “frocia moderna”, con “i capelli lunghi e modellati con la piastra in stile anni Venti, le unghie curate e lucide, (…) abiti da donna con tanto di reggiseno imbottito, tacchi alti e parrucca e (…) di tanto in tanto, un assorbente”, profondamente innamorata di Vinnie, sempre fatta di marijuana e benzedrina.
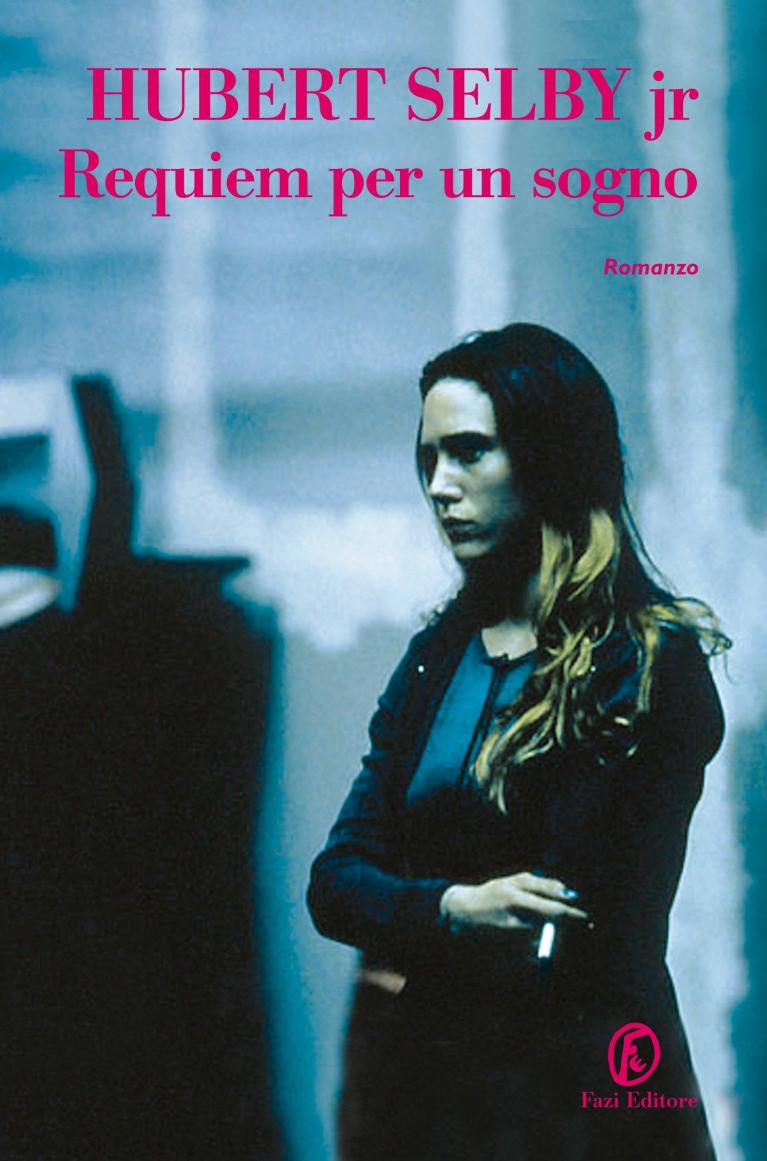
E Vinnie, ladro per vocazione, duro, violento, beffardo, affascinato dalla sfrontatezza di Georgette, intenerito e addolcito da Georgette che in una notte di alcol pasticche e trucco ormai sfatto legge ad alta voce un racconto di Poe. E c’è Spook, che lascia il proprio matrimonio per farsi un giro in moto. E Tralala, che usa il proprio corpo e il proprio seno per soffiare qualche dollaro dalle tasche di tutti gli uomini che la desiderano anche solo per poche ore – Tralala, violentata per una notte intera da tutti gli ubriachi del quartiere sul sedile di una macchina e dimenticata lì, lorda di sangue sperma e avvilimento. E c’è l’operaio Harry, tronfio per la sua buona posizione nel sindacato, incapace di lavorare, di giudicarsi, di ascoltare – Harry che si riempie di birra e che mette la birra sul conto del sindacato, Harry accoccolato ubriaco sotto un tavolo, Harry che tira un pugno alla moglie, che scopre la felicità tra le “frocie” amiche di Vinnie, Harry che Vinnie e i suoi amici e le frocie del quartiere frequentano solo perché ha i soldi del sindacato da spendere, Harry borioso, che la fa sempre franca, Harry talmente disperato da cercare il sesso di un bambino, Harry picchiato, appeso a un palo, insanguinato, spezzato. E ci sono le donne che dal cortile del complesso di case popolari nutrono delle disgrazie altrui le proprie risate amare. E ci sono i bambini che si lanciano l’immondizia, danno fuoco alla posta e giocano agli indiani e ai cowboy “sputando, imprecando, guardandosi fisso”; c’è l’odio e la fatica di Mike e Irene e di figli che sfiancano; le urla degli eterni litigi di Vinnie e Mary; i tradimenti di Abraham; e Ada che era stata felice, ma guerra e malattia le hanno portato via quell’unico marito, quell’unico figlio, di quell’unica famiglia che conoscesse l’amore.
Tutti, tutti dormono sulla collina.
Ultima uscita per Brooklyn ricorda il Notre-Dame-des-Fleurs di Jean Genet, che infatti viene evocato da un’amica di Georgette. Ci sono i ladri, le prostitute e gli assassini, l’omosessualità, la malavita, vite ai margini della società tenute su con lo spago come valigie. Ma non c’è il lirismo della scrittura di Genet, non c’è la bellezza abbagliante del sedicenne Notre-Dame-des-Fleurs, non ci sono Nietzsche, la libertà o l’esistenzialismo fra le righe, non c’è la poeticità di una soffitta a Montmartre o della tubercolosi: sono passati 20 anni e non è Parigi, questa è New York. È l’“ultima uscita per Brooklyn” – perché oltre questa desolazione non c’è più nulla. C’è solo un lembo strappato di vita, una goccia ancora di poesia in quest’esistenza ruvida, pidocchiosa, scalcinata. È il sogno americano strappato sotto i piedi della middle class.
Nella prosa del primo Selby Jr. risuona la rabbia. Stupisce scoprire che il suo mito fin da bambino fosse Gandhi: il desiderio di pace o giustizia è talmente frustrato da non lasciar spazio a nessuna consolazione, catarsi, salvezza. Sembra di sentire il respiro affannato mentre sbatte i suoi personaggi in faccia alla pagina.
Ultima uscita per Brooklyn suscitò ammirazione in personaggi come Allen Ginsberg, sdegno in chi riusciva ad accettare quella crudezza. In Italia fu la Feltrinelli sovversiva e vulcanica di allora a proporlo al pubblico solo due anni dopo.
Requiem per un sogno fu pubblicato per la prima volta nel ’78 ma arrivò in Italia solo nel 2003 per Fazi, in seguito al film di Darren Aronofsky (Requiem for a dream, del 2000).
Qui la rabbia è meno accesa, c’è un distacco maggiore e il periodo storico è cambiato.
Selby racconta quattro vite che si fanno strada attraverso il vuoto nella disperazione. Sara è una donna infelice, immersa nella solitudine: è vedova, il figlio va a trovarla raramente, non ha niente che le riempia la vita se non la tv e il cibo – emblematica vittima della società dello spettacolo e del consumo. Sara, attaccata con le unghie alla carcassa sventrata di un american dream fallito da tempo, sorda alla realtà e completamente incapace di dar spazio e ascolto al dolore, di passarci attraverso e uscirne, riempie il vuoto come può. Un giorno una telefonata la illude di poter partecipare come concorrente a un programma televisivo. Quello sarà il momento del riscatto, tutti la vedranno e la adoreranno, la ammireranno, in ottima forma, nel vestito rosso che aveva usato molti anni prima al bar-mitzvah del figlio. Questa diventa la sua ragione di vita e la sua ossessione.
Per dimagrire e apparire al meglio in tv, comincia una terapia a base di pillole molto simili all’anfetamina.
“Questa cosa mi dà un motivo per alzarmi la mattina. Un motivo per dimagrire e sentirmi sana. Un motivo per entrare nel vestito rosso. Anche solo un motivo per sorridere. Rende tollerabile l’idea del domani. (…) Tutti hanno qualcosa. Ma io cos’ho?”.
Così nell’attesa spasmodica di questo giorno meraviglioso si perde, affonda in un pozzo di follia e smania, sempre più lontana dalla realtà e da se stessa, sempre più magra e paranoica, posseduta dall’anfetamina, dal piacere dei denti che digrignano, fino a trovarsi svuotata, nel suo vestito rosso consunto macchiato usurato, confusa e assente, completamente perduta.
Poco lontano, in un’altra bolla, suo figlio Harry immagina con la fidanzata Marion e l’amico Tyron, di porre fine a tutti i loro problemi comprando e rivendendo eroina: quando avranno messo da parte abbastanza soldi potranno aprire un locale di arte e musica, viaggiare, non avere preoccupazioni. E se nel frattempo qualche ansia si fa sentire, basterà sedarla con un “assaggino”. Zittire il dolore, di nuovo, zittire le preoccupazioni, e poi anche quando si hanno i soldi in mano rimandare il momento in cui si agirà e si andrà incontro ai propri sogni più o meno americani, mai abbastanza concreti da essere realizzabili. È l’eroina questa volta ad allontanare, a rinchiudere ognuno nella propria solitudine e astinenza. Ma a differenza di Sara, i tre giovani hanno ancora la vita davanti, sono capaci di amarsi, di bastarsi, di fantasticare sul futuro.
“Questo non l’ho mai detto a nessuno ma ho sempre voluto aprire un locale tipo caffè-teatro, una roba del genere. Sai no, con delle cose buone da mangiare e dolci e vari tipi di caffè e cioccolata calda e tè da tutto il mondo, Germania, Giappone, Italia, Russia, dappertutto. E potrebbe esserci una specie di compagnia teatrale che fa spettacoli la sera (…). Cioè dopo che il primo comincia a ingranare si potrebbe andare a San Francisco. (…) Marion, ti amo, e lei si muoveva piano lasciandosi andare e si sentiva scorrere dentro le parole e i baci e le sensazioni, un flusso che le lavava via tutti i problemi, i dubbi, le paure, le ansie, e si sentiva calda e viva e vitale. Si sentiva amata. Si sentiva necessaria. Harry si sentiva vero e solido”.
Per questo si è portati come loro a credere che ce la faranno, anche quando, pagina dopo pagina, la dipendenza si fa sempre più schiacciante, persino quando “l’idea di fare soldi non esisteva più, esisteva solo l’interminabile sforzo di trovarne a sufficienza per sé” e loro si fanno sempre più “assorbire dalle fogne in cui passavano sempre più tempo (…) e il loro insaziabile bisogno riusciva a fargli ignorare molto di quello che accadeva, distorcerne dei pezzi, e il resto accettarlo come parte della vita” mentre la città nel gelo dell’inverno si riempiva di tossici in astinenza e cadaveri. Fino all’ultimo si crede che ci sia via d’uscita, che in fondo “loro non sarebbero mai diventati così, che avrebbero fatto qualcosa prima che potesse succedere anche a loro”. Ovviamente non è così, la discesa verso l’inferno non permette inversioni di marcia. E più pensano di sfuggire al dolore e alla realtà, più quella strada si fa a senso unico.
In un’intervista con Ellen Burstyn, l’attrice che interpreta Sara nel film di Aronofsky, Selby sostiene che Sara soffre proprio perché cerca di evitare il dolore. Lo stesso vale, in modo estremamente diverso e completamente uguale, per Harry, Marion e Tyron: e tutti infatti vengono schiacciati. L’unico modo per non soffrire, sembra dire Selby, è immergersi nell’oscurità e accettarla tanto a fondo da poterla comprendere e forse sconfiggere.
In Requiem per un sogno la rabbia non rimbomba come in Ultima uscita per Brooklyn. C’è distacco, e il distacco gli permette una sorta di compassione per questi personaggi che Selby sacrifica per se stesso e per il lettore. In questo modo il romanzo, nella sua oscurità assoluta, diventa latore di una sorta di catarsi: una grotta buia da attraversare, per poter poi uscire dal buio, mentre loro restano esanimi sull’altare di un letto d’ospedale.