Un ricordo / Mario Benedetti. “Scusatemi tutti”
Mario Benedetti non c’è più. Se l’è portato via il virus che ci assedia. Da anni, a causa dell’aggravarsi della sua malattia, era ricoverato in un istituto di Milano, poi – grazie all’affettuoso e generoso interessamento di Donata Feroldi, sua ex compagna, che non ha mai smesso di curarsi di lui – in un altro istituto, a Piadena (Cremona), dove è mancato il 27 marzo 2020. Era nato a Udine nel 1955, ma il suo paese era Nimis, non lontano dalla frontiera con la Slovenia. Nel 1976 si era iscritto alla Facoltà di Lettere a Padova, dove si era laureato con una tesi su Carlo Michelstaedter. Negli anni ’80 aveva dato vita, con Stefano Dal Bianco e Fernando Marchiori, a una rivista di poesia e poetica, Scarto minimo, piuttosto anomala nel panorama di quegli anni.
Ho conosciuto Mario negli anni ’90, quando si è trasferito a Milano. Tutti e due insegnavamo all’Istituto Professionale per il Turismo L.V. Bertarelli, in Corso di Porta Romana; lui al serale, io al diurno. La nostra frequentazione, in realtà, non era legata alla casuale colleganza scolastica: a legarci era la passione per la scrittura, e l’amicizia con Stefano Dal Bianco, anche lui trasferitosi da Padova a Milano. Con loro, e con Donata Feroldi, ci vedevamo abbastanza spesso a casa dell’uno o dell’altro. Mario era una persona molto schiva, apparentemente modesta, ma a me incuteva – non so perché – una certa soggezione. Dietro la sua aria dimessa, dietro il suo sorriso tenue e sornione, nascondeva un’intransigenza non comune, che poteva manifestarsi d’improvviso nel corso di una discussione. Non faceva complimenti, Mario. Sembrava svagato e leggero, ma al momento giusto tirava fuori una durezza senza freni.
“Stare vicini a Mario” – scrive Dal Bianco nel suo intervento introduttivo al volume Tutte le poesie (Garzanti, 2017, uscito per la cura di Antonio Riccardi) – “era sentire una energia che veniva da chissà dove, fredda e compressa e mista di intransigenza, di autentica cattiveria e totale apertura a qualunque possibilità di vita, a qualunque possibilità di pensiero, a qualunque tenerezza e in sostanza del tutto indifesa nel suo puntare all’eccesso di sé. Capivi subito che bastava grattare la superficie di quella corazza per trovare un mare di sofferenza vissuta, niente di coltivato a forza, niente di auto-commiserante”.
Di Mario Benedetti avevo letto e apprezzato le plaquette uscite in quegli anni: I secoli della primavera (1992), Una terra che non sembra vera (1997), Il parco del Triglav (1999). Nei suoi versi mi colpivano gli spasmi sintattici che spezzano il discorso piano, colloquiale. Nelle sue pagine, la lingua ordinaria si deforma impercettibilmente, si strania; come nella poesia Mio padre (da Il parco del Triglav):
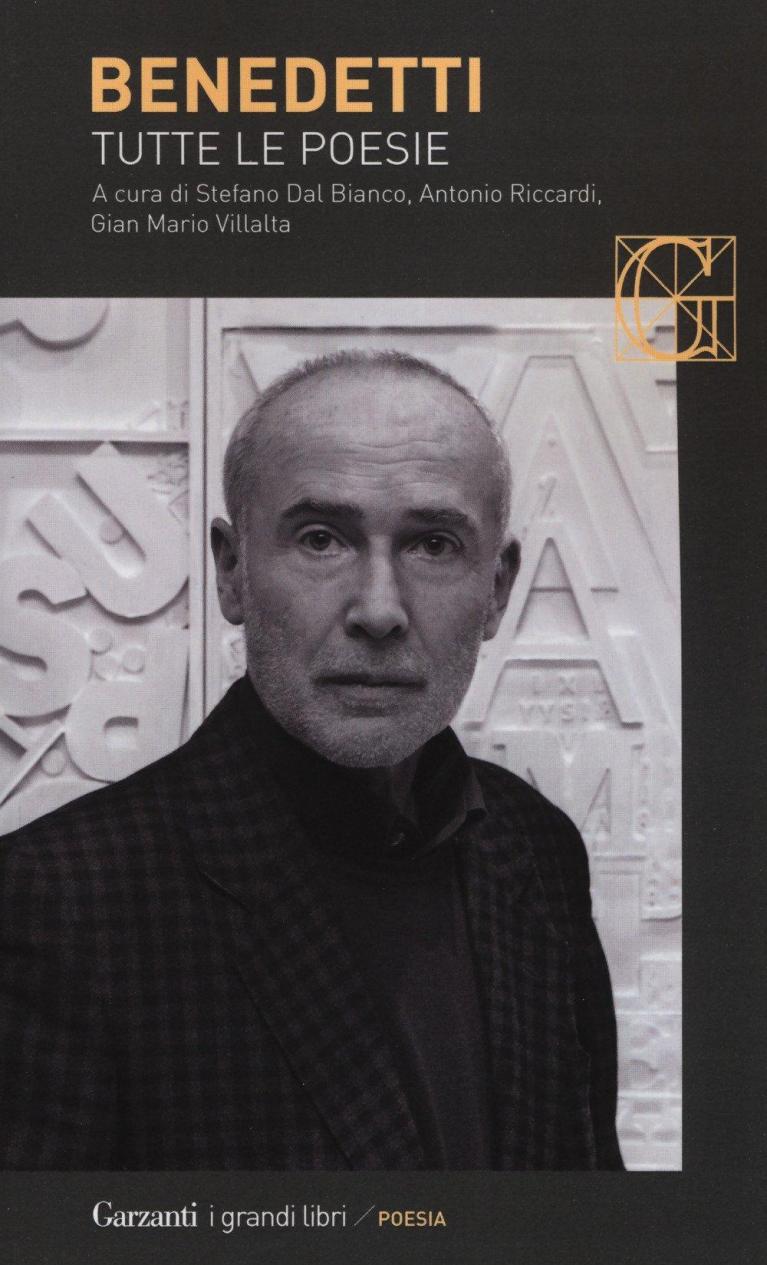
Sta solo fermo nella tosse.
Un po’ prende le mani e le mette sul comodino
per bere il bicchiere di acqua comprata,
come tanti prati guardati senza dire niente,
tante cose fatte in tutti i giorni.
(…)
In questo dettato ostentatamente grigio e ordinario ci sono dei sussulti, dei nessi arbitrari, delle deviazioni improvvise, che sconcertano il lettore non frontalmente ma subliminalmente, aprendo prospettive sottilmente inquietanti. Lo sguardo di Benedetti non si distoglie mai del tutto da quello che chiamiamo realtà, ma è come se mettesse in opera uno strabismo appena percettibile, un clinamen che piega e distorce le cose più familiari e ovvie. Nei libri di Benedetti – parlo soprattutto dei primi – tutto bene o male si capisce; ma è come se a parlare fosse qualcuno che deve riprendere confidenza con la lingua, con il rapporto tra parole e cose, e si muove incerto, pieno di dubbi e di stupore. Un esempio di questa andatura programmaticamente esitante è una delle poesie più note e amate di questo autore, Che cos’è la solitudine, sempre da Il parco del Triglav, ripresa nel 2004 in Umana gloria (Lo specchio, Mondadori), il libro che fa conoscere il poeta a un pubblico meno ristretto.
Che cos’è la solitudine.
Ho portato con me delle vecchie cose per guardare gli alberi:
un inverno, le poche foglie sui rami, una panchina vuota.
Ho freddo, ma come se non fossi io.
Ho portato un libro, mi dico di essermi pensato in un libro
come un uomo con un libro, ingenuamente.
Pareva un giorno lontano oggi, pensoso.
Mi pareva che tutti avessero visto il parco nei quadri,
il Natale nei racconti,
le stampe su questo parco come un suo spessore.
Che cos’è la solitudine.
La donna ha disteso la coperta sul pavimento per non sporcare,
si è distesa prendendo le forbici per colpirsi nel petto,
un martello perché non ne aveva la forza, un’oscenità grande.
L’ho letto in un foglio di giornale.
Scusatemi tutti.
I nessi logici si scombinano, nella pagina di Benedetti; non però con la arrogante arbitrarietà di certa poesia “sperimentale” o “orfica”, ma per una sorta di sistematica – e timida, e parziale – perdita di senso. Che per “guardare gli alberi” siano necessarie delle “cose” è già sconcertante, ma che queste “cose” siano “un inverno, le poche foglie sui rami, una panchina vuota” è davvero spiazzante. Questo sconcerto, questo spiazzamento, Benedetti non li esibisce: li offre umilmente, come un dato plausibile, condivisibile. Anche la scissione del soggetto, cara a tanta poesia del tardo Novecento, si propone senza enfasi, senza intellettualismi, come un’esperienza fra le tante: “Ho freddo, ma come se non fossi io”. La condizione privilegiata del poeta, la sua speciale sensibilità, sono sottoposte a un implacabile understatement: “Ho portato un libro, mi dico di essermi pensato in un libro/ come un uomo con un libro, ingenuamente”. Quello che rende memorabile questo testo, comunque, è il passaggio – del tutto inaspettato, sconnesso – dal morbido flusso elegiaco dell’inizio alla sterzata finale, alla scena terribile (“un’oscenità grande”) della donna che si uccide. Che l’episodio venga riportato “a distanza”, in forma di banale notizia di cronaca nera, letta casualmente su un giornale, non fa che intensificarne l’impatto. A questo si aggiunge la sorpresa – davvero lancinante – di quello “Scusatemi tutti”, che proprio per la sua arbitrarietà, per l’assenza di mediazioni e spiegazioni, si incide nella testa di chi legge.
“Benedetti – scrive Antonio Riccardi nella prefazione a Tutte le poesie, già ricordata – ha messo in gioco la sua vita e la sua scrittura, in un unicum inscindibile. La sua voce chiara, perfino umile ma comunque tagliente, verso dopo verso, pagina dopo pagina, rinnova di mirabile freschezza una vita sofferente, sull’orlo di un buco nero, e ci ricorda la scivolosa instabilità della condizione umana”.









