Giuseppe Pontiggia e la traduzione
Il 27 aprile 1987, al Teatro Verdi di Milano e d’intesa con il Centre Culturel Français de Milan, Giuseppe Pontiggia fu protagonista di «una serata sulla traduzione» (così il sottotitolo), intitolata Bella e fedele. Era allora chiaro il riferimento all’articolo dello scrittore La traduzione bella sì, ma anche fedele, apparso sul «Corriere della Sera» un mese e mezzo prima: il 3 marzo, per la precisione. Non a caso lo stesso articolo era riprodotto nel verso della prima pagina del programma di sala. Il testo sarebbe stato poi inserito – rivisto e corretto e con il titolo Bella, ma infedele – nel volume di prose brevi e aforismi Le sabbie immobili (Bologna, il Mulino, 1991; Premio Satira Forte dei Marmi per la Letteratura, 1992).
Durante quella serata, Pontiggia si era assunto il compito di commentare alcune traduzioni dal francese di Charles Baudelaire e Arthur Rimbaud, apparse in note sillogi italiane delle loro poesie; in particolare si trattava dei componimenti Le balcon, Je n’ai pas oublié, voisine de la ville e La servante au grand coeur dont vous étiez jalouse del primo; e di Sensation, Première soirée e Roman del secondo. Riguardo a Baudelaire, le versioni italiane erano quelle di Luigi De Nardis (Milano, Feltrinelli, 1961), Marco Bonfantini (ivi, Mursia, 1974) e Gabriele Mucchi (Torino, Einaudi, 1979) per Le balcon; per Je n’ai pas oublié, voisine de la ville, di nuovo di De Nardis e di Giovanni Raboni (Milano, Mondadori, 1973 e Torino, Einaudi, 1987); e ancora di Bonfantini e di Raboni per La servante au grand coeur dont vous étiez jalouse. Quanto a Rimbaud, le traduzioni erano – per tutti e tre i suoi testi oggetto del commento – di Ivos Margoni (Milano, Feltrinelli, 1964), Gian Piero Bona (Torino, Einaudi, 1973) e Diana Grange Fiori (Milano, Mondadori, 1975).
Era questo il primo seme del Corso sulla traduzione che Pontiggia avrebbe tenuto dal 5 marzo al 30 aprile 1987 presso lo stesso Teatro Verdi, come abbiamo verificato e ricostruito anche insieme con Laura Bosio e Renata Colorni: proprio una dei traduttori ospiti, «di esperienza e valore collaudati», invitati a parlare del loro lavoro durante le lezioni.
Possiamo qui leggerne ora il programma: inedito e pionieristico. Di fatto si sarebbe dovuto attendere il 31 agosto 1992 per veder inaugurati, nel Palazzo del Lavoro di Torino, i corsi di traduzione della Setl, la prima Scuola europea di traduzione letteraria, istituita da Magda Olivetti.
Pontiggia puntava però a corsi dall’orizzonte comunicativo e formativo più ampio e capaci di muoversi in direzioni molteplici, ma di pari utilità. La prima puntava a che essi contribuissero alla diffusione di una maggiore consapevolezza culturale della questione “traduzione” in generale, la cui qualità media degli esempi – a parer suo – era in calo all’epoca. La seconda mirava a un miglioramento della preparazione degli stessi traduttori e, con ciò, della loro stessa «immagine professionale». Il corso, pertanto, spaziava dalla puntualizzazione dei significati della traduzione ai «ragguagli storici» su di essa, dalle varie tipologie ai «problemi concreti» della traduzione: le disparate modalità traduttive, i codici stilistici da seguire e simili. Né Pontiggia tralasciava di aggiungere anche una lezione sulla figura del traduttore nel senso di chiarirne diritti e doveri, compensi, e i necessari rapporti con editori, giornali, imprese, ecc.: era uno scrittore affermato, un consulente di Adelphi e Mondadori, e conosceva bene i meccanismi e le logiche editoriali, ma anche le difficoltà che, oltre ai successi, si possono incontrare nella pratica con le istituzioni della cultura. Così, con la sua solita generosità illuminata, Pontiggia metteva a disposizione di chi volesse giovarsene il risultato delle proprie esperienze, ed educava anche al modo di fronteggiare eventuali frustrazioni, invitando a rovesciarle a trasformarle in maniera produttiva in occasioni di crescita intellettuale e professionale.
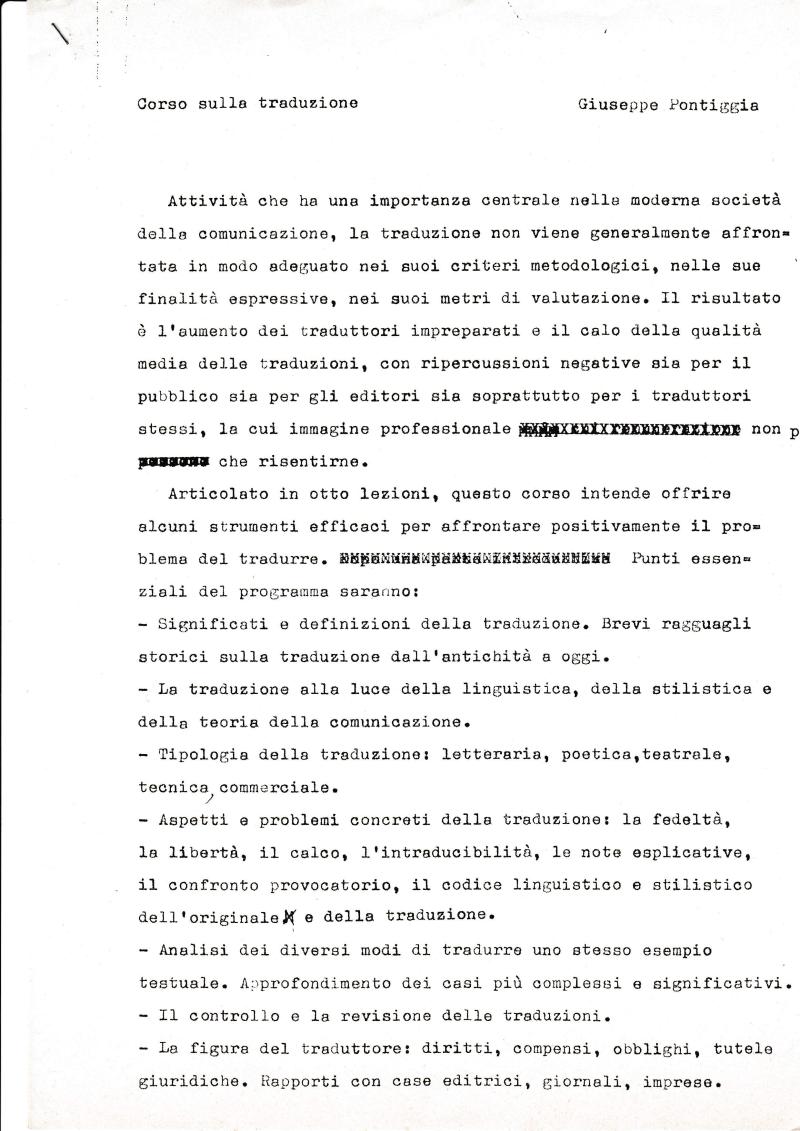
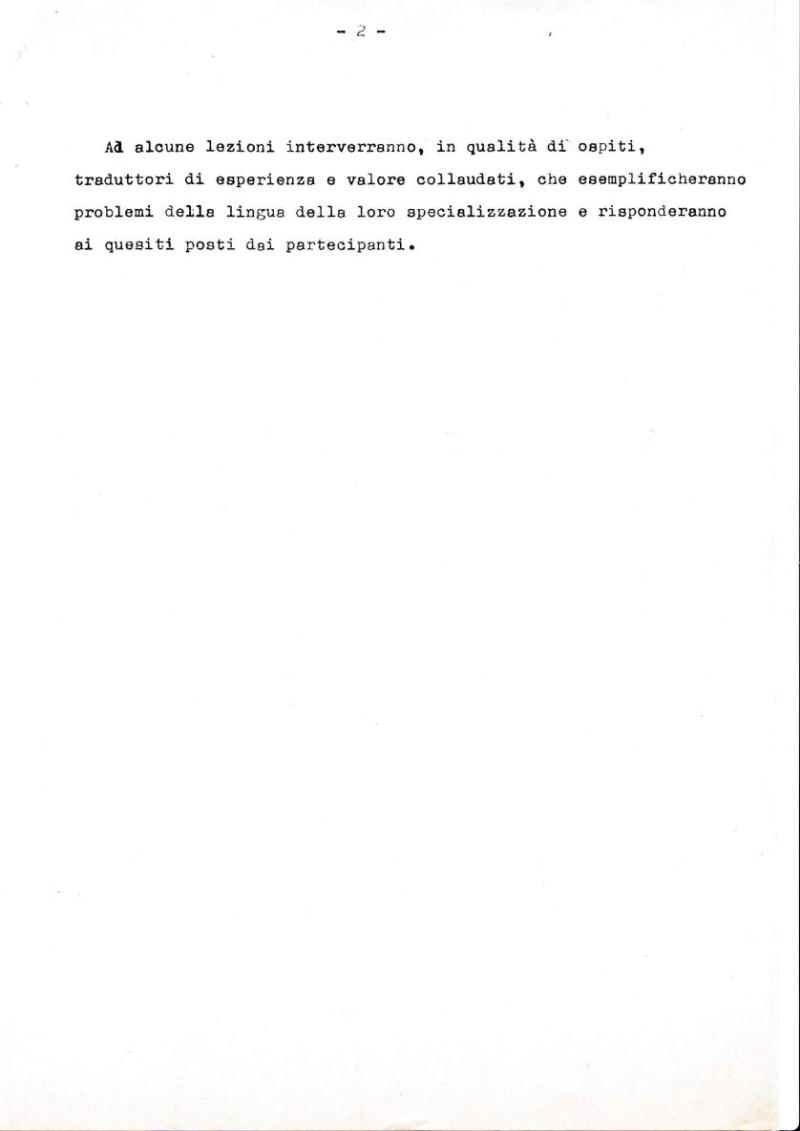
Pontiggia era già allora un traduttore in proprio. Aveva infatti voltato in italiano il saggio dello statunitense Robert Penn Warren, La poesia in un’epoca di sfacelo per l’«Almanacco dello Specchio» (nr 1, 1972, pp. 153-162); e, dal latino, Le meraviglie di Milano di Bonvesin da la Riva (Milano, Bompiani, 1974; edizione riveduta 1983; poi 1998) – frutto di un dialogo con Maria Corti, dei cui rilievi Pontiggia diceva di essersi volentieri avvalso – e il poemetto in esametri La Mosella di Decimo Magno Ausonio (ivi, Verba, 1984; con incisioni di Leo Lionni e tiratura in 150 esemplari numerati).
Negli anni Novanta e, precisamente, nel 1991 e 1993, Pontiggia avrebbe pure tradotto epigrammi rispettivamente di Giuliano l’Apostata (in Lirici greci, a cura di Vincenzo Guarracino, Milano, Bompiani) e del mimo Decimo Laberio (in Poeti latini, a cura dello stesso Guarracino e ivi). Infine, del Commento al Sogno di Scipione di Macrobio, incompiuto e conservato presso l’Archivio Giuseppe Pontiggia della BEIC di Milano, si è occupato di recente Andrea Balbo (Note su Giuseppe Pontiggia traduttore del Somnium Scipionis di Cicerone, in «Bollettino di Studi latini», L, 2, 2020, pp. 744-756), che ha scritto un articolo anche sulla versione della Mosella (Scrittori tradotti da scrittori (e disegnatori): Giuseppe Pontiggia e Leo Lionni alle prese con la Mosella di Ausonio, in La réception d’Ausone dans les littératures européennes, a cura di Étienne Wolff, Bordeaux, Ausonius Éditions, “Scripta Receptoria 15”, 2019, pp. 343-361).
Pontiggia era convinto che la traduzione, specie quella letteraria, debba corrispondere a uno sforzo di fedeltà all’originale in tutte le dimensioni o sfaccettature della sua forma, secondo l’inscindibile coppia “fedeltà–bellezza”: una sorta di «estuario» in cui cercare di lasciar fluire e di «trasporre in un altro linguaggio non solo la nota, ma anche il timbro» di un testo straniero, come dichiarava in Tradurre ed essere tradotti. Esperienze di scrittura (Les écrivains italiens et leurs traducteurs français, Actes du colloque de Caen (11-13 mai 1995), publiés sous la direction de Mariella Colin, Mari-José Tramuta et Viviana Agostini-Ouafi, Caen, Presses Universitaires de Caen, 1996, pp. 31-34). Un bisogno di fedeltà che consente a una traduzione di offrire non solo una «interpretazione illuminante» dell’originale, ma anche di «migliorarlo». Pontiggia era infatti persuaso che dialogare con un proprio traduttore, come gli era accaduto con il francese François Bouchard, fosse stata una opportunità di riflessione linguistica e formale importante per approfondire le ragioni del proprio lavoro di narratore. Precisamente nello stesso intervento di Caen (su cui si è soffermata anche Cristiana De Santis, Giuseppe Pontiggia: “Un autore che ritraduce il suo traduttore”, in «inTRAlinea», vol. 3, 2000, on line), Pontiggia aveva dichiarato che, «sull’esempio delle […] soluzioni espressive» proposte da una versione di Bouchard, gli era capitato di «modificare» le sue. Una consapevolezza da aggiungere a consapevolezza di intenti tecnico-formali della scrittura, nella fiducia, però, che il testo compiuto sorprenderà alla fine l’autore: saprà e dirà sempre di più di quanto egli abbia potuto immaginare o pensare scrivendolo. Non a caso, ancora nella medesima circostanza, Pontiggia ha definito l’«idea stessa del tradurre […] dall’antichità a oggi un viaggio verso Utopia, un avvicinamento progressivo all’impossibile».
Pontiggia giudicava la traduzione «una attività di importanza centrale nella moderna società della comunicazione», perché la considerava un esercizio di resistenza alla globalizzazione in cui l’«universalità dei valori viene semplicemente sostituita da un valore unico, quello del mercato globale. A questo valore vengono sacrificati, se non tornano utili, sia i valori delle tradizioni nazionali sia i valori della tradizione dei classici, intesi non come modelli da imitare, ma come esempi con i quali confrontarsi» (Il traduttore? È troppo antiglobal, in «Il Sole 24 Ore», 17 marzo 2002). Tradurre significava così per Pontiggia lavorare in favore della «conservazione delle lingue», ricche di «una stratificazione millenaria», come continuava ad argomentare nell’articolo apparso sul medesimo quotidiano milanese; lamentando ancora una volta «lo scadimento generale delle traduzioni» come una resa intellettuale dalle conseguenze pericolose.
Tradurre, e tradurre bene, rappresentava invece una reazione di vitalità, di rispetto e di riappropriazione del linguaggio e delle lingue, insomma di un patrimonio pieno di vigore di contro all’appiattimento generale di una omologazione volta alla pura e semplice «vendibilità immediata del prodotto». E, dal momento che sono le culture a venire tradotte, trasportate attraverso le lingue da una comunità all’altra, concludeva: «È in gioco non solo la trasmissione dei valori che solo chi li ignora può illudersi di quantificare; ma la loro azione concreta sulle generazioni, presenti e future».
Allora tradurre comporta la riaffermazione del bisogno di immettere nella società una tensione umanistica, una idealità; vale a dire di tentare di radicarvi la coscienza di quello che abbiamo chiamato l’umanesimo antropologico, che è di per sé stesso sempre costruttivo: nella responsabilità della cultura, nell’orizzonte di una totalità dalla quale l’essere umano non può di necessità biologica fuggire. La traduzione può dunque offrire un antidoto alla diffusa dematerializzazione del reale, alla sua nichilistica implosione in simulacro, nella lavorazione e rielaborazione plastica delle parole e delle lingue che di tale reale sono parte viva.









