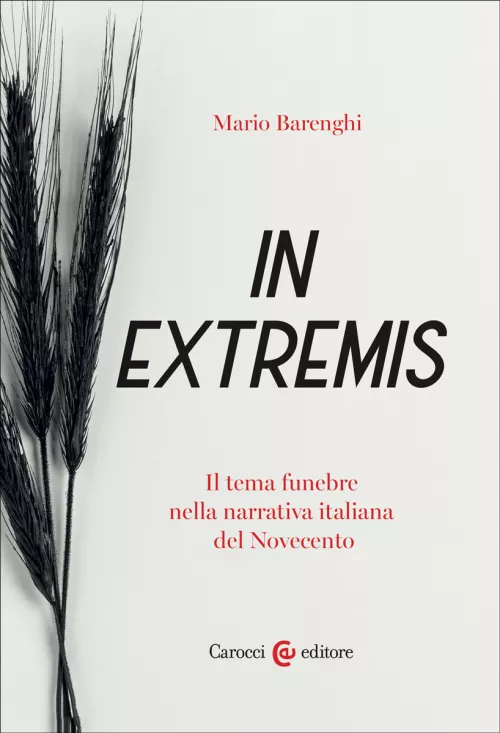Gli scrittori e la morte
Muto splendido cane è la morte: perché, leggendo il bel libro di Mario Barenghi, In extremis, appena uscito per Carocci, mi è venuto in mente questo verso giovanile di Zanzotto?
Barenghi si occupa in effetti del tema funebre nella narrativa del Novecento, non nella poesia, è vero; però il suo testo si apre e chiude con due cani celebri, Jor, l'alano dei Finzi-Contini, menzionato nel primo capitolo e Bendicò, anch'esso alano, di proprietà del principe Salina, nel Gattopardo, che suggella il capitolo sesto, da considerare l'ultimo del libro, essendo il settimo lievemente fuori tema (l'aldilà in Giuliano Scabia).
Non credo che sia solo un caso. Del resto il cane è un animale infero, il guardiano del mondo sotterraneo era Cerbero, si sa, detto anche “il cane dell'Ade”.
Quindi, superata la soglia custodita dal cane infero, oltre a Bassani e Lampedusa (nonché Scabia, con l'avvertenza di cui sopra), troviamo che gli altri autori considerati sono Gadda e Manganelli.
Qualcuno potrebbe meravigliarsi che né a Levi né a Calvino siano consacrate parti specifiche di questo libro, dato che i due sono gli autori cui Barenghi ha tributato negli anni le attenzioni più costanti, il fatto è che né l'uno né l'altro si caratterizzano per una “nota dominante” nella trattazione del tema funebre. Comunque anch'essi, benché quasi incidentalmente, hanno una loro presenza nel testo. Lo vedremo, soprattutto per Calvino.
In aggiunta a questi sette capitoli ci sono due appendici, una sulla Milano di Gadda e l'altra sul carteggio Gadda-Parise. E proprio qui, mi pare, Barenghi enuncia, come di passaggio, il suo metodo d'indagine in questo libro: il confronto tra due autori assai diversi tra loro, almeno a un primo sguardo, come per l'appunto Gadda e Parise.
Infatti il tema funebre nel Giardino dei Finzi-Contini di Bassani è analizzato e illuminato dalla comparazione con La cognizione del dolore di Gadda. Paragone ardito, a tutta prima, data la natura dei due testi, il primo un romanzo “ben scritto”, tradizionale, accattivante, l'altro un poderoso oggetto eteroclito, assai difforme da ciò che s'intende canonicamente per “romanzo”.
Ma le differenze non finiscono qui: nell'opera di Bassani il tema è esplicito: nel prologo c'è la visita a una necropoli; la prima parola del primo capitolo è “la tomba”; cimiteri, lapidi ed epigrafi sostanziano ampie porzioni testuali.
In Gadda vige all'inverso una significativa reticenza. La morte del fratello del protagonista non è mai apertamente tematizzata, sempre e solo allusa attraverso dolorosi sottintesi. C'è solo un cenno fugace al cimitero di Lukones.
Il romanzo di Bassani può anche essere inteso quale monumento funebre di parole eretto a memoria di una famiglia annientata dalla storia (e del resto un cimitero che cos'è se non un giardino?), quello di Gadda tutt'al più è un cenotafio; anzi, a rigore, l'evocazione del fantasma di un cenotafio.
In entrambi i romanzi c'è un'analogia fra la struttura topologica, nel senso che c'è in entrambi un'antinomia tra il chiuso e l'aperto, tra gli spazi familiari e le minacce esterne; inoltre c'è un identico succedersi di movimenti prima centripeti e poi centrifughi; però ciò che li divide irreparabilmente è la dimensione del dolore per la perdita; da un lato infatti c'è un'avvenuta e dall'altro una mancata elaborazione del lutto.
Il dolore più forte è quello individuale, non condiviso, di Gonzalo, rispetto a quello del narratore del Giardino, che ha assunto comunque una dimensione collettiva.
Anche se c'è da aggiungere che forse il narratore del Giardino, più che rimpiangere elegiacamente ed esclusivamente la triste sorte di Micòl e della sua famiglia sterminata nel lager, versa lacrime amare anche sulla sua propria inettitudine, sulla sua incapacità di darsi, di vincere le sue paure con la donna amata. Situazione quanto mai ambigua, contraddittoria, come i due occhi dell'alano arlecchino Jor, uno scuro e l'altro azzurro.

L'autore successivo preso in esame è Giorgio Manganelli, in ben due capitoli.
E qui Barenghi rovescia un luogo comune critico, ampiamente alimentato da Manganelli stesso e seguito fedelmente da legioni di interpreti, devoti esegeti del Maestro (soprattutto in Letteratura come menzogna, questo suo vangelo negromantico, giusta la definizione di Cortellessa).
Per Manganelli lo scrittore non doveva avere assolutamente niente da dire. Non c'era significato al di là di quello linguistico del testo stesso, che si proclamava dunque strettamente autoreferenziale, intransitivo, gratuito e del tutto artificiale.
Invece Barenghi ipotizza che l'intera opera manganelliana, dove il tema funebre è onnipresente, fin dal famoso assioma di Hilarotragoedia sulla natura discenditiva dell'essere umano, abbia un referente preciso, una concreta radice psicologica, dica qualcosa insomma e non sia solo un ricamo vertiginoso tessuto sul nulla.
Centuria è certamente una stupefacente, variegata, vorticosa collezione di allontanamenti, ossia, etimologicamente, di decessi, congedi, rinunce, rimpianti, incontri mancati eccetera; e questo perché Manganelli è autore concentrato sulle fasi terminali, mentre Calvino lo è sulle fasi aurorali. Ma, dietro tutta questa prismatica messa in scena, sta l'io dell'autore, Manganelli medesimo, rifratto in ognuno dei suoi personaggi, quei grigi signori la cui inappuntabilità cela un segreto inconfessabile.
Forse tutte le sue pagine non sono che un'autobiografia travestita, dove una figura materna incombe, senza via d'uscita, senza scampo, e l'alvo uterino è il teatro di un dramma dove il soggetto a volte si esalta, a volte si conculca, dato che il paradosso e l'ossimoro sono le costanti di questi testi.
La proverbiale cerimonialità delle pagine manganelliane è anch'essa di matrice luttuosa, dato che la cerimonia per antonomasia è quella funebre.
Però, pur ubiquitaria, la morte in Manganelli è negata. E lo è precisamente in quanto ne viene rifiutata la irreversibilità. “Rifarsi una morte” è detto in Sconclusione: nel mondo parallelo di questo scrittore si può morire molte volte, al modo che vi si può nascere in seguito a un suicidio e anche rivendicarne la paternità con un certo orgoglio.
Insomma tutta la teoresi manganelliana della menzogna, dell'artificio estremo fine a se stesso è per Barenghi solo una strategia dissimulatoria. Proprio nel senso della secentesca Dissimulazione onesta di Torquato Accetto.
La morte è solo uno scherzo del linguaggio, una figura retorica, un tropo. Fingersi morto, dissimulando, è stato il mezzo principe per vincere l'angoscia.
Del resto, nel capitolo nono della Dissimulazione onesta, il corpo vivo, bello, palpitante non è altro che un “cadavero dissimulato”.
Anche al Gattopardo sono dedicati due capitoli (o uno e mezzo); e anche qui vediamo come a un autore “difficile”, “sperimentale”, ostico come Manganelli succeda un best-seller o long-seller di fama consolidata e inossidabile come quello di Tomasi di Lampedusa.
(Forse in questi accostamenti è implicita anche una polemica contro quelle famigerate definizioni sprezzanti del Gruppo 63, dove Bassani era indicato come la Liala della narrativa italiana oppure contro le analoghe stroncature del Gattopardo provenienti dalla stessa parte; oltre tutto viene in mente che alcuni esponenti del Gruppo 63, di cui anche Manganelli incredibilmente fece parte, amavano presentarsi come “nipotini dell'ingegnere”, ossia Gadda, e allora tutto pare tenersi anche per questo aspetto in questo libro).
Il Gattopardo è, anche secondo Javier Marías, soprattutto un romanzo sulla morte.
Tutto quello che vi accade sembra in realtà non accadere, in quanto eterna ripetizione di ciò che è già stato e sempre sarà. Niente di nuovo sotto il sole. Anche in questo testo, come in quelli di Calvino, pare dominare il nietzschiano “pathos della distanza”, sinonimo del distacco con cui gli occhi disincantati di un nobile guardano il mondo. Se in Manganelli ci si poteva “rifare una morte”, qui il principe può pensare che “finché c'è morte c'è speranza”.
Anche i momenti conviviali che scandiscono la narrazione sono contaminati dal fiato della morte: la gelatina al rum di cui è ghiotto il protagonista è, con la sua friabilità, equiparabile alle fortezze di Franceschiello, facile preda del nemico. Il buffet offerto durante il ballo a palazzo Ponteleone pare più un'esposizione di cadaveri successiva a un massacro che una delizia gastronomica.
Il volo finale fuori dalla finestra del cane (imbalsamato) Bendicò sembra essere il riassunto plastico, l'ipotiposi di questa vicenda di sfacelo e rovina. Tomasi stesso, in una lettera a un amico, lo giudicava “la chiave del romanzo”.
Il settimo e ultimo capitolo, si è detto, esula dal tema funebre strettamente inteso, ma, avendo a che fare con l'aldilà in Nane oca rivelato di Giuliano Scabia ha pur sempre una certa attinenza con l'argomento principale.
Nell'oltretomba di Scabia tutti sono salvati, in una sorta di apocatastasi laica, però ora, di tutti si vede tutto. Tutti sono esposti inesorabilmente allo sguardo altrui; è, in ottemperanza a una distinzione del grecista Dodds, il trionfo della “civiltà della vergogna” (quella di Omero, i cui personaggi temono più di ogni altra cosa il giudizio altrui) su quella “della colpa” (che ha il suo culmine nella tragedia antica).
Testimonianza del valore perenne delle categorie dell'Antico.