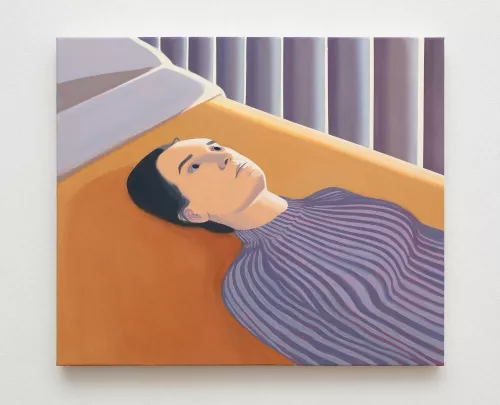Speciale
Il ritorno del trauma / Ha senso parlare?
Non so bene cosa dire, non so che parole usare. Dice: E allora stai zitto! Ma no, nonostante tutto, ho voglia di parlare, di dire la mia, così in generale, su tutto, qualunque cosa va bene, purché io possa dire, parlare. Perché è di questo che adesso ho bisogno: di parlare, di esercitare il mio “diritto animale” di parlare, di esprimermi, esprimere il mio personale bisogno di estrinsecare, come posso, tutto quello che mi passa per la mente mentre sto davanti a questo immenso stordimento concettuale che via via, in questi giorni, si sta configurando nella sua massa enorme, smisurata. Tutti hanno bisogno di dire, di esprimere, di raccontare. Fiumi di parole, come diceva la nota canzoncina. Tutti sentono come l’urgenza di misurarsi con la loro propria verbalizzazione dell’evento che ci colpisce. Tutti devono provare a spiegare che cosa succede, che cosa succederà. Ognuno a modo suo, con gli strumenti più o meno sgangherati o sofisticati che possiede. Non è la ricchezza linguistica o intellettuale che decide per me: l’importante è che io lo faccia, che lo possa fare. Perché è un “naturale” modo di elaborare ed esorcizzare il terrore che ci invade: terrore di morire o di avere un futuro invisibile e troppo insopportabilmente minaccioso. È lo scudo delle parole che io alzo istintivamente per ripararmi, per separarmi dal disastro che, finché io parlo, vuole dire che non mi ha ancora colpito. Parlo perché vivo. Parlo finché vivo.
È l’istinto di sopravvivenza che il sapiens mette in azione nel momento in cui sente le condizioni della sua esistenza poste fisicamente in discussione. Un conflitto primordiale tra l’uomo cosciente e la biosfera. Uno scontro assoluto che solo nei momenti estremi si manifesta in tutta la sua muscolarità. La possibile negazione del proprio futuro mette in campo la potenza del verbale dell’homo sapiens. Non mi riferisco al potere della parola di orientare il mondo (questo lo ha spiegato benissimo David Grossman alla Buchmesse di Francoforte – vedi Le parole cambiano il mondo su Repubblica dello scorso 17 ottobre), ma alla pressione verbale quantitativa, di quando si ha come il bisogno di agire con una materiale sovrapproduzione di parole, di dire tanto, quasi che la massa delle parole potesse fare da diga alla catastrofe. È un sentire di guerra che – a dispetto dei precisini che ci fanno osservare che questa non è in senso stretto una guerra –, è più che sufficiente a scatenare la psiche.
C’è il tasto kantiano da suonare, ne abbiamo bisogno per capire veramente. Poi c’è il tasto brechtiano, per realizzare bene che cosa succede. Ma soprattutto c’è il tasto pulsionale, quello che ci dice semplicemente, appunto, che siamo ancora vivi.
Lo stesso venir meno della solidità delle istituzioni, della loro materiale efficacia, ha in qualche modo incrementato la verbalizzazione del disagio. Fa impressione il profluvio di riflessioni, idee, opinioni che in questi giorni si sta riversando nel mondo della comunicazione, di cui la rete è, naturalmente, il formidabile moltiplicatore. Una massa che si aggiunge ai pensieri, alle riflessioni e ai discorsi che le persone stanno producendo in relazione alla situazione di allarme globale che stiamo vivendo. Tutto converge su questo. Il comune sentire è all’unisono, unipatico, e fa stare tutti allo stesso modo. Il vagare dei significati, il tremolare delle categorie (il tempo, la salute, il benessere, la felicità, l’infelicità, la solitudine…) in un sobbollire cosmico che è cominciato e continua a emanare un odore buono e cattivo, come il minestrone della nonna con tutte le sue verdure.
Al di là delle implicazioni per la salute e, poi, l’economia, c’è quasi uno sbalorditivo azzeramento delle altre implicazioni. Non si pensa più ad altro se non come a delle reminiscenze di un prima che non si sa più bene se esista ancora o sia completamente stato spazzato via dal virus. Accanto alla sacrosanta funzione informativa della stampa – su cui molto c’è da dire, ma non nel fuoco della battaglia –, si assiste a un lavoro alacre di tutti coloro che sono in grado di formulare pensiero complesso e articolato (intellettuali, opinionisti, scrittori, artisti) per spiegare, far capire, un gran darsi da fare a elencare ciò che c’era e che non potrà più esserci e a prefigurare un nuovo futuro. Con una specie di ansia di cancellazione e di rinnovamento, con i tentativi più o meno argutamente sostenuti di segnalare che cosa precisamente sarà diverso, in che modo questo che cosa si modificherà giocoforza dopo questo flagello. E tutti (noi) a cercare un qualsivoglia conforto, una rassicurazione sul proprio grado di sopravvivenza. D’altronde le guerre inducono una tabula rasa della riflessione e dell’espressione, come se solo i conflitti mortali potessero costringere il pensiero a riformularsi rapidamente.

Opera di Molly Bounds.
I musicisti, i disegni dei bambini, i nomi, tutto parla di più: l’ambiente (vigliaccamente ignorato), la povertà (vecchia e nuova), il lavoro (riformulato e dislocato), la scuola (ormai una sfida sociale ed educativa), la socialità (esplosa), l’emotività (completamente ridimensionata). Un’impressionante quantità di parole, meglio, di discorsi che probabilmente stanno elaborando una nuova configurazione della sostanza umana attorno alla quale ogni specificità settoriale dovrà rivedere i suoi fondamenti, e dovranno tenere conto della “necessità che trascende il nostro potere e che ci riconsegna a quella “natura” che credevamo, ingenuamente, di aver evaso”, come bene ha detto recentemente Rocco Ronchi (Seconda ondata, l’angoscia, Doppiozero, 25.10.2020).
Il fatto è che per molti di noi parlare è la suprema coscienza di noi stessi, la vera sostanza del nostro stare al mondo. E quando supera lo stadio solo emotivo di “logorrea ansiosa”, come direbbe lo psicologo, questo parlare oltre misura ha evidentemente dei significati più larghi e fondi. Ecco il punto: siamo soli, davanti allo shock generalizzato della pandemia ci sentiamo abbandonati a noi stessi. Persino le rassicuranti “convinzioni” scientifiche vacillano, gli uomini tirano fuori le armi desuete dell’”oscurantismo” (complottismi, ecc. ecc.), scopriamo che i conforti generalizzati della goduria neoliberista (ristoranti, vacanze, viaggi, nottate a ballare, a bere e strafarsi, consumi incessanti, di cose e persone…) possono non essere più dati per scontati. E allora ci agitiamo e parliamo, guardando in tutte le direzioni, scrutando una bussola che sembra essersi smagnetizzata. E quando ci si percepisce soli si è preda del corpo, delle sue spietate meccaniche di sopravvivenza. Soli e smarriti, si diventa egoisti, e abbiamo bisogno di iperverbalizzare, alla ricerca fisica di dare un senso, una interpretazione a tutto questo (i sociologi della comunicazione avranno il loro bel da fare nei prossimi anni).
C’è un’oscillazione frenetica e costante tra il generale e il particolare, tra il collettivo e l’individuale, ma soprattutto è maturata una vera angoscia per il futuro. “È una lezione clinica – dice Massimo Recalcati –: il ritorno del trauma — la sua recidiva — può essere più traumatico della sua prima volta. Il panico della seconda ondata porta con sé il sentimento di non poter più ritornare alla vita” (Se cresce la paura del futuro, in Repubblica, 31.10.2020).
E ancora più soli ci percepiamo se ci misuriamo con le vastità dei sistemi sociali e politici certamente destinati a rivedere il loro funzionamento e le loro “filosofie”. Verifichiamo, infatti, che “la morte non è democratica”, perché le condizioni sociali condannano i più deboli, ma soprattutto sperimentiamo sulla nostra pelle (anzi, sulla nostra solitudine) quale sia il potenziale di coercizione del controllo digitale anche nelle società liberiste, come dice il filosofo coreano-tedesco Byung-Chul Han: “Il liberalismo occidentale è minacciato non solo dalla pandemia, ma anche dal totalitarismo digitale. […] Le informazioni che divulghiamo ci controllano e ci guidano. Il governo neoliberista non sopprime la libertà, fa uso della libertà stessa. Viviamo oggi in questo paradosso dell’autosfruttamento volontario che va di pari passo con la percezione della libertà. ("Noi, schiavi felici della pandemia digitale" intervista a Repubblica, 31.10.2020).
Sono nuove realtà, nuove sensibilità, nuovi errori di cui ha senso che io parli, purché ne nasca una discussione, e non un’istanza malata della mia (nuova) solitudine. Non posso non chiudere con le parole di Chandra Livia Candiani (Doppiozero, 03.11.2020): «Il fatto è che le cose sono complesse e se vedi un lato ne manchi un altro e non ho parole rotonde. Tutto sommato, credo che ascolterò e basta, lascerò dire a ognuno la sua e intanto respirerò. Certe volte, così facendo, qualcuno mi dice: “Grazie, mi fa bene parlare con te.” “A me invece fa bene respirare,” penso io, un po’ malinconicamente”».