Abitare / Il bricoleur ecologico e il prossimo mondo
Ora che la sostenibilità è diventata argomento comune di conversazione e tutti non possono fare a meno di avere opinioni a riguardo, sta prendendo forma una figura che potremmo definire il bricoleur ecologico. Come il bricoleur lavora con quello che ha a disposizione al momento, così il bricoleur ecologico lavora con un’idea di ecologia ricavata da quello che ha a disposizione oggi, quindi ciò che trova online, su riviste o trasmissioni televisive e, nel caso di ecobricoleur più evoluti, su qualche libro di ultima generazione, poi mette insieme ciò che ha trovato e, convinto di aver penetrato l’argomento, elargisce le sue opinioni come verbo inoppugnabile, come sinceramente crede che siano.
Il problema è che ciò che oggi va sotto il nome di ecologia e sostenibilità è un territorio totalmente devastato dall’arrivo del sistema industriale che, come uno tsunami, ha distrutto e annientato ogni cosa che non fosse funzionale alla propria logica economica. Di quello che era il panorama della cultura ecologica, da vent’anni a questa parte non rimangono che macerie rimesse a nuovo e ristrutturate con parole scintillanti che formano due grandi agglomerati: la città dell’energia sostenibile e quella del riciclo, e si intravedono i lavori per la costruzione di un nuovo grande sistema su cui puntano investimenti e speranze: la città della digitalizzazione. L’idea di transizione ecologica viene sempre più affiancata a quella di digitalizzazione, si conta sulla forza della ripetizione che finirà per farcele considerare interdipendenti e inseparabili. In fondo digitalizzazione confina con smaterializzazione e quindi meno consumo di energia e di materia, proprio ciò che serve per la soddisfazione del bricoleur ecologico.
Peccato che “L’accesso continuo e l’enorme disponibilità di informazioni consuma suolo, energia, risorse, e necessita di un sostrato che lo alimenti e lo renda vivo… ogni nostra ingenua azione in digitale ha un fortissimo impatto sull’ambiente.” A parlare è Ingrid Paoletti, professore associato di Tecnologia dell’Architettura al Politecnico di Milano nel suo libro Siate materialisti! uscito per Einaudi nell’aprile del 2021, che prosegue: ricordandoci che anche una piccola cosa ormai quotidiana come l’uso della mail ha una precisa impronta materiale. Ogni messaggio di posta elettronica lascia un’impronta di carbonio da 0,3 a 50g di anidride carbonica equivalente. Facendo una media, su 50 mail al giorno risulta un consumo di mezzo chilo di anidride carbonica quotidiana. Le tecniche digitali stanno raggiungendo un livello di sviluppo notevole, già l’idea del denaro virtuale è una realtà e a breve non saranno più necessarie neppure le carte di credito. “Un colosso della logistica sta già sperimentando punti vendita dove si può entrare senza essere muniti di carte. Non perché non si paghi, ma perché la nostra fisionomia è sufficiente a riconoscerci come acquirenti. Veniamo seguiti da telecamere e associati a codici di vario genere, così che uscendo dal negozio il digitale possa tirare le somme. Sembra quasi che l’uomo sia scomparso dietro l’oggetto del suo consumo, anzi, che sia proprio l’uomo l’oggetto di consumo. È fondamentale per il venditore posizionare l’acquirente in questo spazio immateriale, dove non possa farsi troppe domande. Non sia mai che non consumi.”
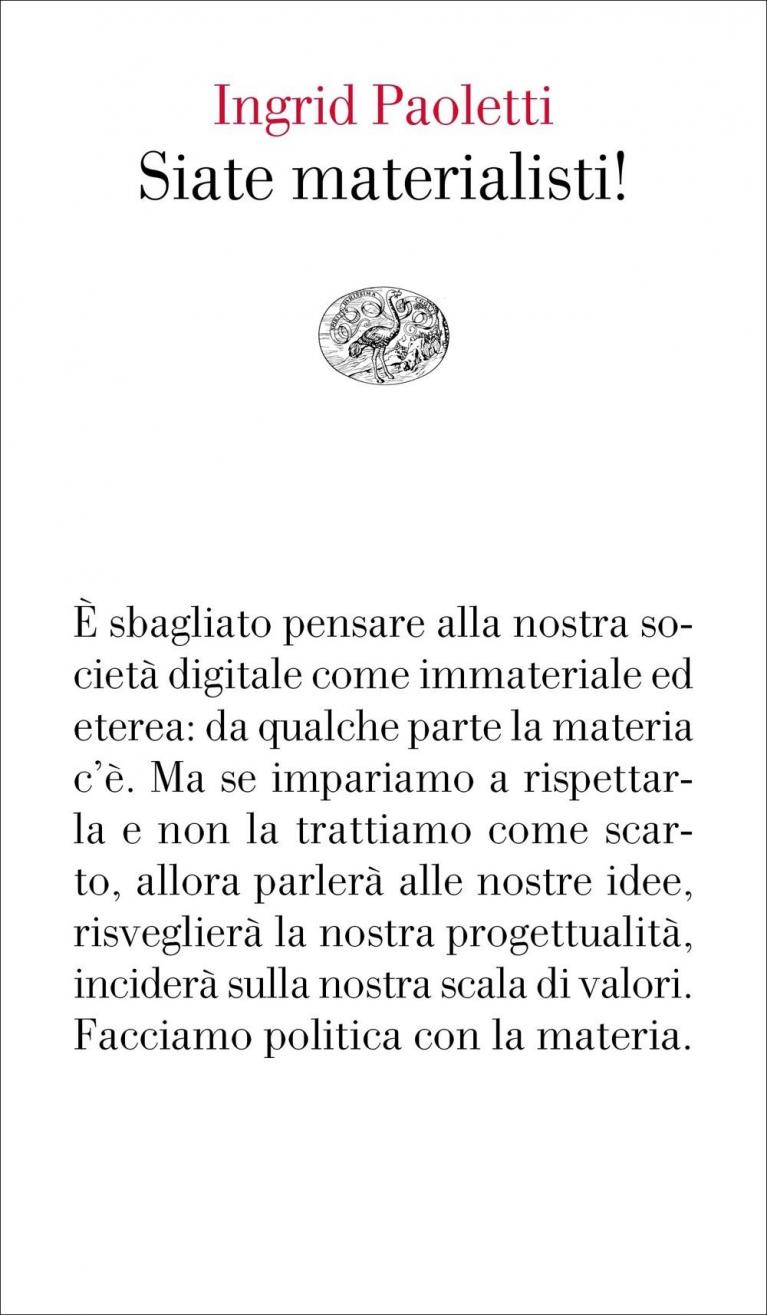
C’è un collegamento diretto fra la trasformazione da uomo in consumatore e l’insistenza su soluzioni che mettono in gioco digitalizzazione e tecnologie di nuova generazione dipinte come sostenibili. Il gioco è palese: puntare l’attenzione sulla tecnologia serve a distrarre dal vero nocciolo del problema, che è di carattere sociale. È la tesi di fondo che pervade tutto il libro La sfida del cambiamento climatico di Dipesh Chakrabarty, uscito nel febbraio 2021 per Ombre Corte. Ho notato che molte delle critiche al sistema neoliberista vengono da studiosi di origine indiana, dal filosofo Homi K. Bhabba all’economista Prem Shankar Jha, fino all’ambientalista Vandana Shiva, la cultura derivata dagli studi postcoloniali e anticoloniali degli anni Ottanta ha prodotto una visione del mondo che finalmente sta bilanciando quello che sempre più è il pensiero unico dilagante. Non va dimenticato che ambientalismo e colonialismo sono legati indissolubilmente, le preoccupazioni per l’ambiente nascono alla fine del Seicento dalla necessità di proteggere le proprietà dei coloni dalla loro stessa azione nei territori dell’Africa orientale e dei Caraibi, ed è un ambientalismo bianco ed europeo, lo stesso che poi negli anni Novanta si trova a fronteggiare le ragioni dei paesi colonizzati e fuori dalla sua cerchia che non ne vogliono sapere di pagare un prezzo per i danni che l’Europa e i suoi figli americani hanno provocato e su cui versano lacrime di coccodrillo.
Nel testo di Chakrabarty il cambiamento climatico non viene visto solo in termini pop di scioglimento di ghiacci e animali in pericolo, ma viene puntata l’attenzione su un panorama più generale che vede con chiarezza nell’azione colonialista europea una delle cause principali che ha nella divisione e disuguaglianza sociale un punto di partenza e non di arrivo. Da questi punti di vista, è la disuguaglianza sociale che porta al cambiamento climatico e, se davvero si vuole agire per contrastarlo, è da lì che è necessario partire. Chakrabarty scrive che secondo i climatologi “gli attuali cambiamenti climatici globali (e non regionali) sono in gran parte opera umana. Il che implica che gli esseri umani ora sono parte della storia naturale del pianeta. La parete divisoria fra storia naturale e storia umana che era stata eretta nella prima età moderna e rinforzata nel diciannovesimo secolo, quando le scienze e le discipline degli esseri umani si erano consolidate, si è incrinata in modo serio e permanente. (…) nel diventare una forza geofisica del pianeta, abbiamo anche sviluppato una forma di esistenza collettiva che non ha alcuna dimensione ontologica. Abbiamo bisogno di modi non ontologici di pensare l’umano. Bruno Latour ha denunciato a lungo che il problema del pensiero politico moderno è la distinzione cultura/natura, che ha autorizzato gli esseri umani a vedere la loro relazione con la “natura” attraverso il prisma della relazione soggetto/oggetto. Ha esortato a una nuova idea di politica che comprenda allo stesso tempo – come partner attivi nelle nostre discussioni – sia gli umani sia i non umani.” È la vecchia storia della separazione oggetto/soggetto cara ai primi filosofi greci, figlia della separazione fra ambiente umano e resto del mondo operata dai primi agricoltori neolitici con il gesto di recinzione dei campi che ha fornito il modello per la recinzione delle città e che ha a che fare con la nascita dell’avere, dei muri, dell’idea che l’uomo è un’altra cosa rispetto al resto dei viventi, idea poi reincarnata nei miti della genesi ebraica. Ci stiamo accorgendo che quei miti non sono quelli della nostra vera origine, che prima ce n’erano altri, da trovare, e dopo ce ne saranno altri, da immaginare.
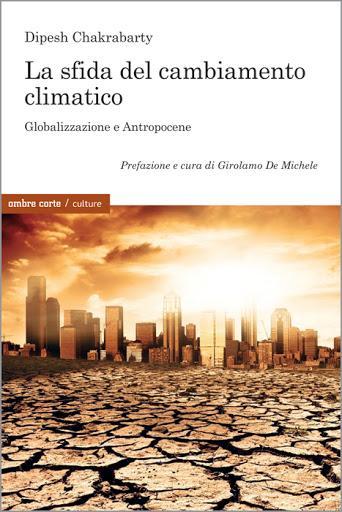
“La scienza del cambiamento climatico ha le sue immediate radici nel periodo della guerra fredda, e ha a che fare in particolare con le realtà della bomba nucleare e della competizione nella ricerca sull’atmosfera e sullo spazio. Il cambiamento climatico – o riscaldamento globale – è diventato una preoccupazione di pubblico interesse nei tardi anni Ottanta, quando gli scienziati hanno avvisato i governi che si trattava della più grande minaccia che la civiltà umana avesse mai affrontato e che questa minaccia veniva dalla dipendenza della nostra civiltà dall’energia a basso costo fornita in abbondanza dai combustibili fossili.” È interessante notare come il più importante cambiamento che abbiamo avuto nella nostra storia, il passaggio dallo stile di vita mobile e all’aperto a quello sedentario avvenuto diecimila anni fa e che ha dato vita alla civiltà nella quale siamo, secondo la maggioranza della comunità scientifica sia avvenuto proprio a causa di un cambiamento climatico. Allora abbiamo deciso di cambiare modo di mangiare e ci siamo dedicati alla coltivazione delle piante, oggi cosa succederà, considerato che nel frattempo da poco più di 8 milioni che eravamo siamo diventati poco meno di 8 miliardi? Qual è il cambiamento che ci aspetta? Come un cambiamento di stile di vita per un cacciatore paleolitico era inconcepibile, nello stesso modo lo è anche per noi, eppure avvenne, quel mondo finì e ne iniziò un altro. Ora, che mondo vogliamo costruire?
Andrea Staid in La casa vivente, riparare gli spazi, imparare a costruire, uscito nell’aprile 2021 per add editore, indica una direzione precisa, che è quella che sta prendendo una parte sempre più numerosa di progettisti e costruttori. Staid si avvicina al mondo dell’architettura da antropologo e da uomo, mettendosi in gioco personalmente, riportando le proprie esperienze dell’abitare e, attraverso i propri viaggi, dell’abitare di altri popoli e nota come in quelle ormai rare culture non infettate dal colonialismo bianco, abitare, costruire, vivere, siano azioni talmente legate fra loro da risultare indissolubili. Fino all’arrivo del metodo di produzione industriale, villaggi e città venivano costruiti da una comunità, chi aveva necessità di costruirsi la casa si rivolgeva ai capomastri locali e insieme a loro, anche materialmente, contribuiva alla realizzazione. Da questo nasce il perduto effetto città tanto poi ricercato per tutto il Novecento e mai raggiunto con altri metodi. Questa modalità partecipativa viene interrotta dall’istituzione di leggi che nel corso dell’Ottocento hanno impedito a chi abita di poter intervenire sul proprio spazio che è stato affidato a tecnici al servizio delle amministrazioni.
Nel giro di poche generazioni l’idea stessa di autodeterminazione dello spazio si è dissolta e oggi chi la reclama sembra un utopista o un rivoluzionario, mentre sta solo ribadendo un diritto che è documentato da tutta la storia della casa. Staid introduce nell’analisi dello spazio metodi propri dell’antropologia, usando quel metodo sempre fecondo che è l’interazione fra le discipline che porta vantaggi e sposta punti di vista spesso dati per scontati. Sulla spinta della prima cultura ecologica, molti operatori si sono rivolti a quelle “architetture senza architetti” che nascondono in evidenza segreti e bellezze che i metodi di produzione industriale non riusciranno mai a raggiungere. Staid racconta di case visitate personalmente, trasformando questo libro anche in un libro di viaggi in cui i progettisti possono incontrare altri modi di concepire l’abitare, oltre le ormai purulente idee del Movimento Moderno che, nato all’insegna dei lumi della ragione è ormai precipitato nell’abisso dell’ottusità, ma che continua a dominare la formazione dei futuri progettisti. Ben vengano allora antropologi con gli occhi aperti che aprono le finestre per cambiare l’aria delle discussioni accademiche e mostrare che fuori c’è il prossimo mondo e che qualcuno ha già iniziato a costruirlo.









