Il fotogiornalismo e la coscienza degli uomini
“Supponi che fossi tu stesso a innalzar l’edificio del destino umano, con la meta suprema di render felici gli uomini, di dar loro, alla fine, la pace e la tranquillità, ma, per conseguire questo, si presentasse come necessario e inevitabile far soffrire per lo meno una sola minuscola creatura, per esempio quella bambina [...] e sulle sue invendicate povere lacrime fondare codesto edificio: consentiresti tu a esserne l’architetto a queste condizioni?”
Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamàzov
Durante la grave carestia che nel 1993 colpì il Sudan, il giovane reporter sudafricano Kevin Carter scattò una fotografia divenuta celebre. Riuscì a fotografare una bimba denutrita e affamata, china sul terreno, inquadrando sullo sfondo un avvoltoio in modo che apparisse incombente sul suo corpo inerme, come in macabra attesa. L’immagine è così brutale nel realismo e chiara nel significato – così “riuscita” potremmo dire dal punto di vista fotogiornalistico – che fu pubblicata in evidenza sul New York Times e poi in tutto il mondo. Fu la sua gloria ma anche la sua condanna. Al suo autore valse il premio Pulitzer l’anno seguente, ma anche feroci e infamanti accuse: alcuni giornalisti gli chiesero perché non avesse salvato la bambina, anziché restare impassibile a osservare la scena per immortalarla, e innumerevoli lettori chiamarono in ansia la redazione per conoscere quale fosse stata la sorte di quella bambina. Eppure Carter aveva semplicemente compiuto con successo la missione che si chiede a ogni fotoreporter di perseguire: testimoniare ciò che vede nel modo più efficace possibile con lo scopo di informare l’opinione pubblica e suscitare interesse, nella speranza di cambiare lo stato delle cose e accettando, per questo, di essere spettatore della sofferenza altrui.
 Kevin Carter, A starving Sudanese girl who collapsed on her way to a feeding center while a vulture waited nearby, 1993
Kevin Carter, A starving Sudanese girl who collapsed on her way to a feeding center while a vulture waited nearby, 1993
Un anno dopo, a soli 33 anni, Carter decise di togliersi la vita, perseguitato dalle troppe scene di morte e violenza a cui aveva assistito e soprattutto, probabilmente, da quell’episodio, da quell’immagine. A guardarla di nuovo, riecheggia nella mente la perentoria e sconcertante domanda che Ivan Karamazov rivolge al fratello Alëša nel capolavoro di Dostoevskij. Alla prolungata sofferenza della bambina che rese possibile l’immagine, si aggiunse quella del fotografo che aveva creato la più controversa icona della fame in Africa. L’aveva fatto con il nobile intento di sensibilizzare la comunità internazionale perché intervenisse su quella situazione, ma per farlo aveva dovuto abbandonare al proprio destino quella creatura. Deve essere ancora questa, al giorno d’oggi, la missione del fotoreporter? La sua autentica efficacia è commisurata al prezzo che viene spesso pagato? La tortura psicologica che Carter si autoinflisse e il suo sacrificio sono stati davvero utili alla causa? In definitiva, per far progredire la civiltà umana è ancora necessario accettare queste condizioni?
 Alfredo Jaar, The sound of silence, 2006
Alfredo Jaar, The sound of silence, 2006
L’emblematica vicenda di Kevin Carter (divenuta anche oggetto di una videoinstallazione opera dell’artista cileno Alfredo Jaar, The sound of silence) è stata rievocata insieme ad altre in un dibattito (l’ennesimo, per la verità) su etica e giornalismo nato sulle colonne del Guardian e riportato in Italia da Davide Frattini sul Corriere della sera. Sul quotidiano britannico Jonathan Jones sostiene la tesi tradizionale che l’immagine fotogiornalistica ha il potere e il compito di risvegliare le coscienze, spronando all’azione chi la guarda. Si tratta però di un argomento retorico, che non a caso si avvale sempre, per essere dimostrato, di esempi tratti dalla storia della fotografia (in questo caso, il Biafra di Don McCullin), e in cui si vantano le battaglie vinte dai fotogiornalisti ignorando tutte quelle perse o non combattute. E comunque, ciò che più conta, la realtà in cui viviamo è completamente diversa: è cambiato il modo in cui le notizie e le immagini vengono prodotte, diffuse, recepite, memorizzate. Lo stato di saturazione da immagini del dolore, con conseguente assuefazione emotiva e cognitiva, ha ampiamente superato la soglia critica. Per quanto le parole taglienti e cristalline con cui Susan Sontag preconizzò questo fenomeno quarant’anni fa vengano sovente (e anche stavolta) citate, non sembra che con esse si sia fatto davvero i conti.
 Don McCULLIN, Twenty-four-year old mother and child, Biafra, Nigeria, 1969 - Photo by Don McCullin Contact Press Images.
Don McCULLIN, Twenty-four-year old mother and child, Biafra, Nigeria, 1969 - Photo by Don McCullin Contact Press Images.
Come scrive sempre sul Guardian Helene De Jode nell’articolo che ha suscitato la replica di Jones dando l’avvio al dibattito, le fotografie falliscono nel mostrare le cause di ciò che fanno vedere. Non che sia questo il compito specifico delle arti visive e della fotografia, ma è un problema che dovremmo senz’altro iniziare a porci. Ci sono fotografi, talvolta loro stessi giornalisti, che hanno iniziato una critica dall’interno delle pratiche e dei meccanismi del reportage, infrangendo le regole che lo caratterizzano per tentare di formulare un modo alternativo di guardare lo stesso problema, di offrire un punto di vista diverso che colga qualche aspetto in più di realtà molto complesse. Immagini più riflessive, spesso articolate in discorsi più ampi, che si avvalgono di altre fonti di informazione, frutto di progetti estesi nel tempo.
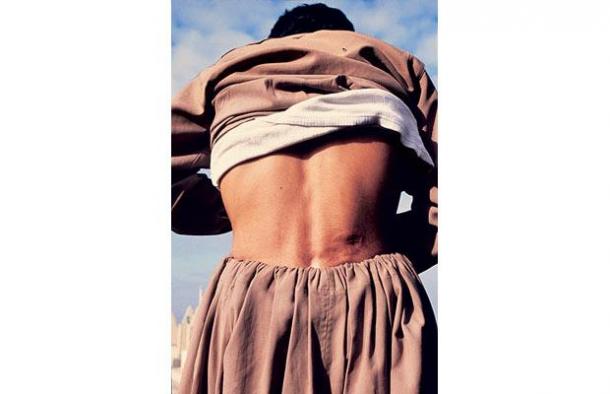 Susan Meiselas, Arbil Taymour Abdullah, 15, the only survivor of mass execution, shows his wound, Kurdistan, Northern Iraq, December 1991
Susan Meiselas, Arbil Taymour Abdullah, 15, the only survivor of mass execution, shows his wound, Kurdistan, Northern Iraq, December 1991
Se pensiamo anche a quanti eventi capitali degli ultimi anni hanno avuto le loro immagini simbolo realizzate non da professionisti ma da amatori, da gente comune o da telecamere di sorveglianza – dall’11 Settembre ad Abu Ghraib, all’uccisione di Neda – ci rendiamo conto che non si tratta affatto di ipotizzare provocatoriamente una rinuncia alla copertura mediatica, ma appunto di un invito a ripensarla criticamente. Molti fotogiornalisti in passato sono stati mossi da ideali alti e sinceri, dalla consapevolezza di poter creare immagini in grado di mostrare cose e fatti inediti e sorprendenti, capaci di colpire i lettori e scatenare forti reazioni. È stata una fase storico-culturale indubbiamente necessaria, che in decenni passati ha consentito una conoscenza del mondo radicalmente nuova, anche se ambigua. Ma la nostra aspirazione odierna a una società e un mondo migliori dovrebbe prendere le mosse da un grado di conoscenza superiore, passando imprescindibilmente da una più libera e capillare trasmissione delle notizie e da una maggiore e più approfondita diffusione del sapere. Quei lettori che chiamarono il New York Times per chiedere della bambina della fotografia si erano appassionati superficialmente a quell’episodio perché aveva creato uno stato di suspence di tipo cinematografico, ma non ebbero il minimo pensiero per tutti gli altri bambini che fuori dall’inquadratura versavano nelle medesime drammatiche condizioni (e questo svela la profonda ipocrisia delle accuse che furono mosse al fotografo).
 Till Roeskens, Fotogramma da Videocartographies, Aida, Palestine, 2009
Till Roeskens, Fotogramma da Videocartographies, Aida, Palestine, 2009
Crediamo che per tenere viva la coscienza civile delle persone siano necessarie a tutti i costi fotografie che ci diano un pugno nello stomaco, che ci provochino un’emozione forte, che ci facciano piangere? Non riteniamo di avere piuttosto bisogno di fotografie (oltre che di testi e di qualunque altro mezzo) che ci permettano di riflettere in modo più profondo sul reticolo di cause e conseguenze dei fenomeni? O non possiamo fare a meno di continuare a toccare con lo sguardo la sofferenza degli altri, pretendendo che ci sia sempre qualcuno a subirla in prima persona e qualcun altro a metterla in immagine per noi?
 Zarina Bhimiji, Memories are trapped inside the asphalt, 1998-2003
Zarina Bhimiji, Memories are trapped inside the asphalt, 1998-2003









